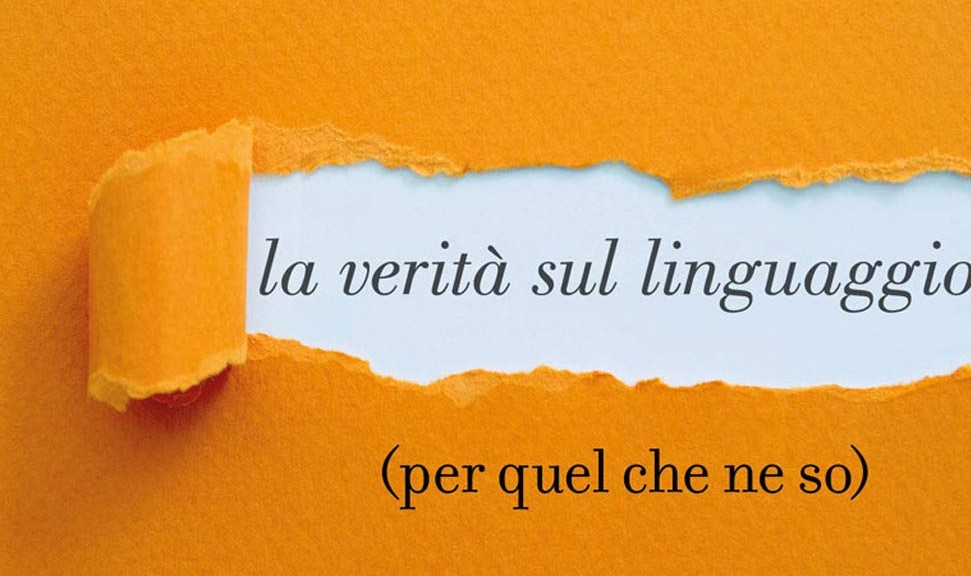Sono due le vicende che spesso si incontrano quando della facoltà del linguaggio si desideri approfondire gli aspetti evolutivi e cognitivi. La prima riguarda quando e come i bambini imparano a parlare e soprattutto su quale base mentale questo fatto succeda.
Da molti decenni, dalla nascita delle grandi teorie sull’acquisizione del linguaggio del secondo Dopoguerra, molti studiosi di diverse prospettive e punti di vista hanno cercato di dare una spiegazione al fenomeno detto della «povertà dello stimolo», un accadimento secondo il quale a un certo punto il bambino si mette improvvisamente a produrre frasi complesse senza che nessuno gliene abbia mai spiegato il funzionamento e anzi spesso senza che il piccolo parlante le abbia mai sentite. Cosa che stupisce lo studioso ma anche il milieu famigliare, che trova tutto ciò fonte di buonumore e di buoni auspici per il proprio ultimo nato.
Un secondo grande tema della linguistica cognitiva riguarda le specificità della facoltà del linguaggio presso gli umani. Per semplificare, anche qui: perché l’uomo parla e gli altri animali no. O meglio, perché l’essere umano è dotato di una capacità così raffinata di comunicazione pur presentando il mondo animale attrezzature in alcuni casi molti simili (le scimmie antropomorfe ci assomigliano molto, come dice la parola) e quindi potenzialmente abilitate alla parola.
Ragionamenti originali a proposito di questi due argomenti sono ora in due libri di pregio appena stampati dall’editore Carocci: Il cervello sintattico dello psicobiologo Marco Tettamanti e La verità sul linguaggio del già numerose volte sorprendente psicologo Michael Corballis.
Il primo dei due è molto affascinante nella trattazione delle localizzazioni cerebrali di molti aspetti del linguaggio, e cioè di quale parte del cervello si occupa delle parole, quale delle frasi, quale dei suoni, che sezione è delegata alla produzione e quale alla comprensione: oggi, con le tomografie e le risonanze magnetiche si può vedere gran parte di tutto ciò, negli adulti e nei bambini. Questi ultimi stupiranno per le capacità eminentemente linguistiche sviluppate già nelle prime ore di vita, per il fatto che i giovani parlanti cominciano a capire le frasi con «sintassi gerarchica complessa» solo a 8-9 anni (quando già vanno a scuola da un po’), per molte e molte altre brave cose.
Il raffronto tra linguaggio umano e linguaggio degli animali è un portento per i contenuti; perché è uno spasso osservare come parliamo bene noi e come (non) parlano primati, cetacei, uccelli, insetti, batteri; quanto siano imperfette le pur accreditate forme di comunicazione dei corvi della Nuova Caledonia, della cinciallegra giapponese, dei tamarini a chioma di cotone, degli stornelli europei.
Dalle scimmie che più ci somigliano ci siamo separati circa sei milioni di anni fa. Secondo alcuni «un lasso di tempo sufficiente per l’evoluzione graduale delle abilità sintattiche più complesse che caratterizzano il linguaggio umano»; secondo altri no: lo iato tra la nostra lingua naturale e quei pochi e poco articolati versi delle scimmie non può che essere stato determinato da un improvviso episodio, traumatico e rivoluzionario.
A maggior ragione perché riferibile a un periodo non sospetto, ha così un fascino straordinariamente attuale un articolo del 2004 dei cognitivisti Massimo Piattelli Palmarini e Juan Uriagereka che, dopo essersi chiesti quale «singolo evento catastrofico» abbia potuto procurare all’uomo la facoltà del linguaggio e ricercatolo nella biologia, ipotizzano e cercano di dimostrare che il salto evolutivo decisivo possa essere stato causato da un’infezione virale o batterica. Questa, «introducendo modifiche genetiche o epigenetiche nella specie umana o nei suoi antenati più prossimi, avrebbe permesso lo sviluppo di un cervello più grande, con per l’appunto facoltà linguistiche».
Ora, nessuno all’epoca avrà avuto gli strumenti per affermazioni correnti in questo periodo, del tipo «niente sarà più come prima»; anche se magari, visto il futuro che si preparava, sarebbe stato molto difficile convincerlo del contrario.
Bibliografia
Michael C. Corballis, La verità sul linguaggio (per quel che ne so), Roma, Carocci editore, 2020
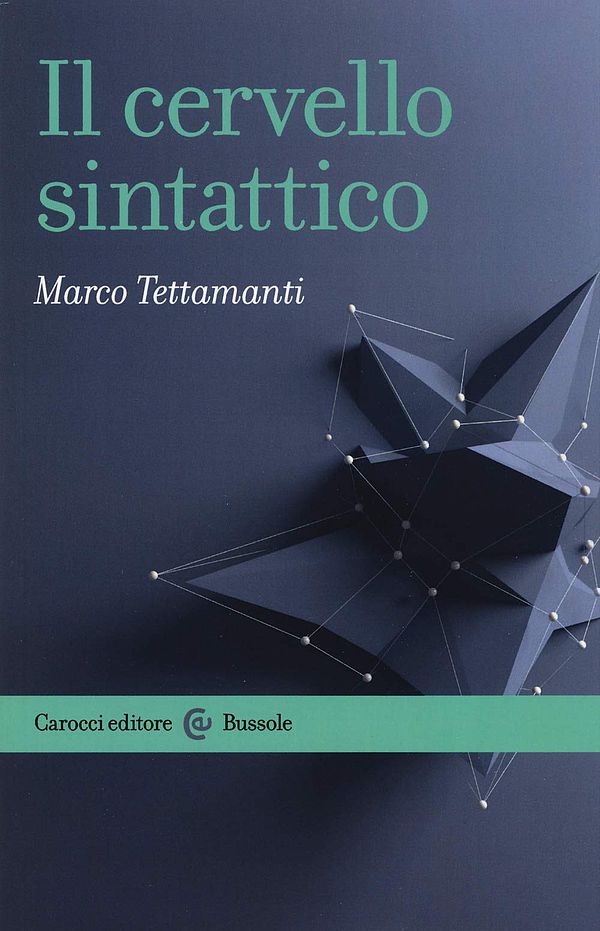
Bibliografia
Marco Tettamanti, Il cervello sintattico, Roma, Carocci editore, 2020.
Il virus della parola
Lo sviluppo del linguaggio nei bambini e lo sviluppo della competenza linguistica nell’evoluzione dell’uomo, in due recenti pubblicazioni
/ 15.06.2020
di Stefano Vassere
di Stefano Vassere