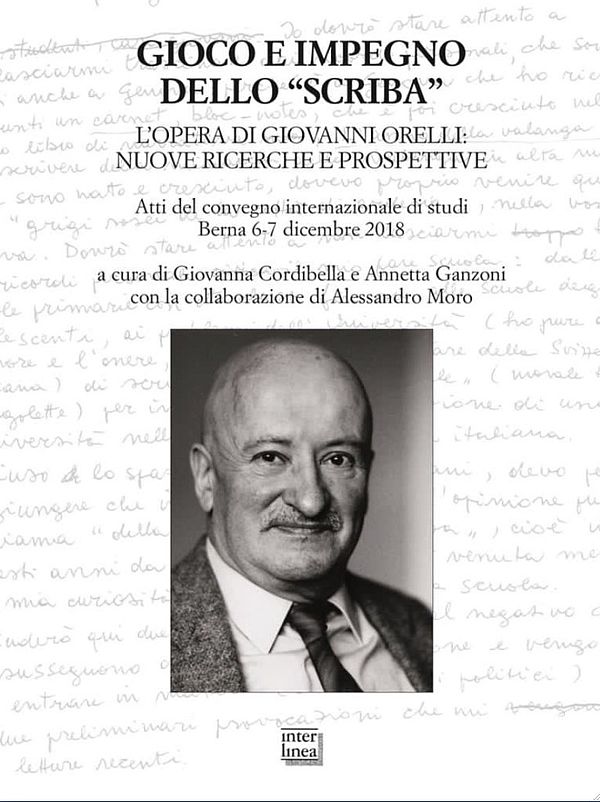«A pochi giorni dalla scomparsa di Giovanni Orelli, il 12 dicembre 2016 la prima pagina del settimanale “Azione” ricordava colui che per quarant’anni ne era stato il critico letterario più assiduo e prestigioso: un’immagine sorridente dello scrittore, contornato dai libri del suo studio, e un breve saluto (“Professore, grazie”) a celebrare una fedeltà che ha pochi eguali nella cultura letteraria di lingua italiana».
Sono le prime parole di un testo di Pietro Montorfani che descrive la lunga collaborazione di Giovanni Orelli a questo settimanale, quantificabile in quasi mille articoli e più di duemila libri recensiti. L’attività pubblica e giornalistica rappresenta uno dei numerosi punti di vista forniti da questo generoso Gioco e impegno dello «scriba». L’opera di Giovanni Orelli: nuove ricerche e prospettive, che trascrive due giornate di riflessione tenutesi tre anni fa nell’edificio storico della Biblioteca nazionale svizzera. Frutto dell’intesa tra l’Università di Berna e l’Archivio svizzero di letteratura, che della Biblioteca nazionale è settore importante, il convegno e il libro accolgono più di venticinque contributi disposti in quattro sezioni dedicate alla letteratura di Orelli, alle traduzioni, a omaggi di amici e colleghi, a uno scrupoloso inventario di una settantina di pagine delle collaborazioni giornalistiche.
Si potrebbe dire che la serie di voci di questa raccolta configura una prima complessiva sede di ragionamento sull’opera e sulle opere di Orelli. E certo non si sbaglierebbe, a patto però di prendere in considerazione anche un’altra significativa uscita, e cioè il grosso volume della rivista «Il Cantonetto» stampato in quello stesso 2018 con titolo d’occasione Un insonne della letteratura. Compagni di via in memoria di Giovanni Orelli (qui citato a pagina 219).
In questo Gioco e impegno dello «scriba», la strada degli interventi pubblici è una delle non poche novità nell’indagine sullo scrittore. In questo senso, il fondo d’archivio di Orelli anticipa tra l’altro direzioni ancora ampiamente tracciabili, che emergono qua e là nel volume: per esempio dalle occasioni fornite da una conferenza tenuta alla fine degli anni Novanta alla Buchmesse di Francoforte su letteratura ed editoria nella Svizzera italiana; o dalle osservazioni sulle tensioni di quell’«angolo di terra, triangolo, cuneo di Svizzera che si inserisce in Lombardia» eppure «frammento di Lombardia andato poi ad agglutinarsi alla Svizzera» (siamo nel 1988, alle Giornate letterarie di Soletta). Ancora, un testo di Daniele Cuffaro ricorda di Orelli la promozione «morale» del progetto universitario ticinese, che, in mezzo a quelle finanziarie e di stretta politica locale, prese la forma di una sacrosanta sezione del «rapporto» al Parlamento cantonale (il numero 4308) in un ormai lontanissimo agosto del 1995.
Gli atti portano ovviamente e con scansione sistematica capitoli dedicati alle singole prove letterarie, e atteggiamenti di lettura che altrettanto naturalmente finiscono per toccarne gran parte. Così torna spesso il celebre programma-destino nelle parole dell’Anno della valanga: «giura: non scrivere mai patetiche elegie sul tuo paese che verrà deturpato». Ma, a un livello più attento, chi legge potrà apprezzare, ordinato nel contributo di Massimo Migliorati sul Treno delle italiane, l’elenco degli spunti narrativi principali e la loro distribuzione nei vari romanzi: sono nuclei tematici come la discussione in un bar, il sogno, la vendita delle castagne, la ferrovia, la neve, le donne emigrate, la relazione tra padri e figli.
È abitudine di chi sia invitato a rendere conto di rassegne di questa inusuale dimensione invocare, quasi a dare l’impressione di una scappatoia, l’abbondanza degli argomenti e la conseguente impossibilità pratica di richiamarli tutti. È dunque certamente parziale ma anche un po’ risolutivo il rinvio sommario a qualche elemento di novità: l’analisi delle schede elaborate da Orelli nel contesto della giuria del Premio Bagutta curata da Paolo Di Stefano; lo studio di Giovanna Cordibella sulla stesura di radiodrammi e sul rapporto con la radiotelevisione; temi minori ma così insistentemente manifestati nelle varie modalità comunicative come quello esemplare dei nomi di luogo («Un segreto/hanno i nomi di luogo e quelli che per primi il nome han detto»); la lettura filologica, con la quale Rossana Dedola descrive le varianti successive dell’incipit del Sogno di Walacek.
Nel quadro della resa disciplinata dei documenti d’archivio inediti rientra in questo libro la restituzione da parte di Fabio Soldini, con tutti i ferri del mestiere («Dattiloscritto di 12 facciate (numerate le pp. 2-12) su fogli bianchi di formato A4, senza titolo né data…»), della conferenza di Vittorio Sereni alla presentazione dell’Anno della valanga, il 29 marzo 1966. Fu «affollata serata pubblica al Liceo di Lugano, come riferirono i quotidiani ticinesi», e «alla fine l’autore intervenne a ringraziare e poi a firmare le copie del libro». Dirà Sereni in conclusione e prima degli applausi che «libri come questi arrivano un po’ come una sorpresa», soprattutto perché inquadrano una situazione circoscritta, «la propria visione del mondo», risuonando nello stile l’attività della scrittura e le sue necessità.
Si è detto dell’imbarazzo nel dovere trascegliere tra temi e piste e della volontà di raccoglierne qualcuno che scarti in un qualche modo dai modi canonici con i quali di Giovanni Orelli si è parlato nei decenni, indicando materie dove sarebbe utile ricercare ancora. Tra queste ultime, due sono dichiarate nel titolo e nella prima pagina dell’introduzione a questi atti: da una parte la «razionale opposizione politica» che informa l’agire nel Paese e dall’altra i punti fermi del gioco e dell’ironia nella produzione letteraria (e forse non solo).
Infine, ai molti che abbiano avuto il privilegio di conoscere Giovanni Orelli, questo libro conferma in numerose pagine due abilità essenziali, che ne arricchirono la produzione e la vita: la formidabile memoria e la capacità di governare un registro linguistico e testuale nel quale, a fronte della continua apertura di finestre tematiche di contorno, ascoltatori e lettori sono con periodicità riportati verso un confortante filo del discorso, recuperato per loro da chi parla o scrive. Una disposizione comunicativa che rivela insomma, tra le molte virtù di Giovanni, un sapiente, civile e vigile rispetto del prossimo.