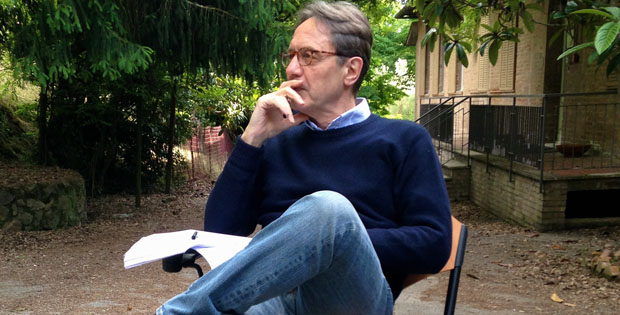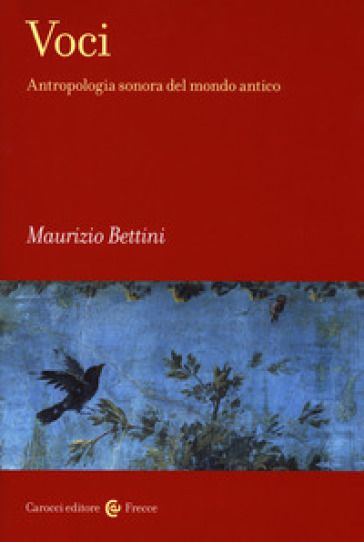«Allora la sua voce, più potente d’ogni filtro nell’evocare gli dèi inferi, emise dapprima suoni confusi discordi e molto dissonanti dalla lingua degli uomini: vi si udivano latrati di cani e gemiti di lupi, e il lamento che emettono il trepido gufo e il notturno barbagianni, strida e ululati di fiere, sibili di serpenti».
C’è un universo sonoro, una fonosfera, in cui siamo immersi ogni giorno: sono i rumori della nostra quotidianità, dei quali, ad averne la determinazione, potremmo allestire un repertorio: motori di auto, strisciare di pneumatici sul bagnato, foni e fonemi umani, rumore di telefoni e di stampanti, molto e molto altro. Manca, in questo inventario, una serie di rumori che doveva risultare molto differente dalla nostra, quella che accompagnava gli antichi: i rumori naturali cui l’uomo concedeva sicuramente maggiori dimestichezza e confidenza e le sonorità perdute dell’artigianato preindustriale: che rumore facevano un mulino, un maglio, l’officina di un maniscalco?
È un libro semplicemente molto bello, questo Voci. Antropologia sonora del mondo antico di Maurizio Bettini. Ridotto a pochi e forse non abbastanza generosi termini, il punto di partenza consiste nel rileggere i classici latini e greci e le loro descrizioni dell’universo sonoro, su tutti i canti e i versi degli animali. Le emissioni del genere animale sono, in lungo e in largo, spunti per tante strade che tengono conto di e ci immergono in una serie mirabolante di prospettive scientifiche, di citazioni, di rinvii.
C’è tra l’altro una zoosemiotica, che studia e ci spiega la modulazione delle vocalità degli uccelli, che sono trasmesse per genetica e istinto ma solo in parte: si dice che abbiano, certi uccelli, dei veri e propri dialetti, a seconda dei tempi e dei luoghi. Ma è tutto semiotico anche lo studio dei nomi stessi dei versi. L’imperatore Antonino Geta estenuava i grammatici di corte con domande sul loro nome: «le colombe minurriunt, gli orsi saeviunt, i leoni rugiunt, gli elefanti barriunt, le rane coaxant». Bettini ci fa notare che solo gli uccelli cantano e sono così avvicinabili agli uomini in questa attività «più bella che necessaria»; gli altri fanno versi e ci sono lontani (ma le balene, con il loro canto?).
Apre a grazie indicibili per il lettore la lunga e attrezzata analisi della costruzione dei verbi che descrivono le emissioni animali e di come si fa a formare parole come belare, muggire, cuculare, titiare ecc. La prima idea è ovviamente l’onomatopea, con le r che ricorrono di più per alcune specie e le s per altre; ma ulteriori formazioni discendono da più complesse icone sonore, altri nomi di versi richiamano altro materiale, «come l’orso che “incrudelisce”, saevit». Ci sono nomi che raccontano storie: la civetta fa tuttomio tuttomio, è egoista e vuole tutto per sé; il merlo siciliano fa le coccole ai suoi piccoli con il suo picciridduzzu. Altri uccelli vanno gridando in giro il proprio stesso nome; il corvo, che la mitologia ha condannato ad avere sete, riproduce lo stillicidio dell’acqua; il raglio che si leva dall’asino è sgradevole, potente e misterioso.
Questo è un libro-mondo; basti dire che il testo finisce dopo duecento pagine ma poi ce ne sono altre cento di note e apparati, che rendono testimonianza di un metodo e di un travaglio tanto immani quanto ben nascosti sotto uno stile scientifico esemplare e leggero. Se si vuole si va a vedere quali sono le fonti che ci dicono che il merlo romano «balbettava» o si cerca di leggere la versione in greco della prima lettera ai Corinzi di San Paolo con la glossolalia dei primi cristiani. Se non si vuole ci si ferma, appunto, alla pace testuale di un libro che non dimenticheremo.
«Nei luoghi selvaggi i merli balbettano la loro cantilena infantile, nelle arcane solitudini gli usignoli lanciano a piena voce il canto dell’adolescenza, presso fiumi reconditi i cigni ripetono l’inno della vecchiaia».