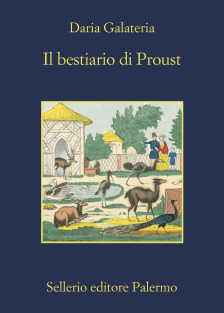Se agli happy few che hanno letto da cima a fondo i sette volumi della Recherche si chiedesse all’improvviso di elencare senza indugio alcune delle immagini che più efficacemente illustrano i rapporti di Proust con le forme e i colori della natura, penso che quasi tutti menzionerebbero i biancospini che nel mese di Maria adornano l’altare di sant’Ilario, a Combray; i lillà che levano i loro pennacchi al di sopra del muro di cinta della tenuta di Swann; le ondulanti ninfee della Vivonne; gli asparagi mondati da Françoise e dipinti da Elstir; le cattleye che nel linguaggio segreto di Swann e Odette («faire cattleya») alludono metaforicamente al rapporto sessuale. Elencherebbero, insomma, delle immagini riguardanti il regno vegetale.
Ma in alcuni di loro, forse, il ricordo delle cattleye applicate ai capelli e lungo le scollature degli abiti di Odette richiamerebbe all’istante un’altra orchidea: quella che attende di essere fecondata dal calabrone attentamente osservato dal narratore nel cortile del palazzo dei duchi di Guermantes, dove avviene l’incontro, seguito poco dopo da un non visto ma rumoroso (e necessariamente infecondo) rapporto carnale tra il barone di Charlus e l’ex farsettaio Jupien.
Il calabrone che compare all’inizio di Sodoma e Gomorra (la cui prima parte è anche un piccolo saggio sull’omosessualità) è uno dei molti animali presenti – come figure reali o metaforiche – nel complesso e variegato mondo della Recherche: «un’arca di Noè, in cui Proust ha messo in salvo, a centinaia, i suoi animali perduti». Così si legge in apertura del saggio Il bestiario di Proust, opera recente della francesista Daria Galateria, la quale aggiunge: «Di un centinaio, scelti quasi a caso, si prova qui a riassumere come entrano in scena – tra lettere, poesie, novelle, fogli persi, quaderni preparatori, romanzi – e poi cosa diventano, e in che ruoli recitano».
Il saggio è diviso in due parti. La prima è una sequenza di brevi capitoli a tema (Arca di Noè, Contro la caccia, Sadismi, Contro lo zoo, Animali che fanno ribrezzo, Animali parricidi, Amori sterili, ecc.), la seconda una sorta di dizionario formato da 115 schede che trattano di altrettanti animali. Del calabrone sopra menzionato, ad esempio, si parla alla voce «Calabrone» e alla voce «Insetto», dove ritroviamo un imenottero già incontrato nel capitolo intitolato Bestie come me («Proust spesso, per parlare di sé in modo profondo, lo fa identificandosi con animali»), nel quale Galateria riporta il passo di una lettera a Gaston Gallimard in cui lo scrittore, citando Fabre e Mečnikov, si paragona alla vespa scarificatrice. «Ma è in Michelet» aggiunge Galateria «che Proust ha raccolto l’dea (falsa) che la morte attende la vespa subito dopo aver predisposto il cibo per la sua discendenza – per lo scrittore, il cibo spirituale per i lettori del futuro.»
Se, all’inizio della Recherche, l’io narrante (che non corrisponde esattamente a Marcel Proust) si identifica con una rondine di mare, e in Sodoma e Gomorra con un gufo, in una lettera all’amico Robert Dreyfus, Proust si paragona a un baco da seta. È invece un poney in alcune lettere indirizzate all’amante Reynaldo Hahn, che lo aveva così soprannominato, mentre in una poesiola, destinata anch’essa a Reynaldo, diventa «il tuo bassotto miserando / che non può seguirti come un cane vero».
Il tema dell’identificazione è tra i più fortemente e significativamente aggreganti nel saggio di Galateria sul bestiario proustiano. Lo è al pari di altri due: l’omosessualità, di cui ho già detto, coi suoi rapporti sessuali sterili, e il sadismo, che ha la sua esemplificazione più impressionante in uno dei cinque capitoli intitolati Amori parricidi, nel quale si racconta un sogno del narratore che adombra ciò che Galateria chiama «la leggenda “nera” di Proust», e che secondo il grande biografo David G. Painter è una realtà attendibilmente testimoniata: e cioè che Proust, nel 1917-19, fece portare più volte dei topi nel bordello per omosessuali di Alfred Le Cuziat (nella Recherche è diventato Jupien), dove raggiungeva l’orgasmo guardando alcuni giovani opportunamente ammaestrati che li trafiggevano con degli spilloni o li uccidevano a bastonate: topi che rappresentavano molte cose, ma soprattutto i genitori e la loro riprovazione per l’omosessualità del figlio.
Ma quale fosse il sentimento profondo di Proust davanti alle manifestazioni di crudeltà nei confronti degli animali, lo apprendiamo (oltre che dalla sua avversione per la caccia e gli zoo) dalle parole che in Jean Santeuil commentano i gesti e le esclamazioni crudeli con cui la domestica Ernestine (che nella Recherche diventerà Françoise) uccide un pollo destinato ad essere magistralmente cucinato: «Tolleriamo l’agonia di pecore, polli e buoi senza pensarci, perché necessaria al nostro piacere; e non sono le uniche vittime incolpevoli che lasciamo sacrificare ogni giorno».