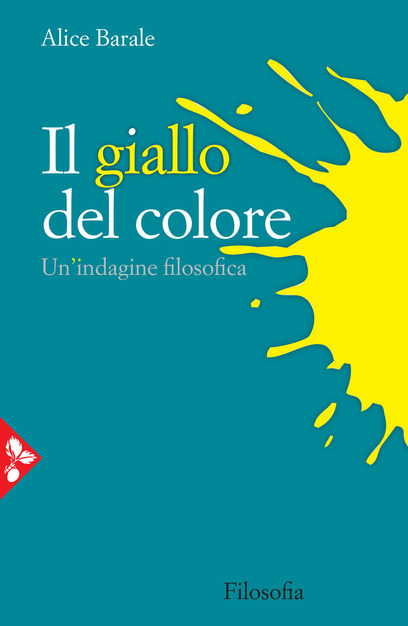Il colore è fuggevole, inafferrabile, mutevole; eppure ne abbiamo ogni giorno esperienza diretta attraverso i nostri sensi, in altre parole vediamo (e sentiamo) il mondo a colori. Ma ci sono ancora poche certezze su che cosa sia davvero il colore; nei secoli è stato definito come materia (l’etimologia della parola «colore» in molte lingue indoeuropee rimanda a termini quali «pelle» o «rivestimento»), in seguito come luce (è stato Aristotele a proporre la più antica scala cromatica, rimasta in auge fino a quella di Newton) e infine come sensazione e quindi decodificato attraverso la memoria, l’immaginazione e le conoscenze.
Nel corso dei secoli si sono susseguite nuove ipotesi e tesi, ora esposte dalla studiosa di estetica Alice Barale nel suo Il giallo del colore, un saggio che fa il punto sul dibattito in corso, intrecciando filosofia e linguistica, neuroscienze e storia dell’arte.
A dominare negli ultimi decenni è l’«eliminativismo», una teoria che sostiene la pura illusorietà dei colori e nega che siano proprietà degli oggetti reali; una diffidenza, annota Barale, che risale all’antichità, al padre dell’atomismo, il filosofo greco Democrito. Agli albori della scienza moderna Galileo intuisce che i colori non sono «altro che puri nomi», ponendo il problema fra esperienza percettiva e la manifestazione fenomenica. Ma al di là delle caratteristiche fisiologiche, fisiche e chimiche attribuibili a ogni colore, esisterebbe anche un significato simbolico e spirituale. O almeno è ciò che pensava Goethe; per lui il giallo «possiede una qualità dolcemente stimolante, di serenità e gaiezza».
Ma l’esistenza di un’essenza immutabile dei colori è una concezione agli antipodi di quella sostenuta dallo storico francese Michel Pastoureau, che considera i colori come «astrazioni» la cui origine è legata alla cultura e alle convenzioni. Lo studioso di araldica è autore di una storia dei colori nelle società europee, giunta al quinto volume (Giallo. Storia di un colore, Ponte alle Grazie, 2019). Giallo che gode di un certo prestigio nell’antichità, perché associato spesso all’oro, ma anche al colore del grano e soprattutto al sole, nella mitologia greco-romana e dell’antico Egitto.
Ma dal Medioevo diventa sinonimo di tradimento, «forse perché è difficile renderlo vivido nella pittura come nella natura»; è l’inizio di una cattiva reputazione, quella di colore equivoco e ambivalente che durerà secoli. La duplicità del giallo è già attestata negli stemmi cavallereschi; il giallo, si legge nei testi d’araldi d’armi, significa sì «forza e ricchezza ben temperata; ma più spesso è un colore cattivo, nel qual caso significa invidia e avidità, menzogna e falsità». Ecco spiegata allora la veste gialla con cui i pittori come Giotto raffigurano Giuda.
Al giallo e al rosso dichiarerà guerra la Riforma protestante, portatrice di un’austerità che considera questi colori troppo vivaci e disonesti. Ecco spiegate le atmosfere cupe di un Rembrandt rispetto ai colori squillanti di un cattolico Rubens, osserva Pastoureau. Sempre in ambito olandese si ricordano i gialli di Vermeer e di pittori coevi, autori di interni domestici dove si intravedono stoffe e arredi sempre più tinti di giallo ad attestarne la diffusione nella vita quotidiana. Nel frattempo si erano fatti grandi progressi nelle tecniche pittoriche, con la scoperta di nuovi pigmenti e colorazioni; nel Seicento si moltiplicano i manuali destinati ai pittori; nel 1692 un certo Anders Boogert compila un eccezionale campionario di oltre cinquemila sfumature di colori, in cui verde e giallo appaiono trascurati rispetto a rosso e blu.
Il giallo si riprenderà la rivincita in epoche più recenti; in particolare a partire dal XIX secolo, già con i cieli di Turner, ma anche e soprattutto con la «febbre colorista» di Gauguin e Van Gogh («Il sole mi abbaglia e mi dà alla testa, un sole, un chiarore che posso solo definire giallo, giallo zolfo, giallo limone, giallo oro. È così bello, il giallo!»). A favore del giallo aveva giocato la rivoluzione della pittura en plein air, con gli impressionisti che avevano trovato un nuovo rapporto con la luce e adottato le più recenti teorie. Ma molti pittori, come Seurat, restano vittime della scienza, abusando della teoria sulla mescolanza ottica dei toni del chimico Eugène Chevreul, in base al quale basta accostare un blu e un giallo perché l’occhio legga il «verde».
Il grande ritorno del giallo in pittura è decretato dall’avvento dei Fauves che rivendicano «l’arbitraria poetica della tinta». Anche se proprio in quegli anni Kandinskij non nasconde la sua avversione per il giallo, colore, scrive, che «genera apprensione nello spettatore… e dimostra il carattere della violenza che si esprime nel colore». Non tutti i gialli del resto sono allegri o tonificanti; basti pensare alla sensazione di solitudine che emana dalla giovane donna dal cappello giallo seduta nella tavola calda dipinta da Edward Hopper.
Emblematico infine l’esempio di Velasco Vitali – citato da Barale – che nella sua monumentale Veduta, un dipinto del 2019, inserisce una macchia gialla fra le montagne. «È il mio autoritratto», dichiara in un’intervista il pittore. Colore coscienza dunque, o autocoscienza, che rappresenta il «sentire di sentire». Un accorgersi di esistere.