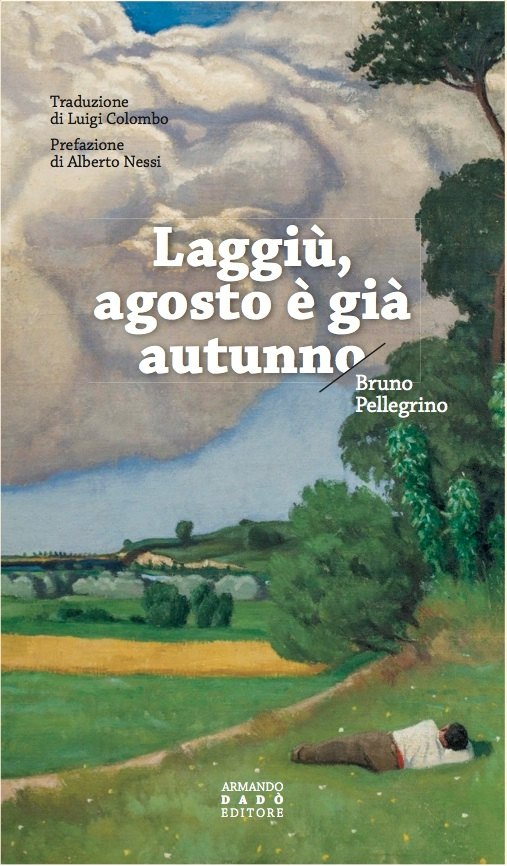Gustave oggi pranzerà da solo. Sua sorella Madeleine, prima di uscire, gli ha però lasciato tutto pronto, con un biglietto che riporta le istruzioni per cuocere le patate. Gustave nota che, «con un alessandrino in cui la cesura cade correttamente a metà», Madeleine ha aggiunto che può prendere tre uova se gliene lascia due.
Basterebbe questo frammento di piccola quotidianità domestica per cogliere la bellezza del rapporto tra il poeta Gustave Roud (1897-1976) e sua sorella Madeleine, le cui vite sono state raccontate dallo scrittore losannese Bruno Pellegrino in un romanzo giustamente celebrato, e ora disponibile anche in italiano grazie all’eccellente traduzione di Luigi Colombo, con la prefazione di Alberto Nessi.
L’autore, che convince soprattutto nelle strategie adottate per rendere opaco il rapporto tra verità storica e manipolazione letteraria, segue i due fratelli per un decennio, dal 1962 al 1972, mettendone in evidenza la comunanza dei tratti, benché declinati nelle diverse sensibilità dei caratteri. A partire dal loro modo di relazionarsi allo spazio, in particolare alla casa, nella quale i due giungono da adolescenti e trascorreranno insieme tutta la loro esistenza.
Una casa e un giardino di cui Madeleine si occuperà alacremente e in cui sarà ambientato il film dedicato a Gustave. Uno spazio progressivamente investito dai lutti (la madre, le zie) e che non vedrà nascere (più) nessuno; ma aperto al Mondo soprattutto grazie alle amatissime piante (anche) esotiche che giungono ai due fratelli: le orchidee da Singapore, le mimose e viole di Nizza. Alla scarsità dei toponimi fa infatti da contraltare la precisione della nomenclatura botanica, tanto che si può dire che il romanzo sia costruito su una geografia delle piante, più che dei luoghi.
Sulla casa soffia il vento della Storia, che vi entra attraverso le notizie che Madeleine assiduamente legge sul giornale (da Valentina Tereškova, prima donna nello spazio, all’assassinio di Kennedy) e che si mescola alle vicende dei protagonisti. A sottolineare la complementarità tra i due fratelli concorre proprio la dialettica tra vicino e lontano. Madeleine si muove in uno spazio limitato (la casa, le brevi incursioni in città) e giunge solo con la mente a quello (infinitamente) distante (l’interesse per le missioni spaziali); mentre Gustave occupa una spazialità più ampia (i viaggi in Italia della sua giovinezza), ma si concentra ossessivamente sul dettaglio (un germoglio appena spuntato).
I due fratelli trovano un altro punto di contatto nell’estraneità a qualunque posa e nella capacità di leggere il Mondo attraverso quello sguardo che sa riconoscere i legami intimi tra le cose, fissandole nel tempo eterno della memoria dell’uomo. Gustave lo mostra nella sua solitudine di poeta lontanissimo dal mondo delle lettere e nella sua programmatica fede a una poetica «rasoterra», per dirla proprio con Alberto Nessi. Pellegrino insiste, piuttosto, sulla materialità dell’atto della scrittura: la fatica, le procrastinazioni, ma anche l’attenzione con cui il poeta guarda ai supporti e agli strumenti, come l’inchiostro che si allarga tra le fibre della carta o la decomposizione della copertina in pelle di un libro. Ma anche per Madeleine, sin dall’adolescenza, «tradurre le Metamorfosi di Ovidio aveva senso solo se portava ad applicazioni pratiche, curare e guarire».
I due sono infatti guidati da un’etica che mi pare si concretizzi prima di tutto nell’infaticabile impegno con cui prendersi cura del Mondo, a cominciare dai piccoli gesti domestici e dalla capacità di accettare la vita assecondandone il fluire. Un’attitudine peraltro già iscritta nella doppia temporalità su cui sono costruiti i nove capitoli che compongono il romanzo: quella della ciclicità dei mesi che tornano e quella della linearità degli anni che passano. Alieno da ogni tentazione reazionaria, Gustave non osserva le stagioni e le piccole variazioni che esse portano per esorcizzare lo scorrere del tempo, ma perché è l’unico modo per accettarne l’ineluttabilità. Anche gli umanissimi rimpianti (le storie di cui Madeleine può solo leggere sul giornale; i corpi nudi degli uomini al lavoro ormai solo fotografati dal fratello) sono sublimati attraverso la loro riduzione alla bidimensionalità della carta (il giornale, la fotografia).
Un legame, quello tra Gustave e Madeleine, suggellato nel momento della morte della donna, quando i gesti rimasti incompiuti armoniosamente si ricompongono. Gustave pensa di sostituire la lapide con una fontana che capti l’acqua dalle profondità della faglia che Madeleine (pre)sentiva sotto di sé; Madeleine illumina e sblocca la scrittura di Gustave, di cui finalmente abbiamo anche qualche traccia effettiva. Ora al poeta Gustave Roud non resta che andarsene. E il Mondo, nel momento del trapasso, non può che essere riconoscente verso chi l’ha curato con tanta premura: in quella casa di campagna, ormai disabitata, è rimasta una luce accesa.