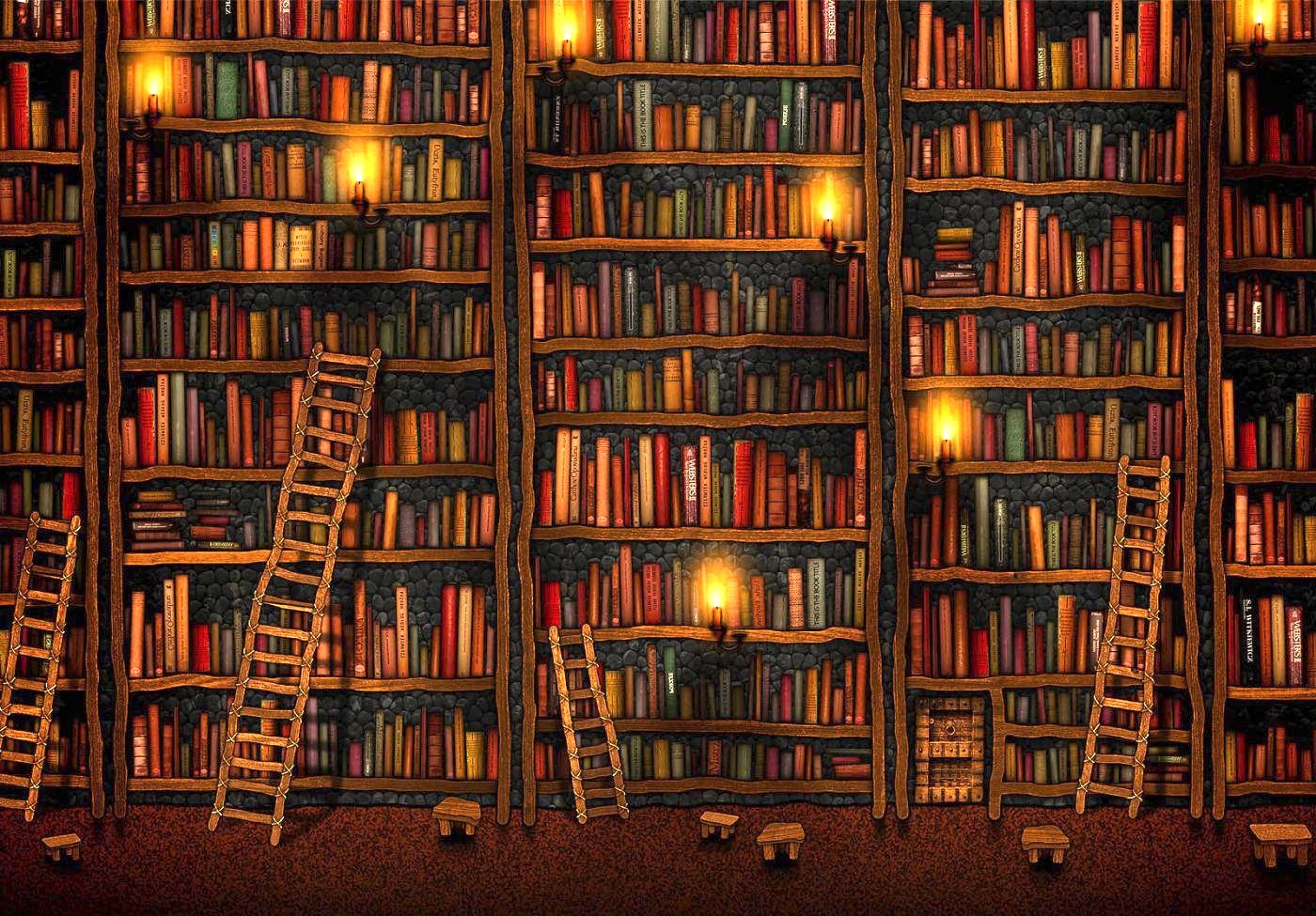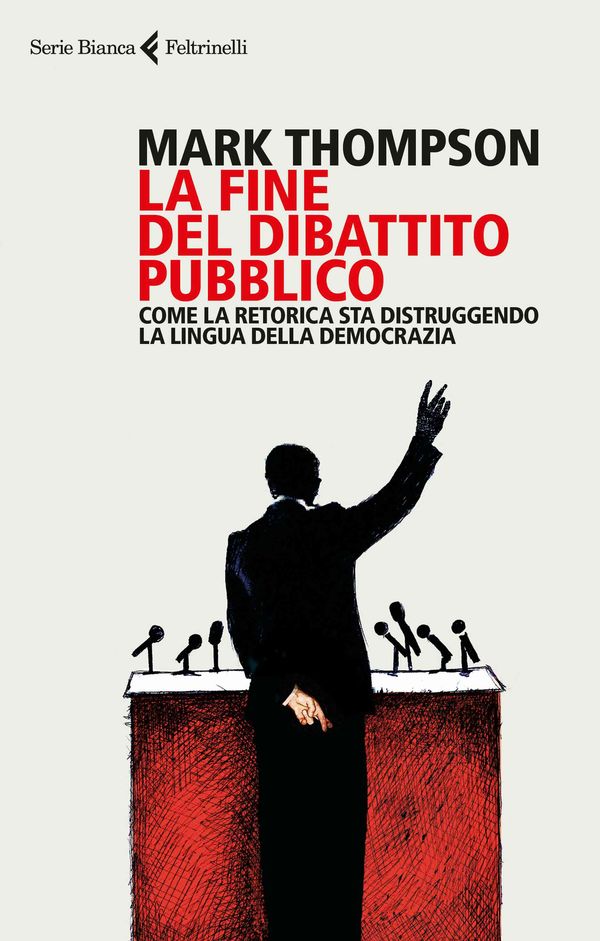Chevy Chase è un anziano sostenitore afro-americano di Bernie Sanders, che rappresenta l’ala sinistra del partito democratico. Chase, questo elettore del Maryland, disse all’inglese Mark Thompson che era improbabile che Sanders potesse ottenere la nomination democratica. Al che, il giornalista gli chiese: lei per chi voterebbe nel caso la scelta fosse tra la democratica Hillary Clinton e Donald Trump, rappresentante dell’ala destra e populista del partito repubblicano? Ecco la sua risposta: «Donald Trump sarà anche un pazzo, e forse anche un razzista, ma questo posso accettarlo. Almeno Trump dice quel che pensa. Invece se uno mente di continuo non sai più come porti».
Mark Thompson (oggi amministratore delegato del «New York Times» e già direttore generale della BBC) scopre che, per quanto non voglia esagerare il fenomeno, gli inviati dei giornali americani «hanno incontrato ovunque elettori con un’opinione del genere».
Il primo messaggio del libro di Mark Thompson è quindi il seguente: attraverso il mondo occidentale c’è una crisi di fiducia nei confronti della politica. Brexit e Trump rappresentano il trionfo di populismo e antipolitica sulla politica tradizionale. «Quando la fiducia nei politici è bassa», continua Thompson, «la presunta autenticità può essere più importante per alcuni cittadini di quasi tutto il resto, posizione politica, affiliazione ideologica, persino dei difetti caratteriali che in altre circostanze li azzopperebbero».
Il secondo messaggio di La fine del dibattito pubblico è che la crisi della politica tradizionale è alimentata «dall’erosione del linguaggio della sfera pubblica». Cosa significa tutto questo? Il riferimento è anche all’irruzione dei social media (Facebook, Twitter, eccetera) sulla scena dell’informazione. Che ha effetti dirompenti, propagando fake news (le bufale) con una rapidità impressionante.
Ed ecco come il primo problema (il trionfo del populismo) e il secondo (il velocissimo propagarsi delle bufale) sono connessi attraverso «la rabbia di internet»: «il linguaggio dell’odio sfrenato (spesso anonimo) scatenato dalle piattaforme digitali ha danneggiato il discorso pubblico. E impone un nuovo cupo standard all’espressione delle opinioni forti, che alcuni politici e commentatori sono ben lieti di adottare».
L’emergere di questa barbarie è tutta colpa dei social media e dei populisti? No. Come già detto, parte dei politici tradizionali si adatta a questo linguaggio barbaro. Altri sono passati alla storia come mentitori.
Per esempio, le «armi di distruzione di massa» di Saddam Hussein sono un’invenzione della politica tradizionale (Tony Blair e George W. Bush) che ha permesso l’invasione e la devastazione dell’Iraq. E, alla lunga, della Siria. Chi ha tentato di opporsi alla menzogna dei dossier governativi sull’Iraq, come il dottor Kelly, è morto suicida, «tritato fra le macine del sistema britannico».
I politici tradizionali sono quindi sia responsabili sia vittime di un sistema il cui linguaggio si sta imbarbarendo. Siamo alla fine della civiltà? Non è detto. La storia insegna che il linguaggio pubblico, in determinati momenti cruciali, come la guerra civile inglese, è già caduto e risorto dall’abisso della barbarie. Prima o poi, anche se non sappiamo come e quando, risorgerà un nuovo linguaggio della persuasione e della ragionevolezza.