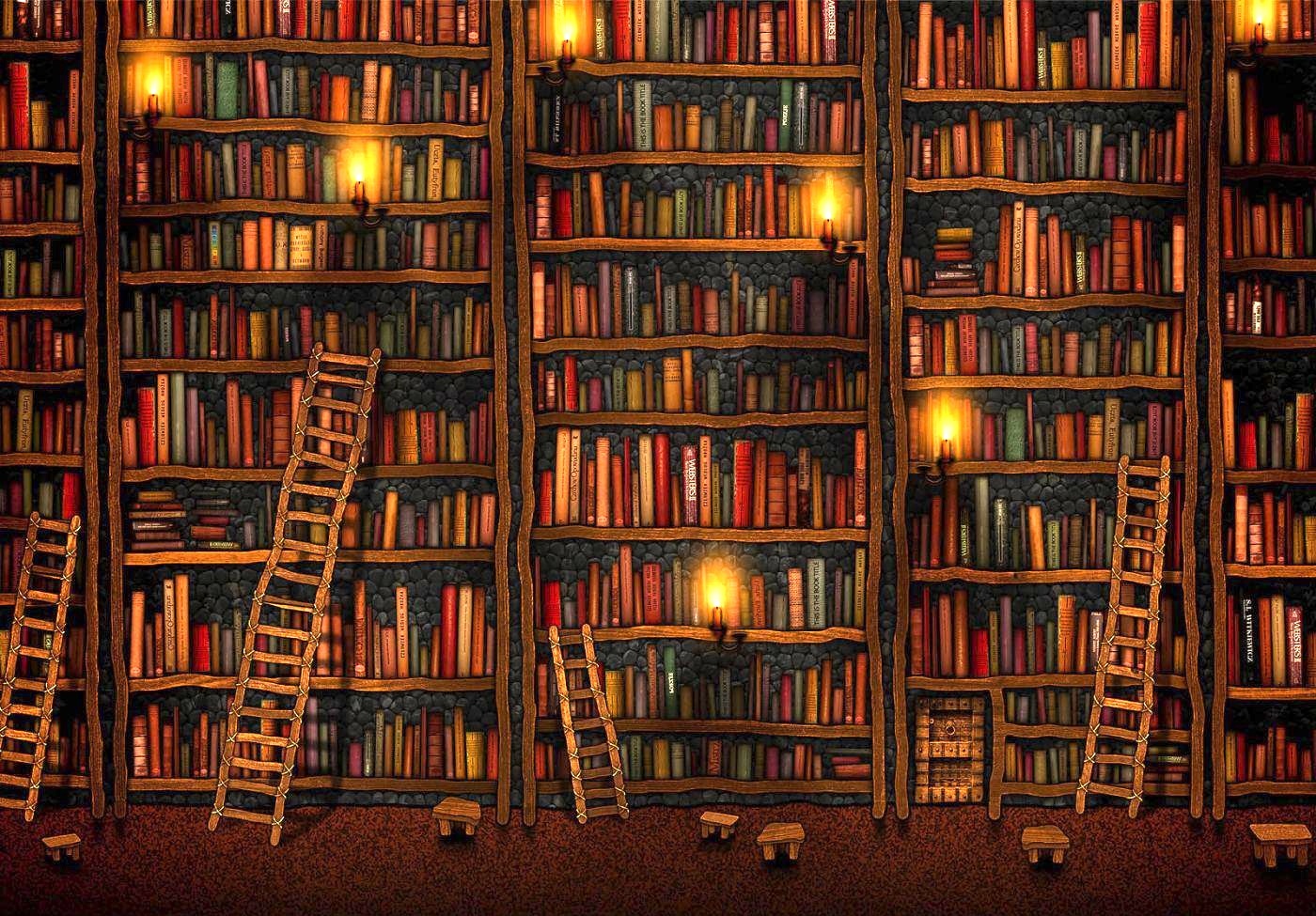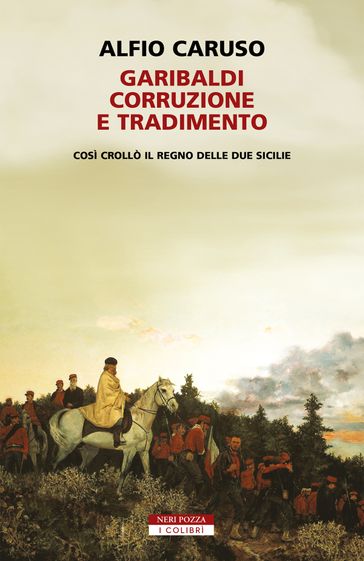Un libro che sarebbe piaciuto al nostro Comandante Aldo Fraccaroli, qualcuno dei lettori lo ricorderà, fervente simpatizzante della dinastia borbonica (in ricordo, è probabile, della sua efficientissima flotta). Il piacevole e scorrevole racconto di Alfio Caruso, apprezzato collaboratore di «Azione» e originale autore di vari volumi storici, guarda infatti con un taglio originale e in qualche modo borbone-centrico alla «conquista delle due Sicilie» compiuta da Giuseppe Garibaldi nel 1860-61.
Nella marea di rievocazioni della folle impresa dei Mille pubblicata negli ultimi centosessant’anni di storia italiana ha ancora senso parlare di queste vicende lontane? La risposta è sicuramente un «sì», soprattutto se, come nel lavoro di Caruso, questa rievocazione storica ci permette di capire meglio dinamiche e atteggiamenti che ritroviamo ancora oggi nella quotidianità della vicina Repubblica. Caruso li sottolinea con il suo consueto argomentare vivace e arguto: gli riesce ad esempio di trovare delle analogie tra lo sbarco dei garibaldini a Marsala e l’arrivo delle truppe americane in Sicilia nel 1943, oppure tra il sistema di corruzione instaurato nel Meridione italiano dopo la sconfitta dei Borboni e quello attuale. In questo atteggiamento storiografico, tra l’ironico e il disincantato, Caruso ci ricorda a tratti il taglio argomentativo tipico di Montanelli, autore peraltro citato in alcuni passaggi del volume.
Per dirlo meglio, il lavoro di Caruso si distingue da altri libri sull’argomento perché utilizza fonti storiche dell’epoca poco conosciute, come il resoconto di Giuseppe Buttà, cappellano militare borbonico e testimone in prima persona delle vicende. Pubblicato nel 1875, il suo Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta è una fonte preziosa e anche impietosa, perché mette a fuoco, nel narrare la sorprendente sconfitta dell’esercito di Francesco II, quanto pigrizia, incapacità, vigliaccheria e anche semplice corruzione abbiano contribuito a una disfatta per molti versi incomprensibile. Come ha potuto un manipolo disorganizzato di volontari (su cui Caruso scherza, affibbiando loro l’epiteto di «Mille non più mille») farsi largo nella storia d’Italia, raggiungendo obiettivi insperati e di fatto costringendo Vittorio Emanuele II ad assecondare un disegno militare di annessione che il suo Primo ministro Cavour non approvava?
La risposta è complessa e articolata e va cercata, secondo Caruso in vari fattori concomitanti, tra cui, non ultima, la debole personalità dell’ultimo re Borbone di Napoli. Francesco II (e la sua eroica moglie Maria Sofia di Baviera, sorella di Sissi, l’Imperatrice d’Austria), circondato da ufficiali e ministri su alcuni dei quali pesa il sospetto di essere stati comprati dal nemico, non ha brillato certamente per coraggio e determinazione. Ma avrebbe potuto comportarsi diversamente? Le radici della sua sconfitta non stavano già propagandosi nel Regno, a Palermo e a Napoli, durante gli ultimi periodi della sua reggenza? Mentre Garibaldi si avvicina alla capitale si assiste infatti a un progressivo modificarsi negli atteggiamenti dell’opinione pubblica: «Le botteghe di Napoli si sono portate avanti: accanto ai ritratti di San Gennaro hanno già messo in vendita quelli di Garibaldi. Da tutti settori, anche da quelli che per decenni hanno strisciato dinanzi al Borbone, è stata avviata una micidiale campagna di delegittimazione di Francesco, del padre, del nonno, dei fratelli, che non si astiene dagli insulti più pesanti, dalle allusioni più becere» (p. 204).
Tanti sono i quesiti interessanti, a cui Caruso cerca di suggerire qualche risposta, ma che naturalmente sono impossibili da sciogliere. La figura di Franceschiello rimane però in qualche modo simpatica al lettore, così come succede ad esempio nel bel film di Luigi Magni, O’ Re (se vi capita: si può vedere integralmente su Youtube). E comunque, più in generale, la sconfitta dei Borboni e la vittoria di Garibaldi sembrano la prefigurazione di un futuro che conosciamo benissimo: secondo Caruso il Risorgimento è «un groviglio di sotterfugi, di opportunismi, di retropensieri.(...) Se volete, l’annuncio del pasticcio italiano, di uno Stato costretto a galleggiare su troppe contraddizioni, naturalmente portato alla concertazione, che spesso si è rivelata una marmellata indigeribile, non una sintesi felice di interessi contrapposti». (p.219).