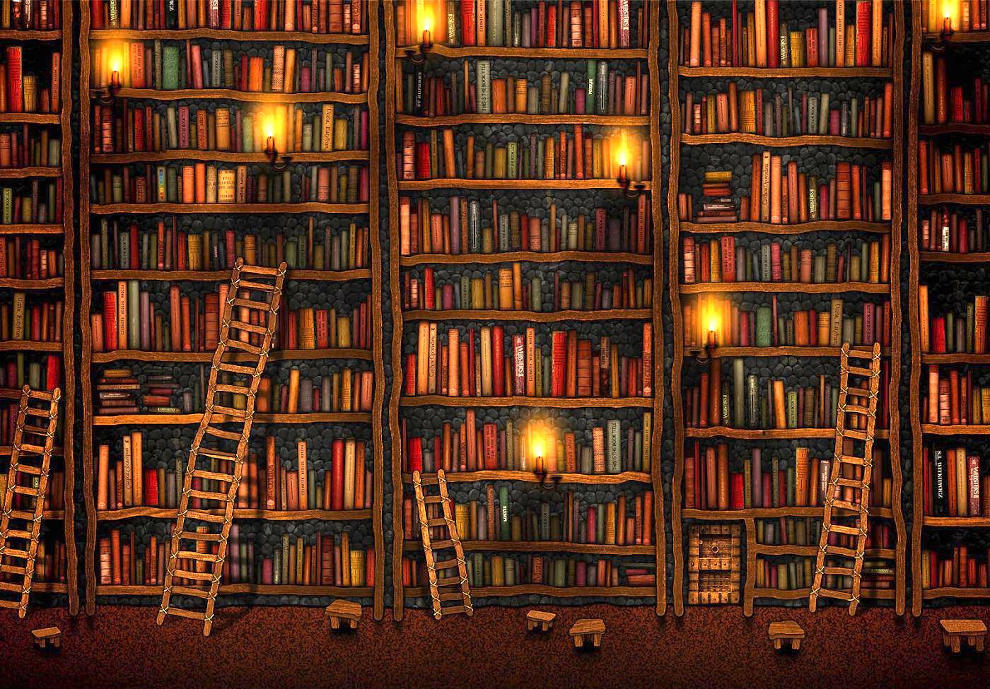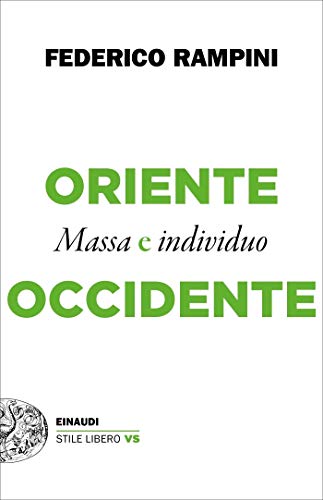Oriente, Occidente. Quale vi fa sognare? Quale vi ispira inquietudine? Chiudete gli occhi e pensate l’Oriente. Se siete occidentali del XXI secolo, questo termine vi trasporta in un luogo magico. Ricordi di terre lontane, letture, contatti con religioni esotiche. La pratica dello yoga o del tai-chi o di arti marziali. L’arte del tè; dei giardini e delle composizioni floreali. Civiltà dalle origini ben piú remote della nostra greco-romana o giudaico cristiana. La spiritualità, è là che siamo andati a cercarla spesso. Soprattutto da tre secoli, da quando la rivoluzione industriale, la competizione per arricchirsi hanno stravolto le nostre vite.
Dunque l’Oriente è anima, l’Occidente materia. Là il regno del silenzio, di qua il rumore. Continuando questa introspezione, per cercare tutto ciò che l’Oriente reale o immaginario ha sedimentato nell’anima, si scopre un’idea di umanità primordiale – l’India come origine delle nostre popolazioni, etnie, lingue e civiltà. La Cina e il Giappone come l’Altro assoluto, civiltà buddhiste e confuciane che un papa polacco definí «religioni senza Dio». Qui c’è l’idea che l’Asia è quella parte del mondo dove la comunità prevale sull’individuo, anche schiacciandolo. I doveri verso gli altri vengono prima dei diritti. Grandi imperi comandano su masse sterminate, da cui esigono obbedienza.
Di recente si è aggiunto un significato nuovo: l’Asia è laboratorio della modernità, là si è spostato il dinamismo, la costruzione del futuro. Per le nostre generazioni quest’ultimo episodio è uno strato sottilissimo, ma ai tempi del Rinascimento l’Asia aveva inventato tutto prima di noi.L’Oriente è un luogo dell’anima oltre che della geografia. Da più di duemila anni ne abbiamo fatto un mito, una costruzione culturale. A cominciare da Omero, Erodoto e Alessandro Magno. Il fascino che esercita su di noi è comprensibile. Da là sono arrivate orde umane che ci hanno invaso, conquistato, civilizzato. E anche contagiato di germi. Qualche volta abbiamo restituito il colpo, andando a colonizzarli noi; nei tempi lunghi ha prevalso il flusso contrario. Poiché siamo più piccoli, cominciammo a formarci un concetto dell’Oriente basato sulla sproporzione. Noi in embrione abbiamo un’idea dei diritti e delle libertà; gli orientali sono eserciti disciplinati e obbedienti.
Regno del silenzio, della trascendenza, l’Oriente lo diventa dopo la Prima rivoluzione industriale. È il Romanticismo tedesco, nell’Ottocento, a imporre due convinzioni: l’India è la culla primordiale di tutte le nostre civiltà; il buddhismo è un antidoto ai mali della modernità. Dopo i romantici arrivano Nietzsche e Schopenhauer. Poi Hermann Hesse col Siddharta forma generazioni di giovani europei e americani. Il Giappone ci influenza col minimalismo della sua architettura, del suo design, a conquistare Steve Jobs e la Silicon Valley. «Zen» entra nel linguaggio di tutti i giorni negli Stati Uniti fin dagli anni Settanta. Ma lo stesso Giappone ci costringe a fare i conti con una realtà rovesciata; un paradosso che la Cina vive in maniera ancora più evidente.
Queste due civiltà ci hanno superato in molti campi della tecnologia e dell’economia. Il risultato dà le vertigini. Dov’è finito l’Oriente che abbiamo vagheggiato per generazioni? Qual è la vera identità degli uni e degli altri? Sono domande che ci stiamo facendo da duemila anni. Vista da Pechino, Singapore o Yokohama, la nostra attenzione verso l’individualità e i diritti è una forza o una debolezza? Ci credono avviati verso un caotico declino?