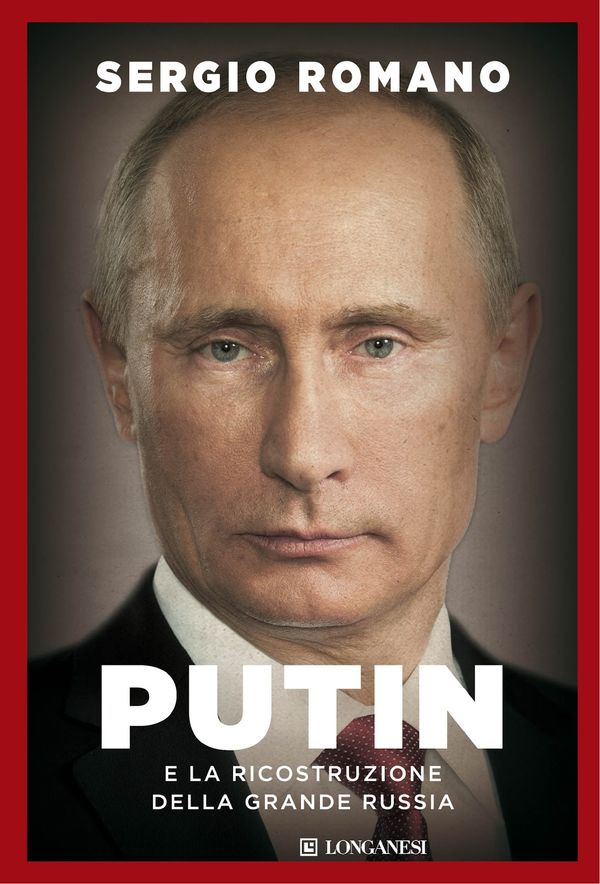Chi sono gli oligarchi? Si tratta di gente che viene dal Komsomol, l’organizzazione giovanile del regime sovietico, la cui caduta li ha resi straricchi e potenti. Al punto che anche Vladimir Putin, un ex colonello della polizia politica dell’Urss, arriva al potere nel 1999 anche grazie a questa casta (l’aiuto più importante arrivò dall’ex KGB). Alla quale, scrive Sergio Romano, «premeva che nessun presidente mettesse in discussione le baronie finanziarie e mediatiche che aveva creato». Ma gli oligarchi non hanno capito con chi hanno a che fare: il nuovo arrivato ha fin dall’inizio un disegno personale. Putin comincia con l’affrontare il più grave dei conflitti etnici che dilaniano il Paese: quello che dalla Cecenia, sta allargandosi a tutto il Caucaso. Ha a che fare con terroristi spregiudicati, che anticipano le attuali tecniche dell’Isis. In quel 1999, la reazione di Putin è durissima, e quella cecena fu «per la ferocia spietata di entrambe le parti, una delle guerre più sporche combattute dopo» il 1945.
In secondo luogo, Putin sgomina gli oligarchi e anche i nuovi boiardi, ovvero i governatori degli oblast e dei kraj (le regioni nate con la costituzione post-sovietica del 1993), feudatari che trattenevano per sé l’intero gettito fiscale. È la fine del federalismo russo post-sovietico: da allora i governatori sono soltanto prefetti nominati dal governo centrale. Cosa pensa di Putin la massa dei russi? Approva. Gli ex comunisti si sentono vendicati, chi teme il terrorismo islamista e la nuova criminalità si sente difeso, gli ortodossi apprezzano la devozione del leader, i nazionalisti sono gratificati dal nuovo prestigio mondiale della Russia, dove patria e fede sono due volti della stessa medaglia. Oltre che della nuova Russia, Putin è architetto della sua memoria identitaria. Occorre dare continuità alla storia del Paese, quindi nemmeno Stalin non viene rimosso dal Pantheon nazionale, che concilia tradizione, periodo sovietico e cristianesimo ortodosso (la Russia come santa erede di Bisanzio e Terza Roma). La data dell’insurrezione nazionale del 1612, ad esempio, è una festa patriottica che cade nell’anniversario della Rivoluzione d’ottobre.
Così le celebrazioni continuano a svolgersi sulla Piazza Rossa. Per esistere e governare il proprio immenso spazio, la Russia ha bisogno di un’ideologia, di una missione. Per un certo periodo, tra i consiglieri di Putin appare Aleksandr Dugin, un estremista di destra che porta alle orecchie del leader le teorie etnogenetiche di Lev Gumilev. Questi era un superstite dell’arcipelago gulag, un teorico dell’euroasiatismo e delle razze primordiali della Russia, la cui qualità era la capacità di sopportare, soffrire, sacrificarsi. Questi gruppi etnici, bollati come primitivi dagli occidentali, sono la vera, eterna anima della Russia. Putin crede in tutto questo? Forse gli serve solo una teoria che proclami l’originalità della Russia rispetto alle seduzioni della cultura occidentale. Il giorno in cui Putin avesse bisogno dell’ovest, queste idee euroasiatiche finirebbero nel cassetto. Eppure, conclude amaramente Sergio Romano, dovremmo chiederci se all’origine dell’autoritarismo di Putin non vi sia anche la pessima immagine che le democrazie occidentali stanno dando di sé.
Nessuno avrebbe potuto tracciare un simile ritratto di Putin, della sua ricostruzione identitaria della Russia e dei suoi rapporti con l’Occidente se non Sergio Romano, che scrive nella doppia veste di grande storico e di ex ambasciatore a Mosca e alla Nato.