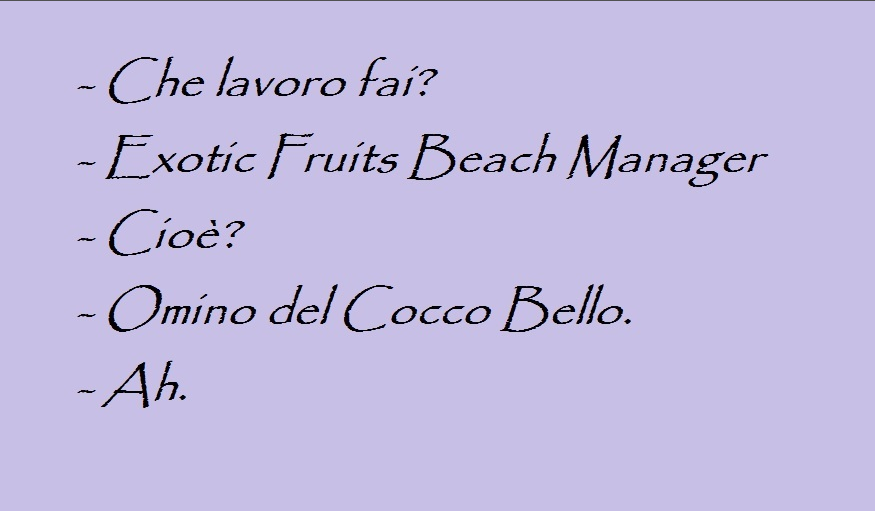«Il concetto di potere morbido, formulato alla fine del secolo scorso dal politologo Joseph Nye, dell’Università di Harvard, riguarda la capacità di influenzare gli interlocutori suscitandone il consenso attraverso la seduzione e la desiderabilità. È un tipo di influenza che una nazione riesce a esercitare anche senza essere una grande potenza economica o militare».
Che il tema degli anglicismi vada ormai un po’ svecchiato è auspicio sacrosanto. L’argomento è scientificamente fermo da anni, pericolosamente esposto alla tentazione, che è anche di qualche linguista illustre, a stare di qua o di là. Dalla parte degli angloscettici neopuristi che sostengono che l’interferenza dall’inglese stia rovinando la nostra lingua, la stia mettendo addirittura in pericolo. O dalla parte degli angloentusiasti, come il tedesco Anatol Stefanowitsch, che insegna all’Università di Amburgo e che dal 2010 indice un concorso per l’anglicismo dell’anno, che è celebrato puntualmente con grande cerimonia.
È quindi benvenuto il libro di un linguista meno conosciuto degli altri, ma originale nella trattazione di questo tema, come dimostra in questo suo Diciamolo in italiano. Gli abusi dell’inglese nel lessico dell’Italia e incolla, appena uscito. Antonio Zoppetti è insegnante e divulgatore; quasi venticinque anni fa, ha per esempio curato la versione digitale del primo dizionario elettronico italiano, l’altrimenti cartaceo Devoto-Oli. In questo suo Diciamolo…, nella meccanica e solida grafica della casa editrice Hoepli, l’argomento è sondato in lungo e in largo. Ci sono i paragoni con altre realtà linguistiche; c’è l’analisi strutturale di dove vanno a incocciare gli anglicismi quando piombano sul sistema linguistico italiano; ci sono gli ormai immancabili pesudoanglicismi (lessicali, grafici e di costume); gli ambiti da dove planano (mass media, scienze, nuove tecnologie ecc.); c’è un «Che fare» che dovrebbe permettere ai parlanti italiani che soffrono di fare un passo avanti, «dalle lamentele all’azione», come dice il titolo di un paragrafo.
Questo libro mette le mani in territori dal respiro certamente ampio e ci tira una certa aria di novità. Dal confronto con le altre realtà (su questo campo, l’italiano è messo sotto da francese e spagnolo e pareggia con il tedesco), al ruolo sottovalutato dell’intervento legislativo francese, alle questioni di costume linguistico e culturale (l’inglese come latinorum contemporaneo è immagine indovinata), all’idea che gli pseudoanglicismi, termini «similinglesi» attestati solo in italiano, siano riconducibili a fenomeni di ibridismo della stessa lingua inglese, che alla periferia dell’impero muta come mutava il latino nel suo periodo di massima espansione. Certo è che il fenomeno riguarda per la sua quasi totalità le parole, e il tentativo di vedere un’avanzata dell’inglese nel cuore del sistema raccoglie solo qualche fraseologia nei territori dove la sintassi è molto prossima al lessico («chi ha comprato cosa», «votare per il tal partito», poca roba).
«Che fare?» è capitolo militante, perché su questo tema tutti, anche i più rigorosi, finiscono per cedere alla passione. Nell’ordine: prendere coscienza del fenomeno, non negarselo; mettersi al riparo dal fascino e dalla sensualità della lingua inglese; l’Accademia della Crusca; politica linguistica e intervento statale (chi ha detto che in Francia la Loi Toubon del 1994 non abbia funzionato?); la promozione dell’italiano come portatore di un potere morbido, che di fronte allo strapotere economico e politico conquisti con la dolcezza e la seduzione; l’uso dell’ironia. Consigli superiori e ministeri hanno avviato in Francia e in Spagna campagne che letteralmente prendono in giro chi usa franglais, spanglish, linguaggi sincopati e abbreviati come quelli dei messaggini. Ogni consiglio è benvenuto.