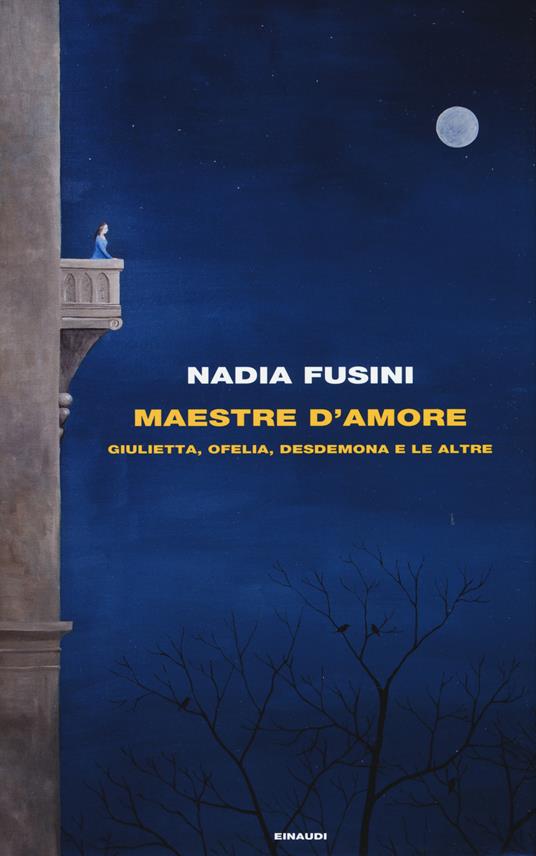Abbiamo incontrato Nadia Fusini, studiosa di Letteratura inglese e comparata, critica letteraria e accademica italiana, curatrice dei due volumi dei Meridiani Mondadori dedicati a Virginia Woolf e di quello su John Keats. Autrice di numerosi romanzi e saggi sulla scrittura delle donne, tra cui l’ultimo Maestre d’amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre, edito da Einaudi, sarà al centro dell’evento letterario «Le donne di Shakespeare».
Nel suo ultimo saggio Maestre d’amore, lei cita Dante in apertura e la canzone Donne ch’avete intelletto d’amore, poi scrive che: «l’amore, più che un’azione, è un discorso». Perché le donne sono più brave a comprendere il discorso dell’amore?
Racconto per spiegare questo, l’episodio di mia madre e mio padre che «facevano l’amore» secondo un modo di dire di generazioni passate, per le quali l’amore si faceva per l’appunto parlando, nella fase del corteggiamento. Il corteggiamento era «fare l’amore» – alla lettera dare all’amore corpo di parola. È una idea del «fare» poetico, fare come creare. Non come mettere al lavoro il corpo, in uno scambio di fatica e di guadagno. Naturalmente «fare l’amore» è anche quello: con «fare l’amore» si può intendere «fare sesso» – ma «to make love» e «to make sex» rimangono cose diverse.
Sono sfumature da cogliere, sono modi di dare senso a delle azioni, a degli atti. In ogni caso è in gioco un’idea del «fare» come azione, in cui si spendono il corpo e la mente, in un esercizio in cui il corpo spendendosi, ne guadagna qualcosa in termini di sensazioni – nel fare sesso è così, no? Nel fare l’amore, al modo in cui lo intendeva mia madre, l’azione riguardava la lingua – era non lavoro, non dispendio, ma creazione. Dante ragiona di tutto questo nella Vita Nuova, e non poteva non essere sullo sfondo del mio libro, perché il discorso sull’amore delle «mie» donne shakespeariane prende avvio contro quella tradizione dell’amore cortese.
Nel capitolo «Godo di te, con te, dice Giulietta», lei aggiunge: «la donna è l’ora della verità per un uomo […] Scrivo questo libro per dimostrare la verità di tali parole». Qual è secondo lei l’ora della verità per una donna?
Che la donna sia l’ora della verità per un uomo significa che la donna che l’uomo sceglie lo «svela», lo «smaschera». L’uomo si fregia della donna, quasi desse così, con la conquista, consistenza alla sua credenza fallica. Al suo abbaglio. Sono altre le ragioni per cui una donna sceglie l’uomo che sceglie. Per ognuna, ragioni diverse. Perché non esiste La donna. Esistono le donne. Come insegna Lacan.
Nella prima parte del testo, dedicata a un’analisi di alcune tragedie shakespeariane, nel capitolo «La bestia a due schiene: Desdemona con Otello», scrive: «l’amore che salva è l’amore intelligente, l’amore attivo che allontana il male e avvicina il bene». Come si fa l’amore intelligente, come Petruccio e Kate, protagonisti della commedia di Shakespeare La bisbetica domata?
Senz’altro la commedia di Petruccio e di Kate trasuda intelligenza e ironia, è una presa in giro sovversiva dei ruoli femminili e maschili della scena dell’incontro tra i sessi. L’esercizio della «doma» – the taming – che coinvolge entrambi i protagonisti è trasformativo. L’amore intelligente è l’amore che trasforma.
Nel testo ricorre questa considerazione: «in amore vince il fantasma, non ci si può fare niente, è così». Può spiegarla?
Non faccio che spiegarlo in tutto il libro. Si può capire leggendo. Credo. Non c’è altra strada.
Nella seconda sezione «L’amore in commedia I», lei scrive: «La bontà e la cattiveria sono qualità etiche, o etichette morali? […] Trasgredire una legge ingiusta non è forse un’azione etica? [..] Se per avere quel che si vuole si deve disobbedire […] come andrà a finire?» Nei testi che descrive e analizza, spesso oltre agli amanti, è protagonista il coraggio. L’amore, dunque, è sempre una prova?
Le commedie romantiche di Shakespeare – come queste commedie vengono definite – sono sì commedie d’amore, ma sono soprattutto una esaltazione del «free will». Della volontà libera, della coscienza del soggetto, uomo e donna, perché liberamente il soggetto scelga e decida della sua vita secondo coscienza. È questo l’amore early modern che Shakespeare esalta.
A conclusione di questo percorso, in cui lei stessa è stata Maestra d’amore, si domanda: «Perché con tutta la scienza che ne abbiamo, ancora soffriamo per amore? […] Questione etica, che chiama in causa il senso della letteratura, il suo valore». Ama peggio chi non legge? E soffre meno per amore?
Direi di sì. Non so proprio come possa amare chi non ha fantasia. Chi non s’avventura nel mondo meraviglioso e portentoso dell’invenzione fantastica.