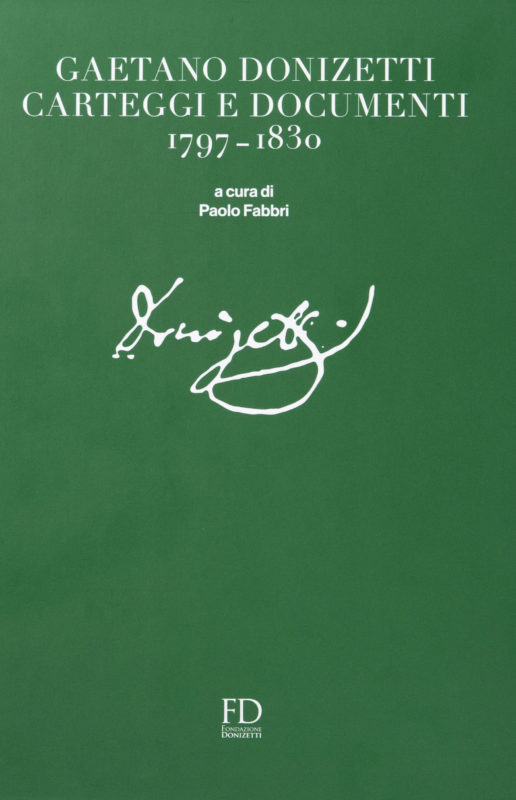Da settant’anni si attendeva ordine nell’epistolario di Gaetano Donizetti, dopo l’antico storico lavoro di Guido Zavadini, gli apporti di Guglielmo Barblan e Frank Walker e di vari numeri di «Studi Donizettiani». Gaetano Donizetti – Carteggi e Documenti – 1797-1830, pubblicato dalla Fondazione Donizetti di Bergamo, per la cura di Paolo Fabbri, include fra 278 documenti, 8 inediti donizettiani e 15 di stretti familiari. Il volume è montato come un’auto-biografia intersecata da citazioni epistolari di parenti stretti, colleghi, impresari, editori.
Parole vitali e piene di umori come quelle del compositore agli amici; paludate come nei contratti con delegati e impresari; rozze come quelle del padre-tessitore Andrea o del fratello soldato, che spalancano con la loro lingua appena sbozzata, le porte di quel seminterrato, fuori dalle mura di Città Alta, civico 10 di Borgo Canale, dove Domenico Gaetano Maria, ebbe natali umilissimi il 29 novembre 1797.
Un bambino che trovò la Provvida ventura nella figura del compositore bavarese Johann Simon Mayr, ideatore e guida delle Lezioni caritatevoli che a Bergamo istruivano fanciulli senza mezzi né speranze di riscatto. Il ragazzino Donizetti si segnalerà per estro e musicalità, come testimoniano le accademie che Mayr organizza per mostrare i progressi degli studenti ai mecenati e al pubblico. Nella Prova dell’Accademia finale, «i personaggi ed esecutori sono li stessi allievi della scuola, li quali fanno tra loro le prove dell’Accademia medesima e facendosi taluno d’essi maestro a’ colleghi, e quale è il costume de’ giovanetti insolentendosi, e perseguendosi l’un l’altro alcune scelte parti di musica di celebri compositori vanno cantando».
Mayr accompagna Donizetti ovunque con lettere di raccomandazione agli insegnanti bolognesi, al futuro editore Giovanni Ricordi, agli impresari che non poteva soddisfare e a cui segnalava il talento dell’allievo, e perfino a chi di dovere gli potesse evitare la coscrizione che lo avrebbe costretto a «scrivere Tedescamente»! D’altronde le carriere si costruivano appoggiandosi alle conoscenze amicali, perché i colpi dei rivali erano bassi e frequenti. Per l’esordio a Roma con Alahor in Granata, alla cabala contraria montata dalla potentissima principessa Paolina Borghese, amante del collega Giovanni Pacini, si aggiunse la morte improvvisa del tenore Amerigo Sbigoli, al quale scoppiò una vena, dopo aver cercato di imitare il primo tenore Domenico Donzelli, e l’unico sostituito su piazza era una certa Signora Mazzanti, contralto.
Sono anni in cui Gaetano Donizetti deve ancora farsi conoscere, come testimonia la grafia «mobile» del suo cognome: trascritto alla bergamasca con la «zeta» pronunciata «s», «Donisetti»; raddoppiate le consonanti alla romana, «Donnizzetti», come lo chiama il Grazioli, maestro di cappella di Santa Maria dell’Anima, che si cura dell’alloggio e della biancheria del giovane musicista. Il collega Mercadante lo chiama «Donesetti» quando lo introduce presso Luigi Mosca, attivo nel direttivo del Teatro Nuovo di Napoli oppure «Dozzinetti», quando diverrà un serio rivale – storpiatura meno perfida di quella dello zio del compositore Nicola Vaccaj che lo chiama «Nonizzetti».
Fra debutti alterni delle opere serie e riprese di successo delle farse, camarille e partiti, poeti neghittosi e impresari spilorci, fra il matrimonio con Virginia Vesselli e la morte del figlio Filippo, nato prematuro e portatore di handicap, la vita scorre accanto al teatro che assorbe tutto: dalle parodie degli anni studenteschi alla vigilia della maturità artistica, sancita dall’incarico di scrivere Anna Bolena per il Teatro Carcano di Milano in sfida diretta con la Sonnambula di Vincenzo Bellini. Appena perso il figlio, il Napoleone degli impresari, Domenico Barbaja «con cui siamo Diavolo e Croce», vuole subito il compositore al lavoro: «ho appena partorito e già mi volete ingravidare?», domanda ironico Donizetti. La risposta è storia del melodramma.