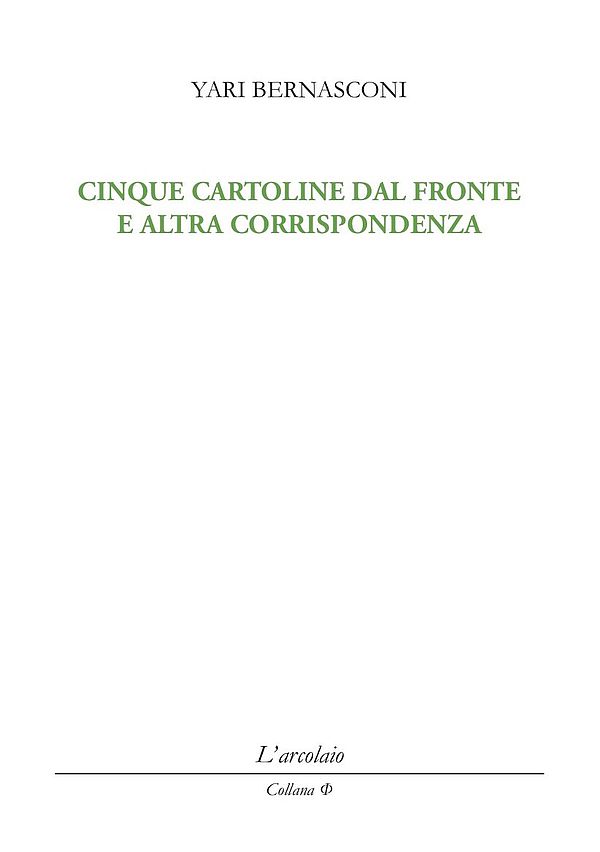Per il suo libro di esordio (Nuovi giorni di polvere, Bellinzona, Casagrande, 2015) Yari Bernasconi aveva avuto in sorte una quarta di copertina di quelle che lasciano il segno. Era firmata da Goffredo Fofi che senza mezzi termini – come è nel suo stile − individuava nella poesia di Bernasconi due tratti distintivi inequivocabili: la ricerca «di un vero che risiede nel dolore degli altri» e il senso di colpa suscitato da una condizione di privilegio. Non saprei dire se Yari si sia mai identificato al 100% in queste categorie, forse un po’ «facili», ma è certo che anche negli anni successivi la sua poesia ha continuato a muoversi in quell’alveo (civile e politico), magari con piccoli accorgimenti e aggiustamenti di rotta, ma senza mai abbandonare una via maestra oramai tracciata, riconoscibile a ogni passo.
A due anni di distanza dal primo libro, nel maggio del 2017, era uscita La città fantasma, una plaquette stampata a mano da Nervi Edizioni che per fattura e compattezza avrà suscitato l’invidia di non pochi colleghi. Vi si riconoscevano il medesimo sguardo dei versi precedenti, tanto più esasperato dall’assenza totale dell’uomo e dalla descrizione di un dopo intriso di malinconia per quanto sarebbe potuto essere: «Sulla mensola buia, di fianco al quadro / senza colore, resta ancora da regalare / un ultimo fiore di legno» (La bottega di un falegname); «La saracinesca ha ceduto. Le riviste e i giornali / non stanno più nelle scansie, ma occupano / il pavimento alla rinfusa. Appeso al muro / c’è uno specchio accecante, dove forse / l’edicolante pettinava i suoi baffi» (L’edicola).
Il costrutto metaforico della città abbandonata si declinava in ogni pagina, in ogni luogo, secondo una strategia retorica costante che metteva al centro l’assenza e la morte, ma che intendeva in realtà raccontare la vita attraverso il suo traslato. Quasi un negativo fotografico dell’originale.
Leggere oggi Cinque cartoline dal fronte e altra corrispondenza, con la mente al percorso degli ultimi anni, è in un certo senso un’esperienza rassicurante, data dalla continuità tematica, dalla consapevolezza del montaggio e soprattutto dalla coerenza stilistica, che non pare essere venuta meno con il passare del tempo. L’idea stessa di una corrispondenza poetica era già insita nella lontana Lettera da Dejevo (2008) e in alcune «cartoline» sparse qui e là nel libro maggiore, dove Bernasconi metteva a frutto spunti prelevati dalla tradizione letteraria svizzero-italiana: Lettera da Bellinzona di Giorgio Orelli (1965) e Lettera da Tinizong di Fabio Pusterla (1985).
Ma Cartoline è anche il nome di un progetto di scrittura a quattro mani, per ora soltanto online, iniziato da alcuni mesi con Andrea Fazioli. Insomma quando Yari Bernasconi scrive, scrive a qualcuno, da un luogo preciso, in un punto fisso del tempo. È la dichiarazione stessa di un bisogno di comunicazione e, insieme, il desiderio di lasciare un segno.
Il fronte da cui si spediscono, idealmente, le cinque cartoline del titolo non è altro che il confine politico tra Svizzera e Italia nei dintorni di Ponte Tresa (l’autore è originario del Malcantone), non più «frontiera» di sereniana memoria ma soltanto luogo di «vite assembrate / negli abitacoli e nel traffico», teatro di incomprensioni, «minime sofferenze, sacrifici comuni». A tema è posto, oltre un’immagine paesaggistica un po’ trasandata, persino troppo, il rapporto tra due nazioni e l’uso anche politico (enfatico) dei problemi che contraddistinguono le zone di frontiera.
Si legge in filigrana quasi il rimpianto per problemi più gravi (il senso di colpa dato dal privilegio messo in evidenza da Fofi): «Dicono guerra e io guardo il lago / appena mosso»; «Verso Luino le strade non crollano, / non lasciano voragini aperte sopra il buio». La negazione in tutte le sue forme linguistiche – morfologica, grammaticale, sintattica, semantica – è non per caso la struttura portante di questi versi, convinti che siano «l’incerto, l’impuro, l’impossibile» a dare senso alla vita e che «la certezza di dire: siamo» possa, con Montale, essere soltanto smentita, mai affermata positivamente.
A tratti emerge una vena civile ispirata alla levitas di un Giorgio Orelli («Se questa è sul serio la tua terra promessa, / puoi tenerla per te. Coltivaci i tuoi sassi») ma l’imprinting poetico di più lunga durata si conferma, nel lessico e nella sovrapposizione ideologica, quello di Fabio Pusterla − davvero un esempio forte, comune anche ad altri giovani autori attivi oggi nella Svizzera italiana, da Massimo Gezzi a Matteo Ferretti, da Vanni Bianconi a Fabiano Alborghetti (per certi versi anche Daniele Bernardi).
Senza nulla togliere alla parabola personale di ciascuno, al proprio stile e racconto biografico, ad atmosfere ed esperienze anche molto diverse tra loro, parrebbe – se il termine non è del tutto scomparso dal dizionario della critica – il manifestarsi di una piccola «scuola», un gruppo più o meno spontaneo e allineato, di cui Bernasconi è forse il rappresentante più puro e riconoscibile.