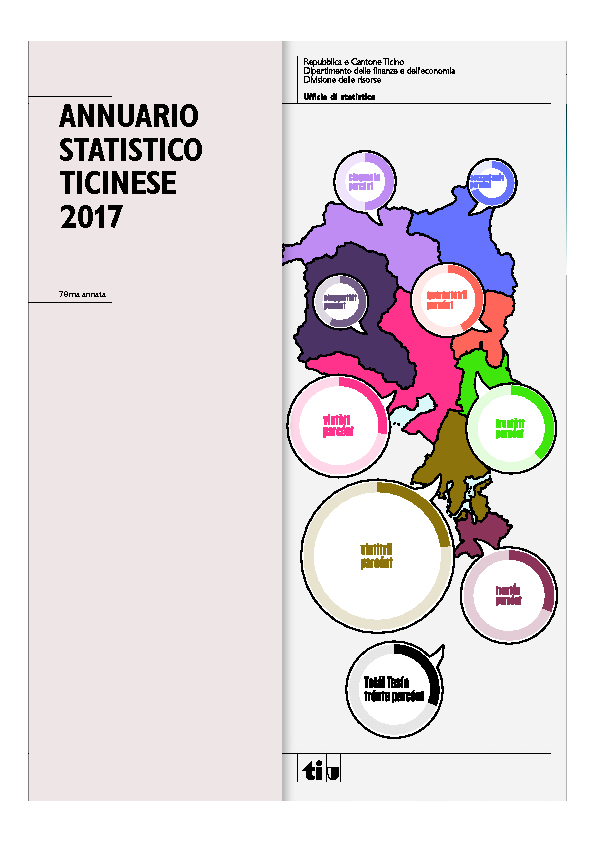L’ultimo numero dell’Annuario statistico ticinese, il numero 78 della serie millesimata, ha un capitolo di una ventina di pagine dedicate a statistiche sulla cultura e la società dell’informazione, oltre a una cover story sulla diffusione numerica del dialetto secondo gli ultimi rilevamenti. La parte sul dialetto porta le percentuali relative a persone che parlano dialetto in casa (coi só gént secondo colorita dicitura a didascalia); come prevedibile, il tasso ogni cento abitanti è chiaramente variabile: dal 23% del luganese al 69% della valle di Blenio.
Ma colpiscono alcuni dati che parlano di una situazione sociolinguistica almeno curiosa. Nell’ordine: il fatto che tra valle di Blenio e valle Leventina ci sia una differenza percentuale a favore della prima che sfiora il 20%; il fatto che la Leventina abbia un tasso di dialettofonia appunto abbastanza basso (inferiore a Blenio e valle Maggia, di poco superiore alla valle Riviera); il fatto che il Mendrisiotto abbia percentuali lusinghiere, essendo il suo 31% superiore a Luganese e Locarnese e di poco sotto a quello del Bellinzonese.
Incrociando tutte le dita possibili e preso atto che nel frattempo sono cambiati i sistemi di rilevazione, il 30% della media cantonale, che è raccolto nella migliore delle situazioni possibili e cioè quando il dialetto è usato insieme all’italiano e ad altre lingue a domicilio, parla di un regresso ormai chiaro di queste varietà. Le quali seguono destino simile a quello delle lingue più deboli in tutte le situazioni di bilinguismo del mondo, dagli ispanici di New York, agli italofoni di Zurigo, a molte e molte altre situazioni: se la prima generazione è monolingue nella lingua di origine, la seconda è quasi perfettamente bilingue e la terza è ormai quasi del tutto monolingue nella lingua dominante. È probabilmente una questione di conguagli tra lingue del matrimonio e succedersi di generazioni. Seppur con un sistema di rilevazione statistica leggermente diverso (che peraltro pare aumentare le percentuali, per fatti propri della statistica), nel 2000 le persone che usavano il dialetto insieme ad altri codici in famiglia erano in numero di quattro punti percentuali superiore; non si può insomma essere sicuri del fatto, sostenuto dai più, che la dialettofonia tiene bene nelle situazioni comunicative miste con l’italiano.
Sul posto di lavoro, anche lì, scendono le percentuali dell’uso esclusivo del dialetto (ormai all’1,9%) e dell’uso del dialetto insieme ad altri codici (21,8%): erano, con il vecchio sistema ricordiamolo, rispettivamente il 4,1% e quasi il 25% all’inizio del millennio. In pratica, parla solo dialetto un lavoratore su venti e anche dialetto uno su cinque: tolto lo scarso settore primario, alcune nicchie di dialettofonia storica come il settore militare e parte del settore pubblico, e al netto di situazioni sociolinguisticamente marginali come le valli o, al contrario, tenuto conto del ruolo percentuale che dovrebbe essere frenante dell’invecchiamento della popolazione, la perdita secca dei tassi di dialettofonia è fuori di dubbio.
Non ci dice l’Annuario statistico, perché non è il suo mestiere e non ce lo potrebbe comunque dire da quell’osservatorio, quanti pezzi stia perdendo il sistema dialettale nella sua qualità oltre che nei numeri; se nelle riserve di resistenza percentuale ai margini del territorio cantonale, i sistemi linguistici tendono a mantenere caratteristiche strutturali se non immutate almeno discretamente conservatrici, la contaminazione, la soluzione intermedia, l’enunciazione mistilingue nelle quali il dialetto è tritato nei settori geografici più centrali allentano la sua presenza in modo ancora più pronunciato. Mettiamoci pure anche ambiti di uso sempre più ristretti e asfittici e un lessico inadatto alla modernità imperante e la frittata è fatta. A meno di prevederne se non l’insegnamento almeno una qualsivoglia «copertura» scolastica, che a questo punto parrebbe idea non del tutto infelice.
Bibliografia
Annuario statistico ticinese 2017, Bellinzona, Ufficio cantonale di statistica, 2017.