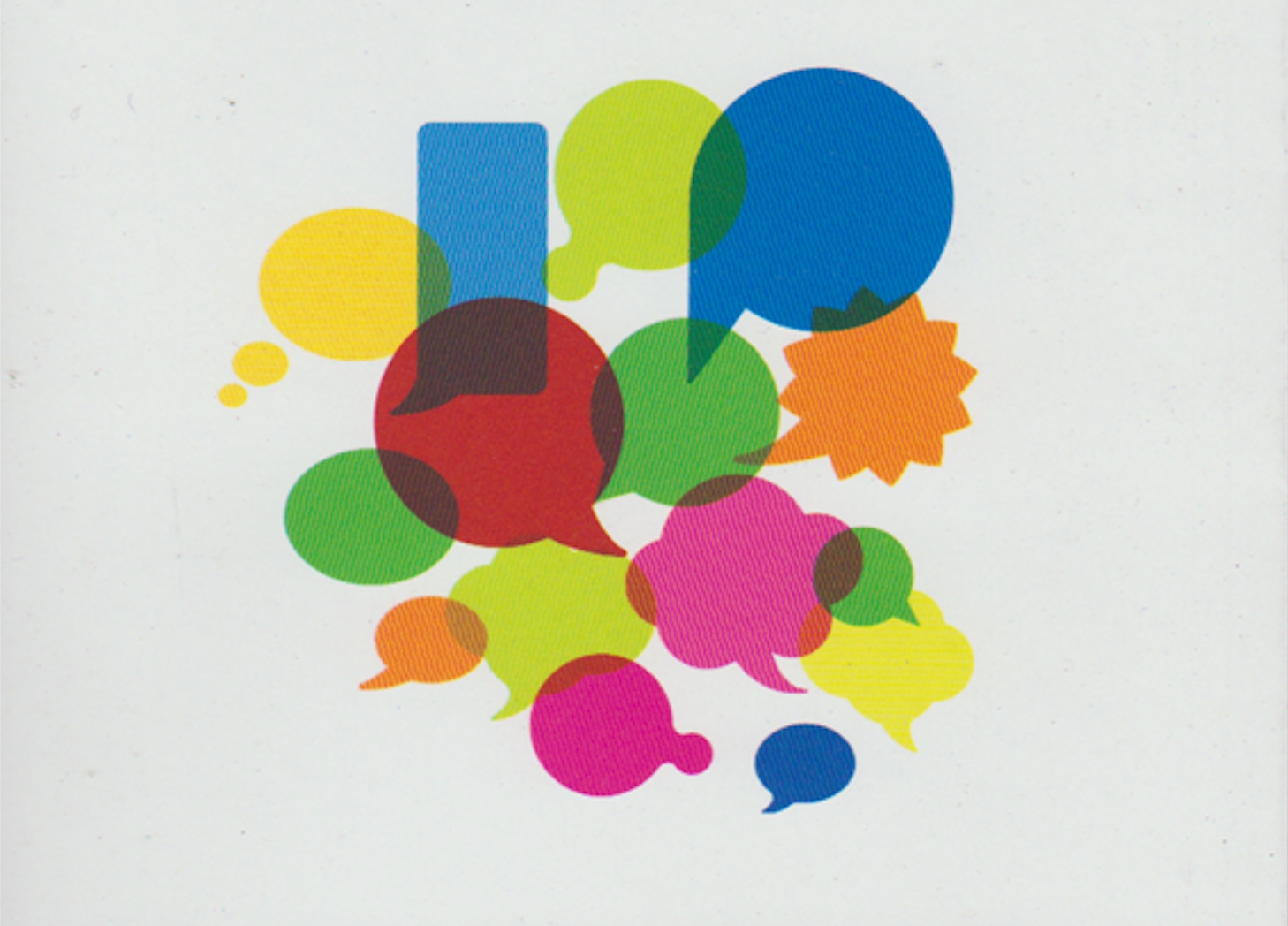«Solo due anni fa, quando già dicevo normalmente “sindaca”, mi trovai per un attimo bloccato e capii in un istante quanto conti l’abitudine, per cui vicesindaca, meno frequente e parola composta, non mi usciva di bocca con naturalezza».
Da qualche settimana e per parecchie settimane ancora il quotidiano «la Repubblica» allega volumetti dedicati a diversi temi a vario titolo legati alla lingua italiana, pubblicati insieme con l’Accademia della Crusca. Per intenderci: la grafia, le parole della Rete, l’italiano nella musica, l’italiano nel diritto e così via. L’impresa del frequentatore di giornalai a fronte di azioni di questo genere è spesso faticosa: il più delle volte ci si accorda con il giornalaio stesso e si acquista tutto in blocco, alla fine, ipotecando in anticipo una discreta cifra. Oppure ci si accontenta di imbroccare la settimana giusta o talune rimanenze e capita, come a questo frequentatore, di sentirsi strane offerte del tipo «guardi, ho qui il primo, poi – vediamo un po’ – dialetti, La ricchezza dei dialetti, il linguaggio di generazione (sarebbe di genere, ma al giornalaio non si può chiedere di sapere sempre tutto) e Le lingue degli altri».
Quindi, per non sbagliare, preso dialetto e linguaggio di genere e letti nell’ordine. Sul primo, che cosa dire? Uno: che la ricchezza dei dialetti sarà anche ricchezza dei dialetti ma che la ricerca sui dialetti ha, oggi, perso ricchezza: se la linguistica è di sovente considerata scienza molle, la dialettologia è da taluni ritenuta disciplina spugnosa, mollerrima. Due: è già un po’ che a questa direzione di ricerca molti chiedono qualche svolta (pragmatica? Strutturale? Sociolinguistica? Situazionale? Qualcosa, insomma), che vada un po’ al di là delle annotazioni minime su qualche episodico volgere fonetico strappato a sapienti vive voci e delle rassegne di testi con dialetto dentro (il dialetto nel cinema, il dialetto nella musica e, inevitabile ormai, il dialetto in Rete).
Il linguaggio di genere è invece tematica à la page; qui, c’è il fatto che la lingua è come risucchiata in faccende di società e cultura ben più grandi di lei. Chiedere alla lingua di risolvere questioni e discriminazioni annose è intento supponente e ingeneroso e la scienza cerca di fare quello che può. Per esempio far notare che sindaca va bene, ma che vicesindaca può voler dire “la vice di un sindaco”, ma a rigore sarebbe “la vice (o il vice) di una sindaca”. Oppure che nelle raccomandazioni del diffuso rapporto su Il sessismo nella lingua italiana, curato nel 1987 da Alma Sabatini per conto della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, non ha preso piede l’accordo dei participi passati sulla base del genere della maggioranza di un gruppo: Sono arrivati resta al maschile anche se la maggioranza di quelli che sono arrivati sono donne. Sì, sul lessico un po’ si può incidere, sulla morfosintassi è difficile. Oppure ancora che avanzano concetti e nozioni più produttivi e meno ideologici, come quello del «valore generico e non marcato» del genere maschile (si può, no? Non è irrispettoso).
Sembra (sentendo ancora il giornalaio) che librettini di «Repubblica» e Accademia della Crusca, vadano letteralmente a ruba. Sarà il fascino della serie che impone, preso il primo, di prenderli compulsivamente fino a esaurimento; oppure, per i più ottimisti, sarà un autentico interesse per la lingua nazionale. Con gli alti e i bassi, la collana è decisamente una buona idea e il canale di distribuzione un’idea supremamente ottima.
«Ma la lingua, lo ricordiamo ancora una volta, non si impone e non si modifica “a comando”: occorrono decenni perché nuove forme e nuovi usi si radichino nella lingua, e secoli perché modificazioni più profonde prendano piede».