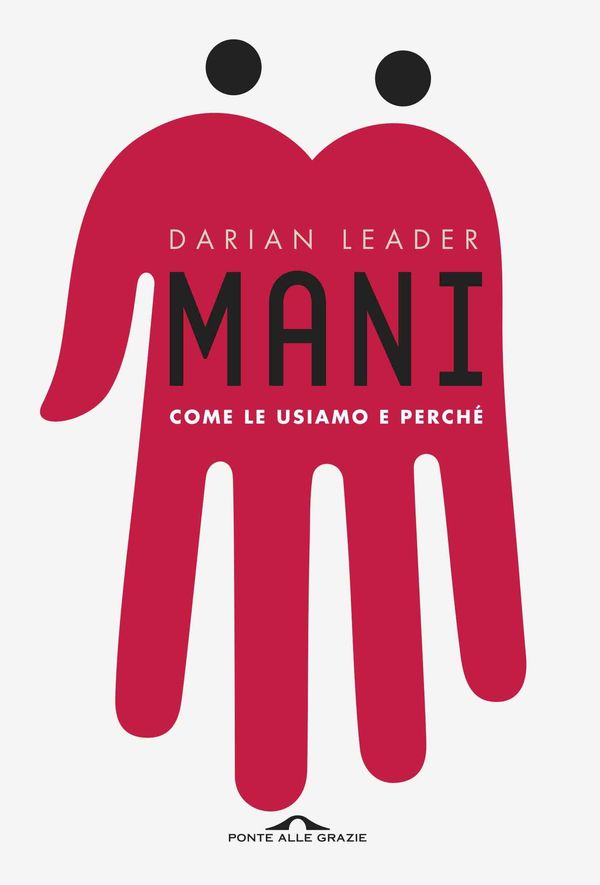«Nell’ampia letteratura sulla mano umana, emerge regolarmente la questione degli attrezzi. È il loro uso che, a quanto leggiamo, non solo ci differenzia dalle bestie ma ha anche sospinto il cervello nel suo cammino verso il successo evolutivo. Smettendo di ciondolare dai rami, le nostre mani si ritrovarono libere di compiere attività che permisero nuove forme di abilità».
È d’uso da qualche decennio inserire nei manuali di semiotica un capitolo dedicato al rapporto, da molti certificato, tra postura eretta dell’essere umano primigenio e sviluppo delle lingue naturali: l’uomo – detto altrimenti – parla in virtù del fatto che ha i soli piedi ben piantati per terra e le mani non occupate a camminare come i quadrupedi. Da quel momento simbolico e virtuale l’uomo comincia a fare cose con le mani: indicare, mediare azioni attraverso l’uso di strumenti e attrezzi, parlare. Secondo questa tesi non priva di fascino, il linguaggio, visto il suo carattere simbolico, non sarebbe che una specie di attrezzo sommamente esterno al suo utente, che serve per interagire con i propri simili e quindi con il mondo.
L’uomo è l’unico essere che parla, insomma, perché è l’unico abitante della Terra che sa fare cose mediate da attrezzi. Certo, qualche cercopiteco riesce a tirare fuori dei tuberi da buchi nella terra con un bacchetto; ma poi, ingerita la patata, tutte le scimmie buttano il bacchetto e se ne vanno via senza cavarne alcuna lezione per il futuro. Per alcuni, la paleontologia classica, tutta intenta a trovare crani che contenessero cervelli più voluminosi di quelli delle scimmie, avrebbe fatto meglio a grattare un po’ più in là e tirare fuori le molto più parlanti mani.
Dell’importanza comunicativa, ma soprattutto psicologica delle mani tratta questo inusuale Mani. Come le usiamo e perché dello psicanalista inglese Darian Leader. Dalle mani dei neonati e il loro rapporto con la bocca, alle mani che filano per gran parte dell’antichità, alle mani che scorrono nervosamente sui tasti dei telefonini. Le mani che non sanno stare ferme, quelle che servono ad agganciare il prossimo ma anche a tenere lontano il mondo là fuori; quelle che servono a organizzare i riti della religione, quelle nel cinema, nelle belle arti, nella letteratura. In Frozen, estetizzante narrazione Disney del rapporto ambiguo e struggente tra due sorelle, una protagonista assiste all’irrompere del male che si manifesta nel congelamento progressivo delle proprie mani (hands) e all’entrata in scena di un principe, Hans (Hans? Che caso, eh?), del tipo che parte apparentemente bello e buono ma poi evolve, dopo un po’, verso l’ambiguo e il malvagissimo. La letteratura è piena di mani, il più delle volte cattive, che agganciano, appendono, stringono, rilasciano al momento sbagliato, uccidono, fanno cose schifose.
E poi i telefonini: se da una parte essi strutturano una certa continuità antichissima e quasi fisiologica nell’occupare le mani, che parte dallo sferruzzare degli aghi da maglia, ai ventagli, alle sigarette, al grattarsi il capo, d’altro canto il correre nervoso delle dita su questi oggettini non farebbe che celebrare una tendenza primaria e fondamentale: quella di sostanziare il nostro linguaggio e la nostra comunicazione con gesti che in un qualche modo «incarnino il verbo», che diano qui al nostro modo di interagire con gli altri la sostanza carnosa delle nostre dita.
«Abbiamo visto che il Google Glass ha avuto uno scarso successo, e la prospettiva di comunicare con i nostri computer solo attraverso la voce può sembrare emozionante e attraente, ma ci priverebbe del ruolo forse più importante che questa tecnologia svolga: permettere alle mani di toccare, digitare, cliccare, scorrere».