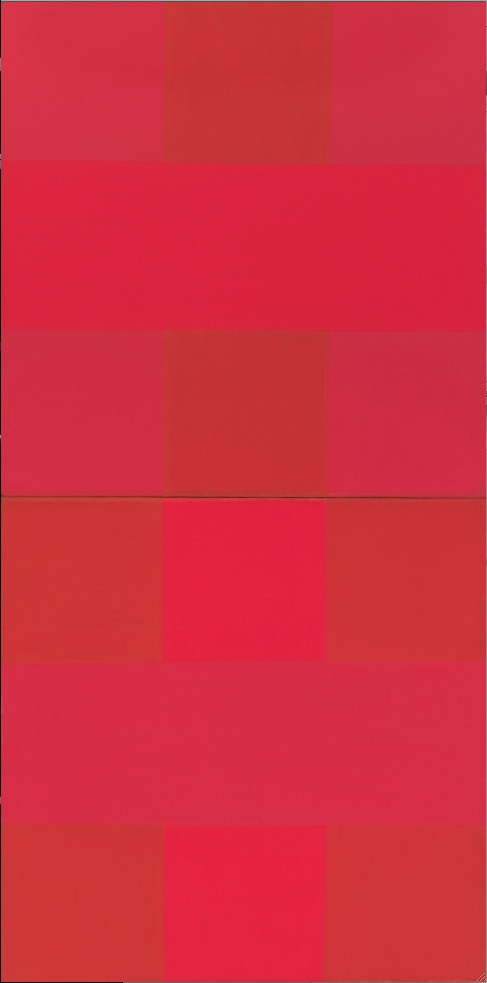Al complesso del Vittoriano, nell’ala Brasini, fino al 24 febbraio si può visitare la mostra dedicata a Jackson Pollock e alla scuola di New York. Circa 50 opere degli esponenti dell’Espressionismo Astratto che animarono la scena artistica mondiale del secondo dopoguerra, spostando per la prima volta il baricentro del fulcro culturale ed artistico dall’Europa agli Stati Uniti. Esposti quadri di Jackson Pollock, anche il celebre Numero 27, di Mark Rothko, di Willem de Kooning, tra cui Door to the River, Franz Kline, Ad Reinhardt, Arshile Gorky, Robert Motherwell.
Si tratta degli esponenti principali della Scuola di New York, firmatari, insieme ad altri, della lettera al Direttore del Metropolitan Museum of Art nel 1950, che iniziava così: «Caro signore, i pittori firmatari di questa lettera rifiutano l’imponente esposizione nazionale che si terrà presso il Metropolitan Museum of Art il prossimo dicembre, alla quale non presenteranno alcuna opera». L’accusa degli artisti firmatari al direttore Roland L. Redmond è che la mostra organizzata non tenesse nella debita considerazione l’arte contemporanea d’avanguardia. Il ghiaccio era stato rotto, per usare un’espressione con cui i critici facevano riferimento all’opera dello stesso Jackson Pollock, e le istituzioni come il Metropolitan Museum non potevano più fare finta di nulla.
Il passato, rispetto alle opere di questi artisti, è l’arte figurativa che compare ancora, seppur in elementi isolati, nell’opera di De Kooning, mentre nelle tele di Rothko esposte a Roma nulla della realtà oggettiva può essere rintracciato e del resto il pittore di origini lettoni dichiarava di voler rappresentare l’interiorità umana, la sua estasi e la sua disperazione e non certo oggetti, come poteva fare la fotografia. Come risaputo, infatti, l’avvento della pellicola influì molto sulla decadenza dell’arte figurativa, inoltre non va dimenticata la congerie storica in cui sorsero i quadri esposti al Vittoriano: la fine della Seconda guerra mondiale. Gli artisti in questione dipingevano l’indicibilità suscitata da due conflitti globali, avvicendatisi in pochi decenni, e della Shoah, mentre il boom economico nel loro paese – l’Europa nel 1950 era ancora alle prese con le rovine della guerra – voleva far credere che lo sviluppo dell’umanità stava raggiungendo il suo apice. Sì, ma a che prezzo?
Visitando la mostra, soffermandosi sui quadri creati con la tecnica del dripping, dello sgocciolamento, quella di casualità, conseguenza della tecnica stessa, è solo la prima impressione. La trama di quei segni di pittura, infatti, ha una compitezza, una precisione, che comunica un messaggio simbolico chiaro, sull’esistenza di un ordine imprescindibile sul caos, che supera la volontà dell’artista, facendo risaltare la sua impotenza, da una parte, e la sua capacità di abbandono alla verità, dall’altra. Osservando poi le installazioni video che mostrano Pollock al lavoro sul pavimento del fienile della sua abitazione a Long Island risalta la connotazione corporea di quella tecnica, non solo per il movimento del polso, ovviamente cruciale, ma per la tensione delle gambe, che rendono l’atto di dipingere simile a una danza tribale, a un combattimento.
Colpisce che nell’audio guida fornita dal museo ad accompagnare il visitatore nel percorso sia il personaggio della moglie di Pollock, alla quale è dedicata la prima parete dell’esposizione in cui si trova un suo quadro creato con la tecnica del dripping, dalla precisione lampante, e una frase di Peggy Guggenheim che racconta come Lee (Eleonor Krasner) fosse una pittrice che aveva abdicato alla sua arte per occuparsi del marito, anche perché lui stesso glielo aveva chiesto. Non sappiamo, allora, se per una sorta di ricompensa postuma o meglio per perpetuare quel ruolo ancillare che aveva avuto fino alla morte del marito nel 1956, i curatori hanno deciso di affidare al personaggio di lei il ruolo di chaperon nell’esposizione. Certo è che l’artificio retorico funziona, perché quella voce racconta di quel mondo infondendo un senso di familiarità, come sanno fare le buone padrone di casa.
A lasciare interdetti, invece, è l’installazione che conclude la mostra: una tela virtuale su cui muovendo le mani si formano schizzi di pittura, che permetterebbero di creare un quadro «alla Jackson Pollock», come se davvero, come recita il luogo comune, per creare opere d’arte contemporanea non fossero necessarie abilità tecniche o forme di ispirazione. Un ammiccamento all’engagement del pubblico che, oltre a non essere sempre necessario, in questo caso è controproducente.