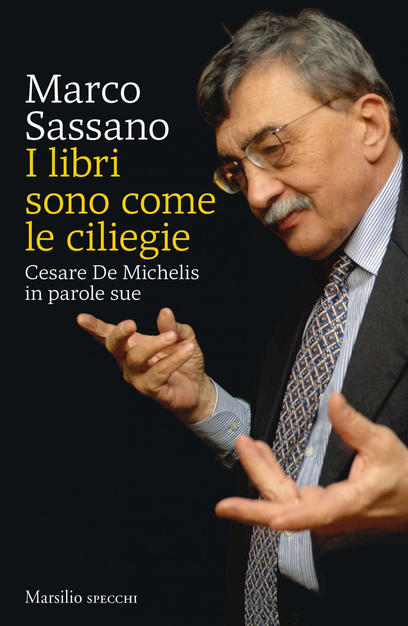«Cesare ride rilassato quando accetta di raccontare la sua nascita e la sua giovinezza. E a guardarlo bene, ironico e brusco come è, gli occhi si inumidiscono quando, con insolita dolcezza, parla dei suoi genitori e della grande famiglia che già da quell’inizio si intuisce gli sarà sempre intorno».
La vita di Cesare De Michelis, storico presidente della casa editrice Marsilio e professore di letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Padova, ha da subito un’onomastica non comune. Il padre, Turno De Michelis, ebbe fratelli che si chiamavano Ilda, Scintilla, Eurialo, Niso, un altro Turno morto appena nato, Fedro, Irno e Miriam. Sono quasi tutti nomi dell’Eneide a parte l’ultimo e il penultimo, che è il nome di un fiume che scorre a Salerno. La madre di Cesare si chiamava Virginia ma fu chiamata per sempre Noemi. E in fine di questa curiosa serie, il nostro stesso Cesare era stato, per l’anagrafe, Rennepont, dal nome di un personaggio di un romanzo d’appendice dell’Ottocento, I Misteri di Parigi di Eugène Sue.
Ora, che destino può avere una persona che abbia in famiglia nomi propri di questo genere? Qualcuno deve naturalmente averlo chiesto a De Michelis, che sembra leggesse in tutto questo «una sorta di allegro destino alla confusione». Che però ebbe forse qualche ruolo, se questo figlio di ingegneri (la madre era stata una delle maggiori esperte europee del plexiglass) decise di occuparsi di lettere e di lingua.
Se è un antico amico, come in questo libro, a scrivere una biografia e a scriverla richiamando spesso le parole vive di De Michelis, essa non può che risultare soggettiva e prodiga di affetto e segreti. E non può non portare gesta e motti memorabili, che danno il metro di una persona che i più riconobbero come straordinaria. De Michelis sfiorò per esempio una carriera politica importante (quella che ebbe per contro il fratello Gianni) e si racconta che a Pietro Nenni, che un giorno, in Piazza San Marco, lo esortava a dargli del tu, il giovane Cesare avesse risposto «Onorevole, non ho dimestichezza a dare del tu alla Storia».
Gran parte del libro è dedicata all’attività di professore di letteratura e a quella di editore, che aveva avuto avanguardie molto precoci, tra le quali un paio di riviste di critica fondate insieme a Massimo Cacciari, e che ha avuto nella Marsilio il suo traguardo più definito. E ciò per ben due «tornate»: l’entrata negli anni Sessanta con un capitale azionario portato in parte dal fratello Gianni e in parte, in dono per la laurea con Vittore Branca, dal padre Turno; e la riacquisizione quasi politica nel 2016, dopo quindici anni di gestione della Rizzoli e dopo che quest’ultima azienda si era unita, con ben nota aggregazione, alla Mondadori.
Dice già molto, di questa vicenda così lunga, l’immagine che Marco Sassano ci rende della sede storica della Marsilio, a ridosso di Piazzale Roma, al punto estremo dell’arrivo delle automobili, prima di entrare nell’acqua. «Nessun luogo migliore poteva ospitarla, se non l’antica capitale dei libri e la famosa Casa rossa della zona portuale, al confine tra canali d’acqua e marciapiedi. Al crocevia di una storia gloriosa e di un sentimento che l’intelligenza del cuore assimilerebbe a quell’attesa paziente con cui un editore si mette sulla riva del mare e aspetta manoscritti in bottiglia».
Viene da dire che la vita di Cesare De Michelis sia stata un’epopea della letteratura, e che egli stesso sia stato, della letteratura, una sorta di eroe. Quanto serve, la letteratura? E se serve, serve a vivere? «Ci troviamo impotenti ad affrontare una nuova crisi. Noi pensiamo che questa crisi sia un problema degli economisti e dei politici, invece è un problema dei letterati. È come la peste del Trecento da cui nacque l’umanesimo. Ma quella peste non la vinsero i medici, la vinse il Decameron di Boccaccio».