«Non voglio che il mio Mimotchka diventi un pliasoon». Mimotchka era il vezzeggiativo di Mikhail Mikhajlovic Fokin, divenuto mondialmente celebre con il nome francesizzato di Michel Fokine. I ricordi del celebre ballerino, docente e coreografo russo, disponibili in traduzione italiana (Memorie di un coreografo), raccontano come Mimotchka non finì a ballare danze folcloristiche o a fare il guitto in spettacoli di varietà (pliasoon). Mikhail assorbì la passione per la danza dai fratelli ballettomani, Sonia e Kolia – quest’ultimo gli racconta i romanzi di Jules Verne e Guerra e Pace, stimolandolo a interpretare tutti i personaggi. Il maggiore Vladimir, attore di commedie, farse e operette, trasformista talmente abile da rendersi irriconoscibile in camerino anche al fratello, gli impartisce una lezione fondamentale: «anche il teatro leggero comporta duro lavoro ed esige la capacità di trasformarsi». Un altro fratello Sasha, ciclista provetto e rematore, gli instilla il culto per l’esercizio fisico e la competizione. Tutte queste influenze sono all’origine del clamoroso rifiuto di Fokine di «un teatro in generale stereotipato, in cui ogni cosa è stabilita una volta per tutte».
Prima di criticare le Regole, studia profondamente il balletto classico come allievo, ballerino e docente del Balletto Imperiale di San Pietroburgo, convincendosi che «mantenere la grazia e la bellezza contenute nelle braccia arrotondate, nelle dita vicine e nel sorriso affettato costituisca una distorsione estetica». La sua partner dell’epoca, la divina Anna Pavlova per la quale scriverà l’assolo forse più celebre della storia della danza (La Morte del cigno), gli risponde: «così si fa», perché «piace al pubblico».
Fokine sente che chi balla rivolgendo lo «sguardo supplichevole alla balconata per aspettare consensi da questa fonte», non è credibile. Anche un ballerino deve ampliare la sua cultura. Appena racimola un po’ di rubli, viaggia. Si spinge nel Caucaso per ammirare le danze locali; scende nel museo-Italia per vedere templi, quadri, bassorilievi («leggere nei bassorilievi aiuta a risalire al movimento che è sfociato in una determinata posa»), pitture vascolari, affreschi; a Parigi fra i clienti della sua pensione, russi emigrati con propensioni rivoluzionarie (Bakunin & Co.), sente che la riforma della danza è qualcosa che va verso il popolo. Entra in un gruppo di suonatori dello strumento nazional-popolare russo per antonomasia, la balalaika: sono così bravi che il celebre direttore tedesco Arthur Nikisch li dirige nello Scherzo pizzicato della Quarta sinfonia di Čajkovskij.
L’allargamento degli orizzonti culturali e la passione per la pittura esercitata in prima persona, portano Fokine a proclamare principi diventati caposaldi della danza moderna: la conformità della coreografia con l’epoca rappresentata e quella della danza pantomimica con lo stile rappresentato; l’abbandono delle punte per sandali o piedi nudi; l’attenzione alla congruenza del costume alla trama. Basta applausi e ringraziamenti durante l’esecuzione.
Creazione decisiva fu il «primo balletto astratto» (senza trama): Les Sylphides da Chopin, dove il non ancora divo Vaslav Nijinskij «emergeva come personificazione di una visione poetica»: si attendeva il ballerino non per fare «doubles tours en l’air, préparation e pirouette», ma per la sua espressione. «Non danzare per te, metti in evidenza chi ti sta attorno, le eteree silfidi», raccomanda Fokine. «Guardale mentre danzi, ammirale, cerca di arrivare a loro! I momenti di desiderio e la volontà di raggiungere un mondo irreale sono alla base dei movimenti e delle espressioni di questo balletto».
Il coreografo Fokine unisce danzatore classico e di carattere in uno spettacolo dove tutte le arti convergono. Naturale che si interessi e accenda l’entusiasmo dei pittori del gruppo «Mir isskustva», soprattutto Alexandr Benois e Léon Bakst, raccolti intorno all’editore e futuro impresario Sergej Djagilev, «uomo di energia fenomenale e straordinarie capacità organizzative». La storia ha dimenticato il ruolo determinante di Fokine nel creare il repertorio che fece esplodere i Ballets Russes come il fenomeno artistico di punta del primo Novecento.
Traduce la potenza espressiva del corpo di ballo per le Danze polovesiane dal Principe Igor: il pubblico entusiasta scardina la ringhiera dell’orchestra del Théatre du Châtelet. Utilizza con genialità una storia diversa da quella pensata dal compositore in Shéhérazade di Rimskij-Korsakov codificando una danza di gesti sintetici e chiari che esprimono l’azione senza equivoci (duttili strumenti interpreti leggendari: Ida Rubinstein e Nijinskij, Enrico Cecchetti, Vera Fokina e Bronislava Nijinska). Trasforma il duttile Nijinskij nell’ambigua marionetta umanizzata Petruška, ricevendo i dettagli della trama poco prima dell’andata in scena.
Inventa ex novo il libretto per quello che diventerà un capolavoro della musica di Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, purtroppo sabotato da Djagilev che ha deciso di trasformare il suo favorito Nijinskij nel nuovo coreografo dei Ballets Russes attraverso lo scandalo del Fauno erotico da Debussy.
Nell’opera Il Gallo d’oro di Rimskij prima mette i cantanti in buca, poi li sostituisce con strumenti: sul palcoscenico i ballerini danzano un gioiello coreografico ispirato alle tavolette contadine russe (lubok), ai giocattoli di legno, alle posizioni di vecchie icone, a pitture di frammenti murari e ricami artigianali. Quando torna a vedere da spettatore il suo balletto forse più famoso, L’uccello di fuoco, osserva i cambiamenti fatti da Djagilev: i suoi passi sono diventati «automatismi».
È l’amaro destino dell’Arte coreografica: «quanto più un balletto gira nel mondo, tanto più si deteriora; quanto più rimane in repertorio, tanto più si allontana dalla sua versione originale».
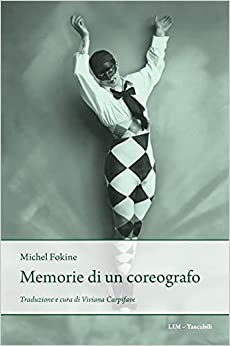
Bibliografia
Michel Fokine, Memorie di un coreografo, a cura e traduzione di Viviana Carpifave, Lucca, LIM, 2021, pp. 373.
Dalle memorie di un genio della danza
Le straordinarie visioni del ballerino, coreografo e docente russo Michel Fokine in un libro autobiografico
/ 11.10.2021
di Giovanni Gavazzeni
di Giovanni Gavazzeni





