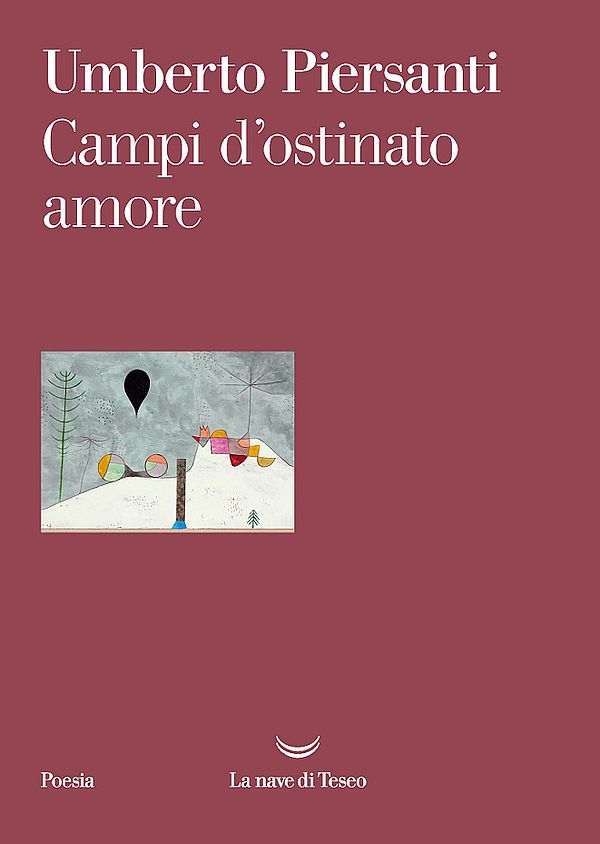Umberto Piersanti tocca con Campi d’ostinato amore un picco nella sua produzione poetica, difatti nel libro risuonano le sue tante interne voci che avemmo modo di udire nelle passate raccolte, ma in qualche modo esse ora, è come se, continuando quell’acuminato discorso in bilico tra natura e memoria di una comunità, lo restituissero una volta per tutte, con immagini chiare e nitide tanto che la poesia che le alimenta, stimola prima che l’intelletto del lettore, la sua parte biologico-emozionale.
E delle molte figure che si danno appuntamento in queste pagine, talune provengono dalla stessa identità del poeta, ma ognuna di queste, proprio perché appartenente a tempi assai diversi, è come se avesse cucita nel DNA la figurazione di uno specifico mondo e ritrovasse proprio nell’hic et nunc del verso lo spazio dialogico d’incontro con le altre da sé: «… // tu non sai / le vicende e le figure, / solo suoni e colori, / non li ricordi, / non sai se la madre / s’appresta a consolarti / dall’esser nato / o se la vita saluti / e bevi a sorsi lunghi / dopo quel limbo caldo, / ma vicino, / così vicino / al Vuoto che tutto / precede // …».
Allora l’acceso e sempre toccante lirismo di memoria assolutamente leopardiana, anche nella ripresa di talune parole-pensieri chiave, si spariglia tingendosi di regole e spazi nuovi: l’io del poeta diviene talvolta come accennavo un tu, ma le sue interne figure naturalmente non sono le sole parlanti ed evocanti immagini. Difatti ritroviamo affrescate nelle pagine anche certe donne e uomini che s’aggirano come in un planetario, nella mappa storico sentimentale dello scrittore.
E in quale luogo d’elezione questo folto popolo di presenze si dà appuntamento? Nello spazio della natura, dove continua a essere immanente la voce dell’origine di ogni cosa, ma anche vi rintocca quella dei suoi precari camminatori presenti e passati, che sembra trascolorino fragili dentro quei toni invece sempre accesi di ogni cresta alberata, pendio montano che come contrappunto rifulge così altero e austero rispetto alle conflittualità degli uomini: «… // greppi, greppi amati / più non salgo / tra voi / col vento in faccia, / anche sul piano / ora arduo è il cammino, / goffo ed incerto / striscia il passo / sul terreno, / … // solo un poco / conforta la memoria / dei greppi luminosi / e le vicende / così perse e remote, / così presenti».
Questo sottile sbiadire, non solo attiene alla vicenda psicologico-memoriale ma anche a quella fisiologico-vitalistica, e per il poeta rientrare nella forra naturale, anche in condizioni di precarietà, vuole dire ancora essere in un giro vorticoso che lo proietta, anche se per poche ore, fuori dagli anni, sempre più incombenti e dove talvolta il dolore è la punta aguzza sotto il piede di ogni passo. La pagina della natura cheta in qualche modo come elisir il suo poeta, lo accoglie come eterno sposo.
E allora la scrittura di Piersanti, nella progressione del libro, sembra acquisire il tono di quei lontani e grandi poeti latini, su tutti Cicerone e ancor più Ovidio, perché cammina sul crinale sempre erto dell’esilio, l’esilio dalla felicità continuamente spezzata dalle prove ardue dell’amato Jacopo: «… / ma il tuo male / figlio delicato, / quel pianto che non sai / se riso, stridulo / che la gola t’afferra / più d’ogni artiglio, / questa bella famiglia / d’erbe e animali / fa cupa / e senza senso / e dolorosa // siamo scesi un giorno / nei greppi folti, abbiamo colto more / tra gli spini, / ora tu stai rinchiuso / nelle stanze / …», l’esilio «dall’antico» come insieme di storie e spazi linguistici remoti che più verranno, l’esilio infine dalla forza vitalistica dell’infanzia, luogo mistico e assieme materico di insuperabile bellezza.
Ma in questi campi d’ostinato amore, il poeta ostinatamente continua a tornare, per pareggiare i conti con la propria vicenda addolorata, anche nell’ultimo tempo pandemico; difatti gli alti confini boscosi, sempre ridisegnano ai suoi occhi quelle patrie lontane che leniscono gli spasmi della storia intesa come mera progressione dei tempi. E mi sembra di vederla, sotto uno sguardo lacerato, la bocca del poeta, pare ancora tra quei crinali spezzarsi in un sorriso, poiché lì il perduto continuamente torna a disvelarsi e a indicare un sentiero: «… // oltre quello stradino, dentro la casa / ridotta a un muro incerto / come quei volti sacri / oramai nell’aria / trascolorati e infissi, / quell’età immortale / tra le valli / continua a risuonarti / dentro il sangue».
Ecco nell’opera di Umberto Piersanti, la vita affacciarsi come mistero insoluto, l’esistere pur greve che sia, esser sempre benedetto, perché unica nostra vera gloria.