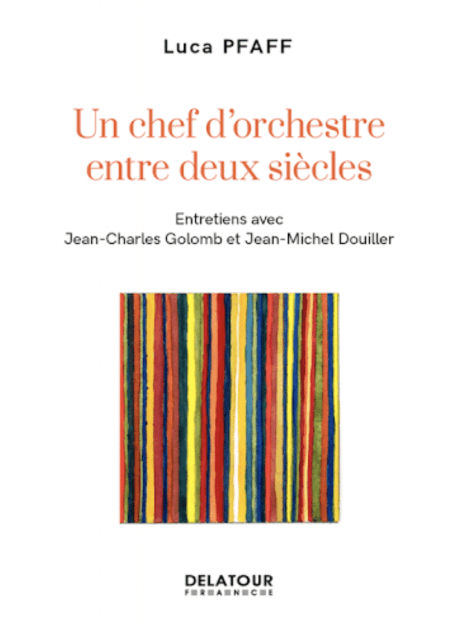Un chef d’orchestre entre deux siècles. Il titolo che ha scelto per il suo recente libro mette a tema l’elemento determinante la biografia, non solo artistica, di Luca Pfaff: per il musicista ticinese (è nato a Olivone 77 anni fa) il podio è stata una predestinazione suggerita da una voce interna più che segnata da circostanze o incontri. «Mio padre era ingegnere, ma amava il pianoforte; dopo il lavoro si metteva alla tastiera e così conobbi Schubert, Schumann, le sonate di Beethoven. Quando ci trasferimmo a Locarno andavamo ai concerti delle Settimane Musicali, ma al tempo non c’erano orchestre. Mi piacevano i solisti e i gruppi da camera, ma ancor più un disco che avevamo in casa, un 33 giri con i valzer di Strauss, quelli del Capodanno di Vienna; non avevo mai visto neanche alla televisione un’orchestra o un direttore, ma, avevo 4 o 5 anni, giocavo a dirigerli».
Così fu anche nel percorso di studi: «Iniziai col violino, ma non riuscivo a sopportare le note stridule che producevo, così virai sul pianoforte: posso suonare un fa invece di un mi, ma almeno è un fa intonato. Nelle intenzioni di mio padre doveva essere un passatempo, così iniziai medicina a Basilea, ma dopo cinque semestri capii che la mia strada era la musica. Grazie a Giulio Cesare Sonzogno incontrai il direttore del Conservatorio di Milano; mi disse che a 22 anni sarebbe stato troppo tardi per uno strumento, ma per la direzione si poteva fare».
Il talento emerse subito: Pfaff bruciò le tappe e dopo quattro anni era a Vienna da Swarowski, mito del podio; suoi compagni di corso furono personalità come Sinopoli. Tornò a insegnare, ma solo per sei mesi; intanto Pfaff era andato a Roma da un altro grande didatta, Franco Ferrara. Fu lì che iniziarono i concerti pubblici. «Dell’Ongaro (oggi direttore artistico di Santa Cecilia, ndr.) e Zaccagni avevano creato Spettro Sonoro, ensemble dedito alla musica contemporanea; poi arrivarono gli ingaggi dai compositori francesi come Dusapin ospitati a Villa Medici; e da Santa Cecilia».
Progetti indimenticabili «come l’opera omnia di Nietzsche, una quarantina di minuti di musica orchestrale che presentammo assieme agli scritti del filosofo; la collaborazione con Fellini per Casanova; soprattutto il rapporto profondo con Giacinto Scelsi, nobile di famiglia e compositore di cui incisi varie opere. Però, dopo quattro anni, questa attività iniziava ad essere ripetitiva. Mi venne spontaneo accettare gli inviti dei francesi e andai a Parigi con la mia ragazza, ospitati da un amico».
La carriera di Pfaff è continuata concentrandosi soprattutto sul repertorio novecentesco e contemporaneo, ovviamente affrontando anche il grande repertorio, Beethoven e i romantici, interpretati a capo di gruppi prestigiosi come Tonhalle di Zurigo, London Sinfonietta, Orchestre Nationale de France e l’Ensemble Intercontemporain fondato da Boulez. Sono tante le serate memorabili vissute sul podio, tutte segnate da un climax emotivo: «Il grande direttore è quello che durante il concerto riesce a creare un crescendo di intensità per poi scemare verso la fine; pensiamo alle sinfonie di Mahler dirette da Abbado a Lucerna, magiche. Delle mie, ricordo alcune sinfonie di Sibelius, in particolare la quarta e la settima. È un po’ come andare in montagna: c’è l’ascesa, cambiano le sensazioni, la percezione di sé e di ciò che sta intorno, poi si ridiscende e si torna alla normalità».
Per Pfaff la metafora alpinistica non è casuale: «Esser nato e cresciuto a Olivone mi ha reso familiare la dimensione della montagna. Con tre amici sono andato in Himalaya; campo base a 4mila metri, volevamo arrivare a 7200 ma a 6500 abbiamo capito di essere al limite: basta poco per avere un enfisema polmonare e morire, e basta scendere di appena 100-200 metri e rimettere tutto a posto. Quando sei così in alto cambiano le percezioni: l’aria è così rarefatta che tutto sembra vicino, a due ore di cammino, e dopo due ore la distanza non sembra essere diminuita affatto. Scelsi mi evocò l’Himalaya per spiegarmi come dovesse suonare un suo brano che avevo inciso e che stavamo ascoltando a casa sua: voleva che le trombe suonassero forte anche se non l’aveva scritto in partitura perché doveva avere l’effetto dell’immensità degli spazi himalayani. Anche Messiaen scrisse Et expecto resurrectione mortuorum per soli fiati e percussioni perché aveva in mente il ghiacciaio della Meije; ho cercato tre volte di portare l’orchestra sul ghiacciaio per eseguirlo, ma il tempo non è mai stato favorevole. E la montagna va rispettata oltre che amata. Come la musica».
Bibliografia
Luca Pfaff, Un chef d’orchestre entre deux siècles. Entretiens avec Jean-Charles Golomb et Jean-Michel Douille, Ed. Delatour, Parigi, 2021.