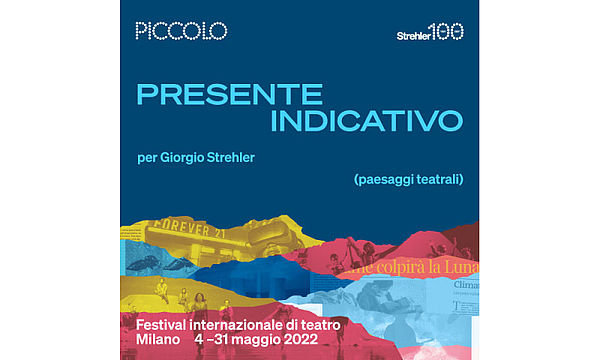Dei 25 spettacoli in programma al Piccolo di Milano dal 4 al 31 maggio, nell’ambito del Festival internazionale «Indicativo presente»: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali), ne ho visti in tutto 10. In due precedenti articoli di «Azione» ho parlato di Zoo, testo e regia del franco-uruguaiano Sergio Blanco (che vive e lavora a Parigi), di The Future, testo e regia dell’argentina Constanza Macras (che vive e lavora a Berlino), e di Los años, testo e regia dell’argentino Mariano Pensotti (attivo a Buenos Aires). Ora vorrei dire qualcosa su L’aventure invisible, testo e regia dello svedese Marcus Lindeen (Angelholm,1980) e su Wakatt, ideato e coreografato dal burkinabé Serge Aimé Coulibaly (nato a Bobo-Dioulasso, e attualmente operante a Bruxelles e nel Burkina Faso con la compagnia Faso Danse Théâtre, da lui fondata nel 2002).
Terza parte della Trilogia delle identità (recentissimamente pubblicata in versione italiana da Il Saggiatore), L’aventure invisible è divisa in quattro sezioni, precedute da una breve parte introduttiva, e ha tre personaggi denominati il paziente, la scienziata, l’artista. La scena è una gradinata circolare, al centro della quale c’è una sorta di piccola arena che gli attori ogni tanto attraversano per spostarsi da un punto a un altro del primo cerchio, dove siedono tra gli spettatori.
Il paziente è un uomo di 45 anni nato con una rara malattia genetica (il nome scientifico è neurofibromatosi) che gli deformava disgustosamente la faccia. Ora, dopo un doppio trapianto eseguito da un chirurgo plastico di Parigi, ha il volto di un ventenne. La scienziata è una neuroanatomista americana (docente presso la Pitié-Salpêtrière di Parigi) che nel 2002, all’età di 37 anni, ha avuto un ictus nella parte sinistra del cervello. L’artista è una donna di età imprecisata che pur essendosi fatta togliere chirurgicamente il seno, ha evitato una radicale scelta transessuale e si è dedicata a ricreare cinematograficamente le immagini di Claude Cahun, scrittrice e fotografa surrealista francese vissuta negli anni Venti, la quale aveva convissuto fino alla morte con la sua compagna, assumendo al posto del suo vero nome, Lucy, un nome epiceno (cioè ambigenere): Claude.
Nel testo di Marcus Lindeen (nato dall’elaborazione di tre interviste, e con l’apporto della dramaturg Marianne Ségol-Samoy), i tre personaggi raccontano i loro casi nei modi di una conversazione pacata, interrogandosi e dandosi reciprocamente delle risposte. Il paziente parla dell’estremo disagio di vivere con una faccia da cui gli altri distoglievano lo sguardo, e successivamente degli interrogativi suscitati dalla propria immagine riflessa e dal vivere in società con il volto di un altro. La scienziata descrive gli effetti avvertiti a livello fisico e cognitivo subito dopo l’ictus, e il lungo percorso intrapreso per reimparare, avendo perso la memoria del proprio passato, a essere sé stessa, o meglio: «per sapere come comportarsi in quanto me». Mostrando e commentando le immagini fotografiche di Claude Cahun e le proprie ricreazioni cinematografiche (visibili su due monitor posizionati al di sopra del pubblico), l’artista dice di essersi quasi identificata con Claude e di essere arrivata alla conclusione che «in termini di genere la scelta più coraggiosa che si possa fare è non fare scelte».
Qualificare col termine «pacata» la conversazione dei tre personaggi mi sembra giustificato dal volume costantemente basso delle voci oltre che dall’estrema sobrietà di gesti dei tre bravi interpreti (Claron McFadden, Tom Menanteau, Franky Gogo). Questo tipo di recitazione, a mio parere, è anche conseguenza di una scrittura che a fini di chiarezza comunicativa persegue la piena normalizzazione grammaticale e sintattica del discorso, sacrificando altresì le variazioni di registro e il peculiare andamento delle singole parlate (come avviene di norma nelle interviste giornalistiche).
È impossibile non rilevare come nello spettacolo di Marcus Lindeen – dove il tema dell’identità è strettamente legato a quello del corpo – gli attori facciano un uso limitatissimo dello strumento corporale. Che viene invece esaltato nello spettacolo di Serge Aimé Coulibaly. Il quale ha dichiarato che al fondo di Wakatt (parola che significa «tempo presente») c’è il tema della paura (effetto e causa dei conflitti) e quello della necessità di abbattere muri e costruire ponti. Detto così, suona un po’ vago, generico, astratto. Ma in Wakatt non c’è nulla di dimostrativo, di predicatorio, di didascalico.
C’è invece la concreta e plastica presenza dei corpi (maschili e femminili, vestiti o seminudi), che sia quando si scontrano o si agitano convulsamente, sia quando trovano brevemente quiete (accompagnati da affascinanti musiche dal vivo), risultano animati da una straordinaria vitalità. E non c’è nulla di vistosamente folklorico nel vocabolario corporale dei danzatori. Al più, per fare un esempio, dei movimenti che a volte fanno pensare alla trance.