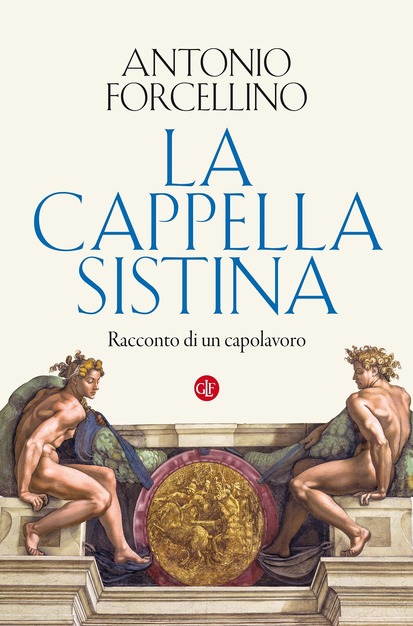Nuova educazione sentimentale per ragazzi: è il sottotitolo del testo di Francesco Pacifico Io e Clarissa Dalloway, parte della collana PassaParola di Marsilio, una raccolta di testi in cui uno scrittore o un’autrice «raccontano del mondo e di sé partendo da un libro». Pacifico di libri ne sceglie due: Il rosso e il nero di Marie-Henri Stendhal e La signora Dalloway di Virgina Woolf. Il mondo che osserva è invece quello della società patriarcale che racconta dall’interno, in quanto uomo in un sistema maschilista.
L’opera è il frutto di una lettura dei due romanzi perpetuata negli anni, che lo ha condotto a un punto di approdo: l’azione sentimentale di Julien Sorel, il suo modo di amare, come quello di Pacifico stesso e di miliardi di altri uomini, manca di qualcosa che Clarissa Dalloway e Virginia Woolf invece posseggono: il contatto, la consapevolezza dei propri desideri. E seppur si tratti di una conclusione che appare astratta, nel testo essa è chiaramente illustrata a partire da immagini molto chiare. Per esempio, il rifiuto maschile, anche inconsapevole, di ascoltare la persona amata, l’impulso irrefrenabile di giudicare: «l’amore ti mette davanti alla responsabilità di doverle spiegare come funziona davvero il mondo. Ti tocca rimproverarla per il suo conformismo, la sua stupidità! Quanto ti piace darle della stupida».
Il libro è un confronto puntuale e simpatico tra i due romanzi, a partire da un’analisi testuale rigorosa. I primi capitoli raccontano per lo più una visione della letteratura: Pacifico sottolinea con sapienza come la prosa di Woolf si fondi sul tempo inteso come alternanza e accostamento di immagini e quindi parole. Poi insiste sulla necessità di sfatare un luogo comune dominante, secondo cui un buon libro sarebbe quello che scorre: «come se l’unico modo di fare esperienza positiva delle cose della vita fosse la velocità. Lentezza uguale noia. Ma la letteratura e il suo piacere nascono dalla noia».
Lo spostamento sulla questione dell’educazione sentimentale e quindi inevitabilmente sulla guerra dei sessi avviene a partire dal capitolo «Softboi». Si tratta di un’espressione che Pacifico ha trovato esemplificata nell’account instagram beam_me_up_Softboi. Softboi è il termine moderno che sta per: «ragazzo sensibile». Pacifico ci dimostra che Julien Sorel è un softboi, come Peter, il giovane che Clarissa Dalloway lasciò per sposare Richard e che rincontra dopo molto tempo. E lui stesso, l’autore, si colloca tra i ragazzi sensibili.A partire dall’appartenenza condivisa a questa pericolosa categoria, senza mai tralasciare il testo di Virginia Woolf che è diventato protagonista assoluto doppiando Stendhal, l’autore sancisce alcune verità rare: «il patriarcato si regge sull’arco delle sopracciglia di un uomo ragionevole, che all’ennesima intemperanza di una donna fa: “mi pare un po’ esagerata come reazione...”».
Così, attraverso lo strumento della critica letteraria e di un’analisi della realtà sociale, Pacifico riesce a mostrare come l’educazione sentimentale dei maschi contemporanei assomigli a quella di Julien Sorel o di Peter, protagonisti di due romanzi scritti all’inizio del XIX e del XX secolo. Essa si basa sulla condanna, sulla totale incomprensione delle donne, ma anche su un’intrinseca impossibilità di essere felici, perché gli uomini programmati così si trovano lontani dal loro desiderio: agiscono in nome della conquista, che non è la voglia ma una necessità imposta.
Al contrario, nello spirito di Clarissa, nelle sue parole, nella visione di Woolf emerge una capacità di saper contemplare la morte che si accompagna alla possibilità di gioire per le cosiddette «frivolezze», come la festa che sta organizzando, per cui Peter e suo marito la rimproverano. Il suo essere felice, senza un’eredità o terre e potere da amministrare, si realizza con «un po’ di libertà, un po’ di indipendenza».