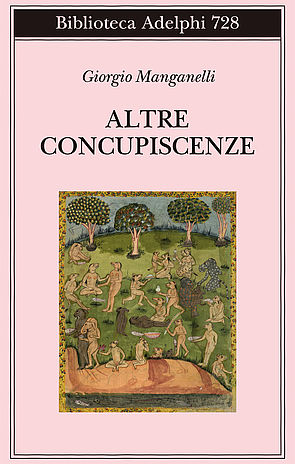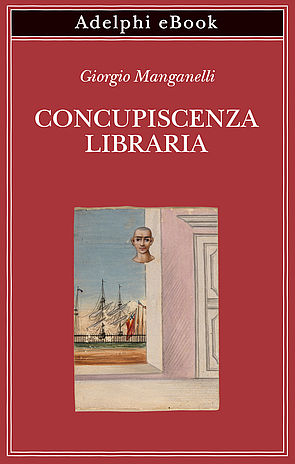Un’antologia era, per Giorgio Manganelli, «una legittima strage», uno strazio autorizzato nel corpo vivo dell’opera di uno scrittore. Ci credeva e non ci credeva, se è vero che pianificò per sé alcune selezioni prelevate dalla sua vastissima attività di critico e di recensore: Laboriose inezie, dedicato all’arco lungo tra Omero e Collodi, pubblicato nel 1986, e il novecentesco Hoggidiani, che invece non vide mai la luce nonostante fosse giunto a una fase avanzata di elaborazione del progetto. Da quell’ideale mancato è partito Salvatore Silvano Nigro per immaginare, in due tappe, una raccolta delle recensioni manganelliane mai apparse in volume: il primo tomo, Concupiscenze librarie, è uscito da Adelphi nel 2020 in occasione dei trent’anni dalla morte; il secondo invece, per il centenario della nascita, fresco di stampa, porta il titolo complementare di Altre concupiscenze e più che un ulteriore volume pare infatti una succosa appendice del primo.
A chi si chiedesse che tipo di recensore fosse l’autore di Hilarotragoedia, linguista di formazione, nonché il più tradizionalista tra i protagonisti dell’avanguardia letteraria italiana degli anni Sessanta, si potrebbe rispondere tranquillamente che fu un recensore atipico, e proprio per questo sommamente interessante e meritevole, a decenni di distanza, delle nostre attenzioni. Fu innanzitutto un lettore accanito e vorace, con la giusta dose di erudizione e di spregiudicatezza, miscelati in un mix originale e sapiente. Lui stesso un teorico del genere, riteneva la recensione un esercizio solo in apparenza minimo, anzi, nobilmente «minore», una letteratura nella letteratura capace di veicolare il giudizio critico per mezzo di una retorica assai prossima a quella della narrazione. Soprattutto, la recensione era un genere dichiaratamente disonesto e fazioso, perché ancorato al punto di vista dell’io che legge, giudica e infine condivide. Senza che questo rappresentasse per lui il benché minimo problema, semmai un valore aggiunto: «Se io fossi un “praziano” (dopo tutto, ho perfino finto di fare l’anglista) sarei, con queste pagine, del tutto felice; ma non lo sono, e mi chiedo perché. Mettiamo in conto la mia naturale rozzezza…» (Concupiscenze librarie, p. 79).
Nel montare questa ricca selezione a due ante, nella quale si apprezzano gli accostamenti brillanti e gli impliciti e sotterranei percorsi di lettura, Salvatore Silvano Nigro ha provato a dare ragione della «fame» di Manganelli, del suo essere onnivoro e insieme feticista, un librofilo passionale e goloso sin dal primo contatto (fisico, tattile) con le opere di carta stampata. Si vedano ad esempio le pagine dedicate alla collana di tascabili Penguin, oppure alla nuova copertina del Giovane Holden o ancora alla Parola dipinta di Padre Giovanni Pozzi: «Prima di toccare, come mi sarà possibile, della materia del libro che mi sta ora davanti, desidero discorrere brevemente della “cosa” fatta di pagine scritte che reca quel titolo. È un libro, in primo luogo, solido, ben legato, di quattrocento pagine, del peso di circa settecento grammi. Quando lo si apre, produce quel lieve, delizioso scricchiolio libresco, che Charles Lamb pretendeva di ascoltare anche nell’alto dei Cieli» (Concupiscenze librarie, p. 84). Quest’ultimo caso è invero esemplare, perché parlare della scatola (la «cosa») è già un omaggiare e un interpretare il contenuto del testo di Padre Pozzi, incentrato proprio sulla forma dei testi nella storia.
Un critico di questa finezza, costretto per ragioni professionali a divenire «un lettore veloce di libri lenti», non poteva perdere troppo tempo con la letteratura di consumo («La cruna dell’ago di Ken Follett è un eccellente thriller, ma se tolgo la trama resta la pagina bianca») e si trovava inevitabilmente più a suo agio in mezzo ai classici, continuamente riproposti e «recensiti» quasi fossero delle vere e proprie novità librarie. In quella che Nigro definisce una «turnée grandiosa» durata un cinquantennio attraverso le principali testate italiane (dal «Mondo» a «Tempo presente» a «L’Espresso» passando per «Il Messaggero» e il «Corriere della Sera»), Manganelli si è fatto paladino di riscoperte e valorizzazioni senza cedere mai alle mode del momento, bensì inseguendo un suo personale pantheon di scrittori forti e non per forza canonici, anzi, aperto persino a quelli scomparsi da poco o agli autori di un solo libro. Un atteggiamento, il suo, che noi lettori ticinesi di «Azione» dovremmo poter cogliere e apprezzare al volo, poiché è quanto di più simile alla postura critica e morale di un Giovanni Orelli, colui che non per nulla, in quarant’anni di peregrinazioni letterarie altrettanto vaste e curiose, è stato una sorta di Manganelli dislocato al di qua del confine.
Bibliografia
Giorgio Manganelli, Concupiscenze librarie, Adelphi, Milano, 2020
Giorgio Manganelli, Altre concupiscenze, Adelphi, Milano, 2022