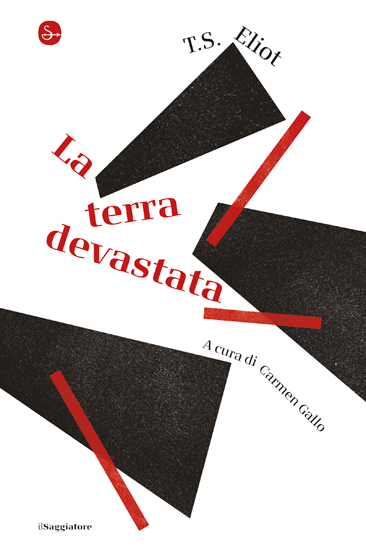Leggendo la traduzione di The Waste Land di Carmen Gallo (ilSaggiatore) sembra di avere sempre ascoltato T.S. Eliot attraverso una parete di cartone che ovattava i suoni e ora ci fosse tolta. Sorpresi nudi siamo noi lettori, incantati dal vecchio canto senza essere ascoltati a nostra volta, non visti, come non meritassimo di vivere nella mente del poeta, abbiamo fatto del godimento una lasciva abitudine da camera. Ma Eliot, visionario del visibile, che pur di permettere all’anima di volare nel solo cielo di cui il Novecento disponesse – ed è l’impossibilità di staccarci dalla storia – instauratore di una mistica rovesciata dove il mito irrompe, sì, ma come il grande entra nel piccolo per renderlo abitabile, ha sempre lavorato alla ricerca di un dialogo con i suoi contemporanei di cui noi facciamo parte, fornendoci gli strumenti per rimettere insieme una civiltà che sta crollando.
Un errore di natura scolastica finalmente corretto è pensare che l’ampio uso che fa del mito avrebbe lo scopo di rendere autorevole quale critica del Novecento il volgergli le spalle; una sorta di snobismo razionale che pone il tempo corrente gerarchicamente inferiore al tempo classico e che in questo consisterebbe il suo conservatorismo. Il mito serve a Eliot per trovare ossigeno nel tempo soffocato dalla guerra mondiale appena conclusa e dal terrore per il futuro dell’Europa. Mette in luce le fughe del tempo più che i ritorni. Non separa il sempiterno dal caduco ma ne denuncia il rovesciamento non attraversabile se non «puntellando le rovine». Se l’oggi è materia che ferisce, chi lo vive sarà moralmente teso a trarne conclusioni, che sono di ricerca e non ideologiche. Se l’attualità è solo rumore di fondo – ci dice Eliot oggi più chiaramente – lo è al punto da invadere tutta la percezione, e la falsificazione che il reale subisce si attesta quale evento centrale dell’opera.
Ora, se questo era già contemplato dalla critica, lo era come dato ricavato, mentre adesso possiede una evidenza totale nel testo. Le percentuali di mito e contemporaneo si riequilibrano; i vettori stilistici dell’opera originale affiorano nell’italiano senza interferenze, giacché Gallo non lavora sulla voce di Eliot come personalità ma come esito di un procedimento artistico attento e scientifico. Sebbene egli giunga a conclusioni morali severe, non le anticipa mai, come potrebbe fare solo chi all’indagine storica anteponesse convinzioni aprioristiche. A rileggere ora le vecchie traduzioni ci pare invece di trovarne delle anticipazioni già nei primi versi.
Ciò dipende dal fatto che la comprensione che i traduttori precedenti hanno avuto di quest’opera, approcciandola più come opera filosofica che non poetica, li ha indotti a enfatizzarne il lirismo, impagliandola di alloro. Malinconicamente hanno lasciato che vi si posasse sopra una coltre di polvere. Desolati, loro sì, di non poter fare meglio, hanno più o meno consapevolmente aggiunto alla devastazione della Terra un velo di impotenza che tanto somiglia a quella storica con aggiustamenti retorici, automatismi e meccanismi di maniera, di fatto preferendo la musicalità alla musica, la poeticità alla poesia e alla lingua piana e sorvegliata; dove gli oggetti del presente precipitano come fenomeno atmosferico, cenere e lapilli che scendono leggeri sul mondo, una neve oscura e non già il frutto dell’azione dell’uomo, su cui invece Eliot mette tensione.
Ora la sua voce è meno suadente ma decisamente erotica, non più omologata alle novità del ritmo da lui stesso introdotte ma a cui fino a oggi è stato ricondotto facendone il ripetitore di se stesso. Riaffiorano i numerosi registri linguistici, le polifonie dei personaggi, il cui realismo non è più estetizzazione romantica ma coscienza vivente. Certi vizi delle altre traduzioni, come le rime interne utilizzate per rafforzare qua e là ciò che già va da sé ora cadono. I nervi non sono più «irritati» ma «a pezzi», la City di Londra in quanto centro finanziario è correttamente «City» e non «Città», la «brown fog» è giustamente «marrone» per l’inquinamento e le «combinations» non sono quelle astratte visioni che si è sempre creduto ma le «sottovesti» dell’ultima moda.
Questa di Carmen Gallo non è una riattualizzazione. Non è il vocabolario lo strumento che ha tenuto più vicino a sé durante la traduzione; semmai, a media distanza, immagino manuali di storia e di linguistica, e accanto, vicinissimi, nel piano, pianissimo delle regolazioni minime, gli strumenti della poesia stessa.