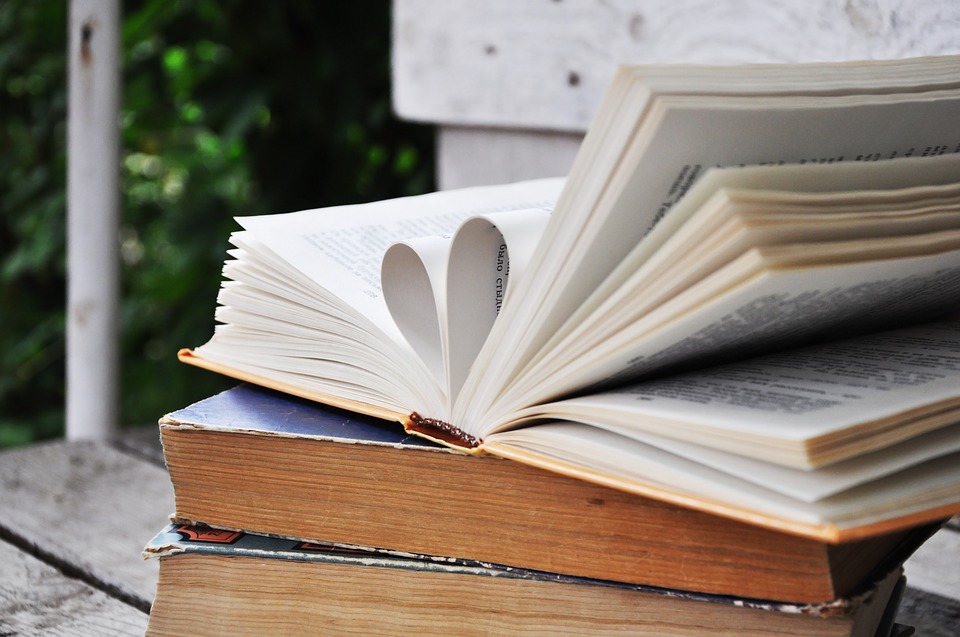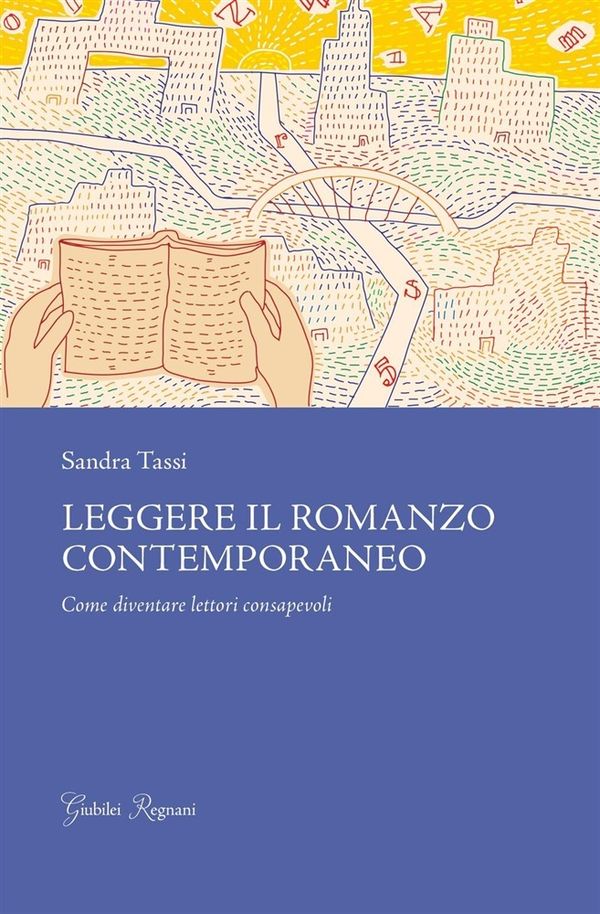«Il Lettore non sa ancora che, leggendo Se una notte d’inverno un viaggiatore, verrà coinvolto in una vera e propria rivoluzione culturale. Abituato a farsi catturare dalla copertina e dal titolo, acquista il libro esposto in vetrina tra le novità e si convince che “proprio quello” è ciò che stava cercando».
Pochi romanzi sono rimasti nella mente di chi li abbia letti come Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino; ed è probabile che chi abbia letto quel romanzo sia oggi un lettore di romanzi migliore e privilegiato; perché, almeno nella letteratura italiana, a quell’epoca nessun testo aveva messo in scena in modo così incisivo e nuovo il lettore stesso. Se una notte d’inverno è la storia del lettore che sta leggendo, un metaromanzo, un libro sui libri; e in quegli anni è il metalinguaggio narrativo a dare una improvvisa e violenta svolta moderna alla narrativa occidentale.
Ora, si comprende chi dica, con fare pensoso e sguardo perso nell’orizzonte, che un romanzo è bello perché racconta una storia meravigliosa e inscena personaggi indimenticabili, e che quello che conta sono le emozioni e il coinvolgimento e che una storia fa pensare e tutto il resto. Sia permesso dire però che aiuta anche conoscere come un romanzo è fatto e come è fatta una tradizione narrativa, critica e letteraria, il che rimane privilegio di chi si sia dato la pena di studiare un po’; perché è peccato, insomma, non intuire nulla della forma, dello stile, del laboratorio della scrittura di un autore. Come i romanzi iniziano, come vengono introdotti i personaggi, la differenza tra la fabula e l’intreccio, il montaggio, quello che è chiesto al lettore di integrare e completare. Ci permette peraltro, questo armamentario, di distinguere tra la buona letteratura e la numerosa robaccia; cosa utile, fosse solo a cena con gli amici, quando qualcuno comincia a fare il saputello e a buttare là cose senza dignità.
In questa direzione è molto invitante e immediato il titolo di questo Come leggere un romanzo. Diventare lettori consapevoli di Sandra Tassi, una pedagogista che vive a Modena. Il libro è una specie di guida al romanzo che, con piglio pedagogico e non pedante, smonta l’attività di lettura nelle sue componenti che conviene conoscere per dare un nome al piacere del leggere. Quindi: la differenza tra il romanzo tradizionale e quello moderno (quando gli autori hanno appunto capito i meccanismi di base e un po’ ci giocano, con grande gratificazione loro e nostra), il ruolo che il lettore sceglie o è costretto a scegliere, l’incipit o l’inizio dei romanzi, l’entrata dei personaggi, i rapporti continui o discontinui tra il procedere della narrazione e quello delle vicende narrate, il ritmo della scrittura, i generi letterari. Se nel romanzo tradizionale, quello di Dickens per esempio, l’inizio è una specie di entrata in scena teatrale, dove al lettore non rimane altro che «sedersi davanti al testo», in quello moderno le prime pagine servono a delineare un’«impronta», «il carattere narrativo» di quello che ci aspetta. E non sarà banale stare attenti a come si presenta, se si presenta, un personaggio: «Chiamatemi Ismaele», ci dice il marinaio-baleniere? Ci fidiamo? Ma non si parlava di una balena? No perché ci sono anche i personaggi che sono presentati da altri personaggi, o quelli che sono presentati dal narratore, che non va peraltro confuso con l’autore, che è altra cosa.
Tanta roba, conviene sapere. O meglio, tanta roba è forse più gratificante conoscere. Perde molto «piacere della lettura», in concreto, il lettore inconsapevole. «Dove cominciare?», si dirà. Da Calvino, appunto: «Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto».