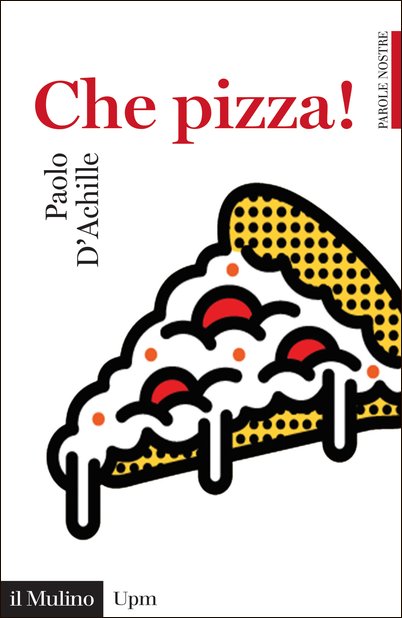«La pizza napoletana non è certo un cibo che fa passare tranquilla la notte, nemmeno a un giovane dallo stomaco di ferro. Giovanni Verga, l’indomani, non aprì gli occhi. E De Roberto si dava pugni sulla testa, maledicendo quel vecchio imbecille che aveva fatto mangiare di notte, a un uomo di ottant’anni, un intruglio di pomodoro e olio fritto».
Secondo Vitaliano Brancati, scrisse lui l’aneddoto in un articolo dal titolo Gli ultimi giorni di Giovanni Verga, fu una pizza mal digerita a uccidere, una mattina di gennaio del 1922, il grande scrittore siciliano. Nel gustoso Che pizza!, del linguista italiano Paolo D’Achille, il feroce aneddoto brilla in quanto unica e isolata voce nell’unanime coro di scrittori, giornalisti, storici e letterati che della pizza napoletana fecero e fanno, nei secoli e oggi, grande e reiterata lode; come se il piatto quasi nazionale per eccellenza presentasse, oltre all’indubbio portato culturale e simbolico, una più concreta serie di virtù salutari, al riparo da qualsivoglia disagio nell’assunzione e nella conseguente digestione.
L’aneddoto, che è pregevole appunto per quel suo solitario giudizio, sta appunto in un appena sfornato libro che entra come terzo in una collana dell’editore il Mulino dedicato a parole fondanti della nostra lingua: Luca Serianni vi ha già curato Parola e Giuseppe Patota Ciao!. E ora appunto Paolo D’Achille arriva con la pizza. La struttura è simile, l’ordine dell’esposizione conosciuto e confortante: prima di tutto, una sistemazione etimologica, che qui è tutta in salita, tra pizze, pinze e pite, con calate di goti e longobardi, antichi romani, soldataglie mediterranee che mangiano sempre qualcosa di simile, ora dolce ora no, ora con un grano ora con l’altro, con o senza pomodori, aglio, basilico, formaggio a fette o grattato sopra, molte altre complicazioni. La mangia Torquato Tasso a Mantova, la descrivono Francesco de Sanctis e Alexandre Dumas; la troviamo in italiano, nei dialetti, nel latino volgare. Più recentemente, il linguista onomasta Enzo Caffarelli ne censisce quattromila denominazioni: dalla semplice Margherita su su, passando per i quattro formaggi, le quattro stagioni, le calabresi, le trevigiane, le tirolesi, le americane, le hawaiane, fino alle etichette più improbabili e personalizzate, ai confini del concetto, quando la pizza tende a smettere di essere tale e rischia di essere altro: quelle con le patatine fritte, con la cotoletta, con l’hot dog adagiato sopra.
Una parola satura di storia e geografia come questa offre mille piste di studio: si può voler sapere come si chiamano i modi di prepararla e consumarla, i luoghi dove si vende (lo svizzero-italo-americano Hermann Haller diede, anni fa, un repertorio delle pizzerie newyorchesi), gli usi figurati (dalle pizze del cinema, agli usi, sempre connotati negativamente nelle esclamazioni: «che pizza», cioè «che noia»), i derivati pizzetta, pizzella, pizzeria. Spesso il piatto è associato, chissà per quale motivo, a luoghi, città, regioni, in una non delimitabile e quasi sempre immotivata fucina di formazioni e associazioni. Un cibo relativamente semplice diventa testimone di culture infinite, varia, si modifica, si contamina, esprime sue modalità, suoi dialetti verrebbe da dire.
Certo che la linguistica, quella ben fatta e ben scritta, se ha un pregio è proprio quello di una commovente leggibilità; questo libro sulla lingua delle pizze ha rigore indubbio nel metodo e nella scienza, ma si legge d’altro canto in un bóff. Uno. E due: più passa il tempo e più, chi legga spesso cose della materia, costruisce la convinzione che è nella storia della lingua che la provincia italiana degli studi linguistici si alza sopra ogni altra tradizione di studi sorella: la francese, l’anglosassone, la tedesca, ogni altra scuola. Questo libro fila subito nella libreria più cara.