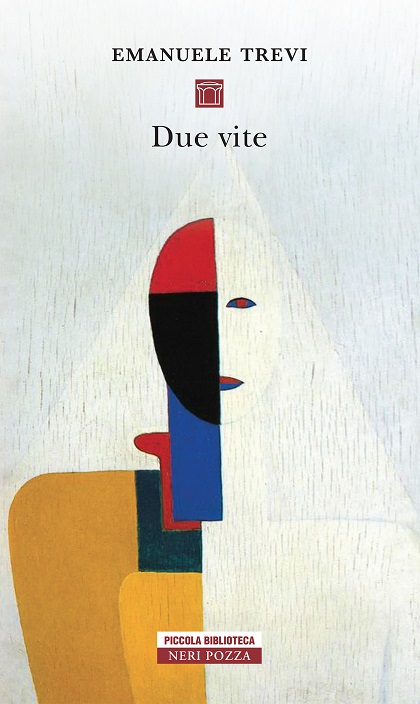Abbiamo incontrato Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, autore per la casa editrice Neri Pozza del romanzo Due vite, dedicato al racconto della sua profonda amicizia con i due scrittori scomparsi Rocco Carbone e Pia Pera.
Nel tuo libro Due vite racconti dei tuoi cari amici Rocco Carbone e Pia Pera. Nel precedente Sogni e Favole avevi scritto di un’altra persona a te cara, Arturo Patten. In Due vite leggiamo: «la scrittura è un mezzo singolarmente buono per evocare i morti, e consiglio a chiunque abbia nostalgia di qualcuno di fare lo stesso». Scrivi di loro solo per vincere la nostalgia?
No, la nostalgia è un demone che non si può vincere. Preferirei non avere scritto su di loro, e che fossero entrambi ancora qui con me. Però la scrittura, più del pensiero libero o del sogno, ricostruisce una specie di intimità, perché mentre scriviamo, ci apriamo all’imprevisto, il potere del nostro ego si attenua, ed ecco che l’assente, in qualche misterioso modo, si manifesta.
È molto interessante come dei due personaggi, Rocco Carbone e Pia Pera, rimangano molto impressi in chi legge i tratti del carattere più difficili, potremmo banalmente dire i difetti: l’indeterminatezza di Pia Pera e il facile risentimento di Rocco Carbone, per esempio. Questo accade all’interno di una narrazione in cui trasuda l’amore che porti loro. Gli eccessi sono più memorabili, cioè più degni di essere raccontati, o resistono meglio all’oblio?
Dipende un po’, credo, dal mio carattere fondamentalmente ironico, dalla mia tendenza alla dissacrazione. Quando ero un bambino, gli adulti mi facevano un po’ ridere, spiavo non tanto i loro difetti, ma la loro comica inadeguatezza alla vita. Forse la prima idea «letteraria» che ho avuto riguardava mio padre e i suoi eterni tentativi falliti di parcheggiare bene la macchina.
A un certo punto elogi la capacità di Pia Pera di raccontare il sesso e la sua tendenza a essere porno invece che indulgere in un erotismo che di vero ed eccitante non ha nulla. Qual era il tratto della sua personalità che in questo frangente specifico la rendeva così diversa dai tanti narratori e narratrici che o le evitano o non sanno scrivere scene di sesso?
Pia era una persona libera e imprevedibile, estranea a qualunque forma di «correttezza» ideologica. Nemmeno il femminismo aveva presa su di lei. Come ha giustamente osservato Goffredo Fofi recensendo il mio libro, la lettura di Sade può avere influito sulla sua esplicitezza.
Di Rocco Carbone ricordi invece con totale incomprensione l’interesse per la teoria della letteratura sul quale avrebbe potuto anche costruire una carriera accademica, se lo avesse scelto. Come scrivi, questo ambito del sapere ha l’ambizione di dare una scientificità alla letteratura. Perché ti sembra così riprovevole?
Riprovevole addirittura non direi, ma la programmatica aridità «scientifica» di quel modo di studiare la letteratura negli anni Settanta e Ottanta, quando Rocco era ancora impegnato nella sua carriera accademica, mi sconfortava. Non amo il gergo, il termine tecnico: lo capisco in medicina, ma la letteratura può essere descritta con qualche possibilità di illuminazione solo da altri scrittori, credo che la critica sia una forma artistica. Valgono più i due saggi di Baudelaire su Edgar Allan Poe che intere biblioteche accademiche. Semmai, amo l’erudizione, la grande scuola storica ottocentesca, perché lì ci vedo una specie di poesia implicita, l’idea che una tradizione immensa possa essere conosciuta da un singolo individuo.
Scrivi: «Noi pensiamo di essere infelici per qualche motivo, e non ci rendiamo conto che è proprio l’infelicità a produrre continuamente un suo teatro di cause che in realtà sono solo le sue maschere». Si tratta di un’espressione vera ed evidente. Ma se non ha cause originarie allora l’infelicità è un tratto della fisionomia, pari alla forma del nostro naso o al modo di camminare?
Forse potremmo dire che ognuno ha il suo modo di essere infelice così come ognuno possiede una sua fisionomia. La cosa più difficile, nel tipo di scrittura che pratico, è capire quanto una caratteristica appartiene alla collettività, e quanto invece alla singola, irripetibile persona. Questo secondo aspetto è la perla nell’ostrica, ma in mare non ci sono perle senza ostriche. Perché gli esseri umani, oltre che essere se stessi, assomigliano anche agli altri, altrimenti non esisterebbero. La letteratura, io credo, si può esattamente definire come un’indagine su ciò che è unico in individui destinati a essere, per moltissimi aspetti, simili agli altri. Basti pensare alla Monaca di Monza di Manzoni: è una figlia della sua epoca, del suo ceto sociale, fino a un certo punto in lei è tutto prevedibile… ma poi c’è uno scarto, l’inizio di un destino personale: è qui, a questo bivio, che lo scrittore deve aspettare il suo personaggio.
Bivi letterari
In Due vite lo scrittore italiano Emanuele Trevi ci offre il ritratto di due amici scomparsi, Pia Pera e Rocco Carbone
/ 20.07.2020
di Laura Marzi
di Laura Marzi