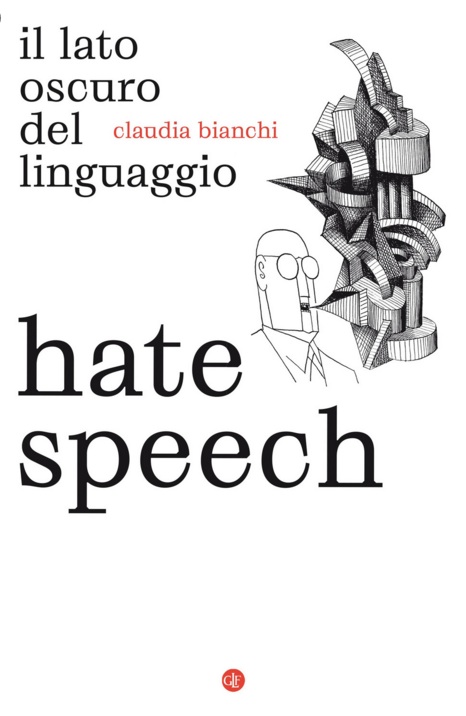Esistono formiche tropicali che si chiamano attini e si nutrono di funghi. Anzi, coltivano funghi per mangiarli; la coltivazione avviene predisponendo un letto dove viene adagiata la fungaia. Le tribù di formiche che vivono in questo modo sono chiamate tagliatrici di foglie, perché riducono le foglie in frammenti, che poi lavorano e utilizzano per attrezzare il nido. Questi industriosi animaletti sono oggetto dello studio Le formiche tagliafoglie di Bert Hölldobler e Edward O. Wilson. Un contributo a dire il vero non nuovo ma «rivestito» per l’occasione e inserito nella geniale collana «Animalia» di Adelphi, che fino ad ora aveva già ospitato libri sulla comunicazione degli elefanti, dei polipi, del corvo e di molte altre specie.
Animali che usano la mediazione di oggetti per produrre qualcosa sono automaticamente interessanti nella prospettiva dell’analisi della comunicazione. Questo perché si ritiene che parlare sia un po’ come mediare la propria attività utilizzando uno strumento: là sono le foglie portate a casa per la fabbrica dei funghi, qui è lo strumento-lingua per parlare. Così le nostre amiche formiche attuano un «foraggiamento cooperativo» molto comunicato, percorrendo piste tanto infinite quanto disciplinate; una specie di ferrovia merci dove le merci sono le foglie e loro sono i vagoncini. L’uomo vede molto bene queste autostrade di approvvigionamento (ottime le foto che allietano questa nuova edizione del libro) ma difficilmente intuisce il raffinato sistema comunicativo che le regge. In pratica funziona così: le formiche rilasciano una secrezione, un feromone che marca la pista e permette al gruppo di procedere spedito per una unica direzione, ricorrendo a due componenti: una richiama altre formiche alla collaborazione, letteralmente le «recluta», l’altra traccia la via. L’informazione è potentissima: un milligrammo di feromone prodotto dalle foraggiatrici del tipo Atta vollenweideri «basterebbe a depositare una traccia lungo la circonferenza del pianeta per ben sessanta volte».
Giunte sulle foglie più appetitose, alcune formiche sono poi in grado di emettere «segnali di reclutamento a breve raggio detti suoni stridulatori», per concentrare lì le risorse e le energie della squadra. Questi suoni non sono percepiti attraverso onde sonore provenienti dall’aria, ma sono «sentiti» dalle formiche dal suolo su cui si trovano. E in più i suoni stridulatori possono essere usati anche come segnale di allarme nel caso il nido stesso sia esposto a un pericolo improvviso e come ordine di marcia per altre operaie, per la ricerca di altre foglie e per la costruzione del nido. Questi sistemi servono pure ad altri scopi: indicare la presenza e il luogo di residenza della regina, assecondare una sorta di autostop sulla pista di trasporto ecc.
Ora, tutto ciò potrà sembrare facile e banale (anche se provare a far fare tutto questo al vostro cane di casa e a una serie di suoi «compari» potrebbe risultare un po’ frustrante), ma denota alcuni corredi tipici dei linguaggi animali, anche i più evoluti: prima di tutto che la comunicazione animale è di regola confinata a tre finalità principali ed esclusive: trovare e gestire cibo, proteggersi dai pericoli, assicurare la sopravvivenza del gruppo e della specie. E poi che ciò che informa la lingua degli animali è il fatto che ogni animale, uomo compreso, comunica con ciò che ha sensorialmente più «sotto mano»: per l’uomo la bocca e le orecchie per l’orale e la vista per lo scritto, per queste formiche l’olfatto per i feromoni, il tatto inferiore per i suoni striduli.
Ogni animale è in sostanza confinato entro un suo universo sensoriale che ne determina la comunicazione e, in concreto, la capacità di stare al mondo senza troppi danni. Per quanto ci riguarda, raramente riusciamo con i nostri sensi a percepire tutto quello che fanno e si dicono gli animali, specie quelli minuscoli. Buon per loro, forse.