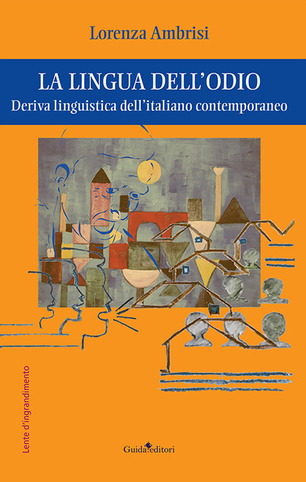Due cose colpiscono di questo La lingua dell’odio. Deriva linguistica dell’italiano contemporaneo di Lorenza Ambrisi. L’età dell’autrice («nata a Pompei il 13 gennaio del 1996», ci avvisa la nota biografica in quarta di copertina) e l’attenzione agli aspetti pedagogici e legati al mondo giovanile. Il particolare comparto della linguistica (anche) italiana è legittimamente maturo e ha oggi una sua solidità di strumenti ed esemplificazioni. Così diventa interessante, là dove molto si è già detto, tracciare nuove prospettive e porte d’entrata. Non ultima, così, la via della pedagogia e dello sguardo sulle fasce giovanili, in prima fila di fronte a bombardamenti social di varia provenienza.
Su questa linea, rileva giustamente Lorenza Ambrisi che «in questo scenario appare evidente come la “semplice” educazione al pensiero critico non basti più»; nello spazio tutt’ora incontrollato delle moralmente sgangherate ma potenti comunità digitali «i razzismi appaiono come modelli interpretativi del mondo e della società contemporanea» e i riferimenti diventano incerti e ambigui.
I politici, anche se «dovrebbero essere i primi a esprimersi attraverso discorsi che non veicolino messaggi d’odio» hanno finito per cedere a un atteggiamento che si è affermato con decisione, sospeso ad arte tra i due poli dell’autorità e dell’istigazione: «postare» una notizia apparentemente neutra su un tema caldo (i migranti è il primo che viene in mente) e scatenare i propri amici virtuali lasciando loro dirne di ogni e creando così un peritesto malefico che, si sa, finisce per contare più del testo stesso.
La prima parte del libro è dedicata a un linguaggio d’odio storico, quello dei nazismi e dei fascismi del Ventesimo secolo. Se da una parte è indubbio che grandi linguisti come Viktor Klemperer prima e Gabriella Klein poi abbiano prodotto descrizioni accurate e forse definitive su quei codici così cupi, fa un po’ strano che questa materia stia nello stesso libro insieme allo hate speech contemporaneo, quello di facebook e Twitter. E però porre il problema della eventuale continuità, «dall’uso strumentale della lingua nei regimi totalitari alla lingua dell’odio nella realtà contemporanea», è pure una delle coraggiose scelte di questa autrice.
Tra le altre novità, c’è una discussione molto ampia sul ruolo dell’identità e dell’identificazione personale in rete. Da qualche tempo in qua (e questa è proprio nuova) chi odia e insulta in rete, specie se è giovane, tende a non rifugiarsi più nelle sicurezze dell’anonimato. Anzi. «I commenti che lancia hanno una corrispondenza con l’individuo stesso che vuole farsi riconoscere», contando su un ampio numero di simili, un fiero gruppo di sodali con il «petto in fuori» che rivendicano una loro personale e collettiva ribalta.
Non è un caso che siano relativamente poche le pagine dedicate a soluzioni e resistenze. Dietro a un mondo digitale spietato, veloce e incisivo, il diritto e la filosofia non possono che arrancare; e risulta ormai quasi simbolica l’enorme difficoltà di chi decida di chiedere una anche solo parziale rimozione di determinati contenuti d’odio (provate, per credere, a scrivere a Google di fronte a una menzogna che vi riguarda. Auguri!). Libri come questo, con la loro intelligenza e con una certa attenzione alla giustizia morale ancora prima che giuridica, tendono comunque ad aprire alla speranza di una contronarrazione dei fatti. Che ha spesso, dalla sua, il non insignificante faro della verità.
(C’entra forse poco, ma ancora sul sopra richiamato Klemperer, chi abbia letto la fonte originale, il memorabile La lingua del terzo Reich, non può dimenticare il testo posto in capo al libro nel giorno di Natale del 1946 e dedicato alla moglie: «Se volessi spiegarti tutto questo nei particolari mi ci vorrebbero molte, e intime, pagine. Tu sai bene, e quanti non sanno dovranno intuirlo, a chi penso quando a chi mi ascolta parlo di eroismo». C’entra poco ma dà l’idea della gloria che talune discipline come la linguistica hanno avuto nei loro decenni più floridi).