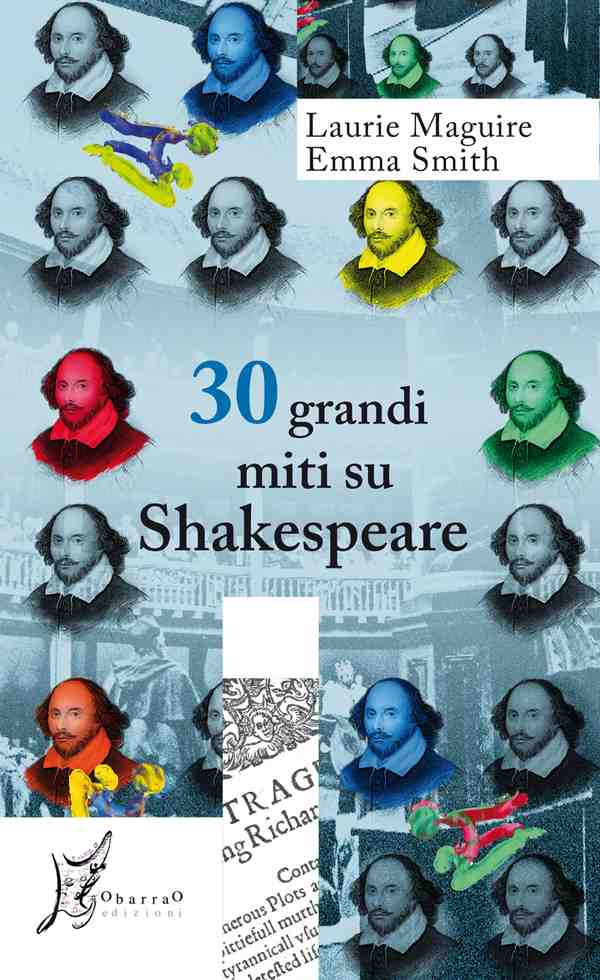S’intitola 30 grandi miti su Shakespeare (30 Great Myths About Shakespeare) il libro che suggerisco di leggere durante le prossime feste, sul finire dell’anno in cui ricorre il quattrocentesimo anniversario della morte – avvenuta per l’esattezza il 23 aprile 1616 – del massimo drammaturgo dell’età moderna. Lo hanno scritto Laurie Maguire (docente di Letteratura inglese al Magdalen College di Oxford) e Emma Smith (ricercatrice, lei pure a Oxford, presso l’Hertford College).
«Questo libro – dichiarano le autrici – si propone di indagare le cognizioni che crediamo di possedere riguardo a Shakespeare, qui indicate nell’insieme come “miti”». Nell’accezione proposta da Maguire e Smith, la parola «miti» significa «credenze comunemente accettate», «opinioni consolidate», «idee diffuse che possono avere una base fattuale, ma ingigantiscono i dati disponibili o suppliscono con mere supposizioni alle lacune nelle prove documentarie». Le intenzioni di Maguire e Smith sono tre: mostrare «come il materiale storico, o la sua assenza, si presti a interpretazioni e fraintendimenti»; illustrare il momento storico in cui le ipotesi interpretative sono diventate «verità indiscusse»; cercare di «comprendere il fascino dei miti e la presa esercitata sui loro sostenitori».
Progettando il libro, Maguire e Smith hanno saputo resistere alla tentazione di occuparsi principalmente dei miti legati alla biografia di Shakespeare. Ne hanno presi in considerazione alcuni, ma cercando di indirizzare il più possibile il discorso verso le opere drammatiche e poetiche in quanto tali. Trattando il mito 16 («Non sappiamo molto sulla vita di Shakespeare»), Maguire e Smith espongono i fatti documentati e concludono che in realtà ne sappiamo parecchio: meno che sulla vita di Marlowe e Ben Jonson, ma molto di più che su quella di altri drammaturghi dell’età elisabettiana.
Ciò di cui sappiamo assai poco, invece, è la personalità di Shakespeare, ragion per cui siamo portati a leggere certe memorabili battute di alcuni suoi personaggi come espressioni dirette del suo pensiero. Quanto all’indagine condotta dalle due studiose inglesi su altri miti collegati alla biografia dell’uomo e dell’artista («Shakespeare non era istruito»; «Shakespeare non viaggiò mai»; «Shakespeare era cattolico»; «Shakespeare odiava sua moglie»; «Amleto prese il nome dal figlio di Shakespeare»; «I Sonetti di Shakespeare sono autobiografici»; «La tempesta è l’addio di Shakespeare al palcoscenico»), ho deciso di comportarmi come il recensore di un thriller. Niente spoiler. Lascio al lettore il piacere di seguire le argomentazioni e di conoscere le conclusioni a cui arrivano Maguire e Smith.
Di particolare rilievo – perché interessano anche i teatranti dei giorni nostri – sono i miti concernenti le rappresentazioni delle opere di Shakespeare e la loro fruizione da parte degli spettatori del suo tempo. Il mito, ad esempio, secondo cui «i ruoli femminili erano interpretati da ragazzi-attori» corrisponde a verità. Da ciò un’ambiguità e un’allusività erotica che «Shakespeare spesso potenziava inserendo nella trama delle sue commedie un travestimento transessuale». Ne La dodicesima notte (l’esempio è mio) Viola era un ragazzo-attore che fingeva di essere una ragazza che fingeva di essere un ragazzo. Olivia, a sua volta, era un ragazzo-attore in abiti femminili.
Grazie a una convenzione teatrale, il gioco scenico del triangolo amoroso Viola-Orsino-Olivia accresceva quella messa in crisi generalizzata dell’identità sessuale, quel «richiamo impronunciato ma avvertibile – di cui parlava Luigi Squarzina – a una comunione orgiastica e al mito dell’androgino», che unitamente ai pregi del linguaggio fanno della Dodicesima notte un’opera di raro fascino. (Che tale commedia possa essere compresa per davvero solo se recitata da un cast interamente maschile lo ha dimostrato, circa dieci anni fa, il bellissimo spettacolo inscenato da Edward Hall con la compagnia Propeller.)
A chi gli domandava – al termine di una conferenza tenuta a Berlino il 12 maggio del 1996 – quali livelli di scrittura patissero un notevole danno per il fatto che i testi shakespeariani, alle Bouffes du Nord, venivano tradotti e inscenati in una lingua straniera (il francese), Peter Brook rispondeva: «Le opere non soffrono, ma io sì. Per un inglese è una vera e propria sofferenza. Perché appena si inizia a tradurre scompare un livello di musica». Tuttavia, «quello che è straordinario con Shakespeare, è che le sue opere sono talmente ricche che anche se sottraiamo ciò che per la maggior parte dei poeti corrisponde al novanta per certo del valore, rimane una materia straordinaria e magnifica». L’undicesimo mito indagato da Maguire e Smith («Shakespeare scriveva nei ritmi del parlato quotidiano») riguarda perlappunto il «suono», la «musica» delle opere drammatiche di Shakespeare. Che in larga misura sono scritte in versi, con prevalenza netta del blank verse, decasillabo sciolto a cinque accenti che fu perfezionato da Marlowe e poi adottato dagli altri drammaturghi elisabettiani.
Dopo aver dimostrato che il blank verse affiora non infrequentemente anche nel parlato quotidiano, Maguire e Smith forniscono numerosi esempi di come questo metro – nelle parti in versi delle opere teatrali di Shakespeare – possa agevolmente trapassare dal tono elevato al colloquiale, e di come possa non stranamente risuonare nelle parti in prosa. Inevitabile che tutto ciò vada perduto nelle traduzioni in lingua straniera. Ma come ha detto Peter Brook, nelle opere di Shakespeare c’è molto altro.