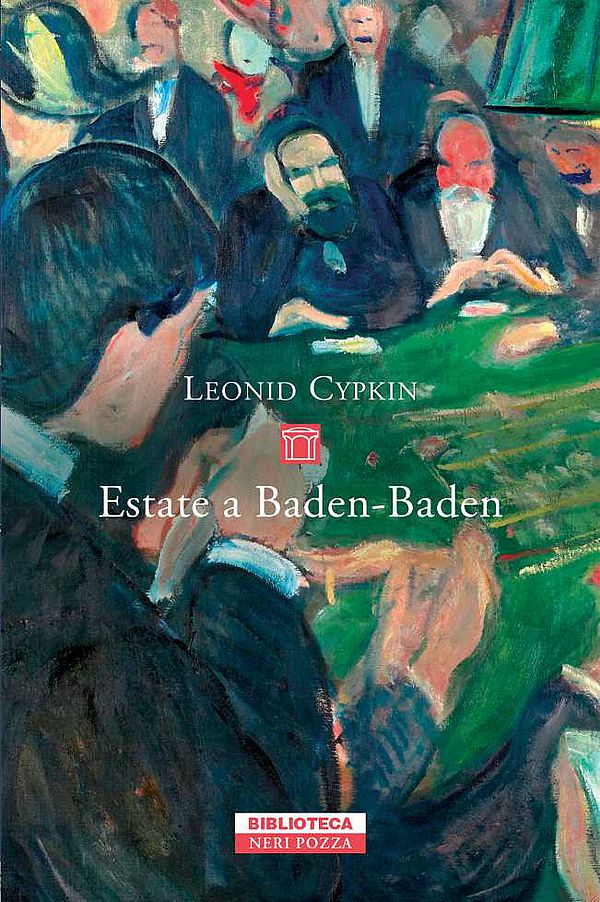Dire che questa opera è unica è persino troppo ovvio ma, in effetti, si fatica a nominarne il genere. Opto per biografia romanzata ma di un tipo particolare. Gli sforzi per trovare riferimenti ad altre opere (qualcuno cita WG Sebald o Th. Bernhard) non hanno migliori risultati, anche se sono stati spesi aggettivi qualificativi al massimo grado.
Estate a Baden-Baden è un libro decisamente singolare per l’invenzione che dispiega, lo stile di scrittura e l’esperienza di lettura che offre. E per il prologo di Susan Sontag. All’inizio del racconto (siamo negli anni 1960/70) il narratore/autore, in una giornata invernale e durante un viaggio in treno verso Leningrado, legge i diari di Anna Grigor’evna, seconda giovane moglie di Fiodor Dostoevskij, e il suo pensiero e il suo sguardo si perdono nei paesaggi di neve, di ghiaccio, di cieli che progrediscono verso l’oscurità esterna mentre, all’interno del vagone, si alternano immagini di varia umanità.
Da queste descrizioni poetiche emerge, grandioso e meschino, il suo idolo letterario che viene inquadrato mentre viaggia con la moglie da San Pietroburgo verso la Germania e soprattutto verso Baden-Baden, celebrata località termale europea dove soggiornavano, nel 1867, anche intellettuali e scrittori russi come Turgenev e Goncarov. In quella città l’ossessione per il gioco d’azzardo di Dostoevskij è finalmente vissuta a pieno con tutta la disperazione che porta con sé (anche se la moglie riesce a separare la fibra morale dalla sua dipendenza).
Due narrazioni, due storie a distanza di un secolo che vivono intrecciandosi, scivolando l’una nell’altra, in continue entrate e uscite, giri lunghi e svolte rapide, seguendo i cambi d’umore dei personaggi e i paesaggi naturali e artistici delle loro vite. Vediamo Dostoevskij con tutte le sue caratteristiche, idiosincrasie, ossessioni, pregiudizi; lui giovane prigioniero del regime zarista, difensore dei perseguitati ma preda del suo sfacciato antisemitismo, inseguito dai creditori e in fuga dal suo Paese, le sue miserie, la nevrosi, l’epilessia, fino alla morte nel 1881. E anche lo stato dell’arte della letteratura russa, dei dibattiti fra scrittori e critici del tempo, le avversioni e le menzogne con nomi e cognomi. E i personaggi dei suoi romanzi che sembrano camminare per strada o resistere negli angoli bui delle loro malefatte. Emerge anche Anna Grigor’evna, la stenografa de Il giocatore, lei che tutto perdona, che rammenda e risparmia, che impegna gioielli al banco dei pegni, conscia del ruolo di moglie protettiva del grande scrittore.
Anche nel tempo del viaggio del narratore, un secolo dopo, appaiono importanti personaggi – mai nominati col loro nome ma individuabili attraverso le descrizioni – della scena letteraria e del dissenso russo del Novecento come l’emigrato pentito Solzenicyn o la coppia Sacharov-Bonner. L’autore sapeva troppo bene di non poter essere più esplicito.
Il ritratto sembra più reale del reale – l’autore, ossessionato da Dostoevskij e alla ricerca incessante di informazioni, sembra immergersi totalmente nel suo idolo – e la biografia romanzata cattura il lettore che vive una vera esperienza singolare, nel corso del libro, a causa della fusione delle due storie, un borborigmo senza fine, come un delirio o un sogno. Anche lo stile sorprende: una scrittura letteraria, poetica, evocativa come l’anima russa, circonvoluta, raffinata e talvolta pedante. Le frasi sembrano paragrafi, lunghe anche più pagine, interrotte solo da qualche lineetta, virgola o congiunzione. Una lettura impegnativa, un flusso di coscienza maniacale, comunque inclusivo, distaccato ma umano a significare come intelligenza, introspezione e razionalità possano convivere con l’invenzione e l’immaginazione.
Ma chi è questo autore sconosciuto, pubblicato dall’editore Neri Pozza con una sapiente intuizione? Lo scopriamo dal prologo, Amando Dostoevskij di Susan Sontag – altro pregio del libro – che davanti a una libreria di Charing Cross Road (la via è famosa per le sue librerie specializzate e antiquarie), rovistando fra i tascabili usati, trova Estate a Baden-Baden e se ne innamora.
Leonid Cypkin, 1926-1981, di famiglia ebrea di Minsk, che perse la nonna sotto i Nazisti e vide il padre arrestato durante il periodo di terrore di Stalin (con tentativo di suicidio in prigione), aveva seguito i genitori nella carriera medica diventando un ricercatore stimato e salendo a migliori funzioni. Fino al 1977 quando suo figlio aveva ottenuto il permesso di emigrare in America: allora fu destituito dai suoi incarichi e privato anche di supporto economico. Aveva sempre scritto senza l’illusione di pubblicare, e durante questo tempo di isolamento scrisse Estate a Baden-Baden.
L’autore, affascinato dallo scrittore Dostoevskij, si fa narratore del viaggio della coppia in Europa mentre lui stesso si dirige verso la sua città (Leningrado per l’autore e San Pietroburgo per lo scrittore per problemi di Storia): nel tempo sospeso del viaggio elabora e rielabora domande inquietanti anche sulla sua capacità di comprensione della sofferenza altrui così sbandierata, specialmente di quelli insultati e feriti come pure della vita di una foglia o di un filo d’erba. I suoi romanzi sono colmi di umanità – sebbene quest’uomo non abbia speso una parola a difesa di un popolo perseguitato, anzi: era portatore di pesanti accuse antisemite. Dostoevskij ha narrato un mondo popolato da ebrei che vengono descritti con le qualità più infime e i nasi lunghi. Leonid Cypkin, lui stesso ebreo, sceglie la letteratura e la devozione letteraria nel rappresentare il grande scrittore di Delitto e Castigo, ma descrive anche la vita di sofferenze silenziose degli ebrei sovietici che conosce molto bene.
Arriva addirittura a occuparsi di come gli studiosi ebrei abbiano sempre avuto per Dostoevskij una singolare attrazione e studio che lui giudica «un atto cannibalistico verso il leader di una tribù nemica». Oppure lo sfruttamento di un salvacondotto, «come nascondersi dietro la sua schiena» o «mettere una croce sulla porta durante un pogrom». Una doppiezza?
Quel che emerge, alla fine, è il ritratto di Dostoevskij e di sua moglie Anna Grigor’evna – un ritratto intimo e fatto di piccoli dettagli, affettuoso ma non sentimentale. Così facendo, l’ha reso personaggio letterario.