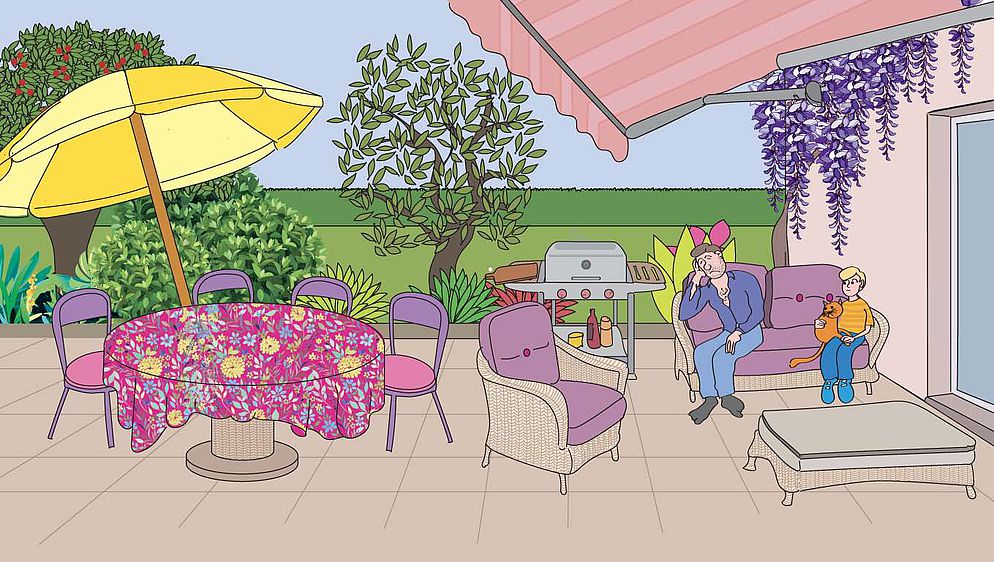È ormai innegabile come un disagio generalizzato abbia «contaminato» tutti gli strati della nostra società. Ce lo raccontano quotidianamente i mass media: soffrono i giovani, reduci dalla pandemia e privati di una prospettiva di futuro, soffrono le persone anziane, protagoniste di un nuovo status (non a caso, e non sempre senza una nota di biasimo, si parla di ageismo e baby boomers), ma soffrono anche i genitori, responsabili del delicato compito di crescere altri esseri umani in un mondo e in una società i cui paradigmi si fanno imperscrutabili, e le cui coordinate sembrano variare da un giorno all’altro.
Può dunque succedere che anche i genitori «inciampino» in un malessere che impedisce loro di essere performanti, o anche solo presenti come desidererebbero, o ancora, come il loro ruolo o la società richiedono. Ma se il malessere psicologico colpisce un genitore, cosa accade alle sue figlie e ai suoi figli? Chi si prende cura di quel disagio riflesso? Quali sono le strategie che una bambina o un bambino possono mettere in campo quando la «malattia dell’anima» colpisce un membro della famiglia?
L’associazione ginevrina Novacarta, attraverso un lavoro di divulgazione realizzato in collaborazione con HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève), CHUV (Centre Hospitalier universitaire vaudois), il Réseau Hospitalier neuchâtelois e l’Hôpital du Valais, e perseguendo l’intento di «creare libri per spiegare ai bambini temi complessi o addirittura dolorosi», propone ora una serie di pubblicazioni ad hoc, sostenute dal Percento culturale Migros, rivolte a chi vive un forte malessere psicologico in casa, e più precisamente, una depressione. Dov’è finita la felicità, infatti, si presenta come pubblicazione personalizzata (vedi box) per chi si ritrova confrontata/o con la «tristezza» o «malattia dell’anima» della madre o del padre, e non capisce. Oppure, quando capisce, non sa cosa fare. Ne abbiamo parlato con lo psicoterapeuta ginevrino Nino Rizzo, esperto di dinamiche famigliari e curatore insieme a Stefano Monzani di Les parentalitàs contemporaines (Parigi, efs Sciences Humaines, 2022), che accompagna i libri di Novacarta con quella che definisce una «supervisione informale».
Nino Rizzo, qual è la particolarità dell’iniziativa editoriale che sta dietro a Dov’è finita la felicità?
Il libro nasce da un’esperienza personale di qualcuno molto vicino ai due autori, che non sono dei teorici o degli insegnanti, ma persone che hanno vissuto concretamente questa esperienza. Il libro nasce dunque dalla vita, non dalla mente. La prima particolarità di questa idea è rappresentata dalla quantità di scenari che permettono al bambino un’identificazione. I narratori possibili sono due, Olivia o Gabriel, e ci sono quattro strutture familiari differenti. La casistica di scenari presenti permette al bambino di leggere il libro che combacia meglio con la sua situazione personale, dando così a lei o a lui modo di calarsi dentro la storia e di aprirsi anche a un eventuale dialogo con l’adulto. L’idea delle pagine bianche, inoltre, aiuta il bambino a entrare in totale intimità con sé stesso.
Dov’è finita la felicità esce in un momento in cui giungono segnali di disagio da più fronti: si parla di malessere nelle persone e psicologi e psichiatri sono in affanno per il grande numero di richieste. Che impatto hanno avuto le problematiche degli ultimi anni sul nostro equilibrio interiore?
Abbiamo assistito a un incremento del disagio, e credo che la pandemia abbia inciso più di altri fattori, certamente più della guerra, poiché ha messo in evidenza problematiche che esistevano già, legate ad esempio alle difficoltà economiche, all’emigrazione, alla monoparentalità o alle differenze culturali. La pandemia ha rinchiuso ogni famiglia nel proprio guscio fatto di paure (come quella di incontrare qualcuno o di toccarlo), impedendo quell’apertura agli altri che è un continuo arricchimento indispensabile per tutti. Dopo la pandemia, qui a Ginevra, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti sono stati investiti da una valanga di richieste di aiuto, al punto che oggi è difficile trovare la disponibilità di queste figure professionali. Le persone si sentono un po’ come quando si è costretti a salire in cima a una montagna: non ci si ferma, ma quando si arriva al traguardo esce un ulteriore fardello, che è quello della stanchezza morale.
Oggi finalmente si parla di depressione e di salute mentale: gli esperti sono concordi nell’affermare che se ne debba sempre parlare con i propri figli, anche se piccoli.
Con i bambini più piccoli si deve parlare a partire dal momento in cui ci pongono delle domande. Se il bambino comprende che la sua ansietà è ricevibile dall’adulto, rapidamente, anziché mostrarla in forma di espressione psicosomatica, la esprimerà a parole. Quando il bambino somatizza, significa che sente che il papà o la mamma potrebbero non recepire le sue paure e i suoi dubbi.
Vi sono delle parole specifiche da utilizzare con un bambino per spiegargli cosa sia la «malattia dell’anima»?
I differenti elementi della famiglia possono fare un duplice lavoro intorno alla depressione di un genitore. Per entrare nella sofferenza del bambino si può anzitutto parlargli, ad esempio dicendogli: «Vedi, papà è un po’ triste e tu te ne rendi conto, cosa ne pensi?», aprendo così uno spazio di parola per il bambino. È importante utilizzare parole semplici che facciano parte del linguaggio basico, basta parlare di tristezza, paura, rabbia, ecc. I bambini in genere percepiscono bene le situazioni, poiché l’essere umano nasce con una capacità di intuizione profonda, che purtroppo perde naturalmente a mano a mano che sviluppa il suo lato razionale. Attraverso le domande sensibili e rispettose di un adulto, il bambino sente di potere essere ascoltato. L’altro modo per entrare nella sofferenza dei bambini è parlando agli adulti toccati dal problema, attirando la loro attenzione sul malessere dei più piccoli. A volte, per rompere il ghiaccio, basta un gesto, una mano sulla spalla o uno sguardo, insomma una manifestazione di semplice e umana empatia.
Quali sono i rischi se non si affronta il problema della depressione di un genitore con i bambini?
Nello spazio tra l’intuizione naturale del bambino e la certezza che vi sia realmente qualcosa che non va, il bambino potrebbe maturare l’ipotesi che sia tutta colpa sua e che la situazione creatasi possa essere frutto di un suo comportamento inadeguato, come essere stato disubbidiente o avere litigato con la sorellina o aver riportato cattivi voti a scuola.
Fin qui abbiamo parlato di bambini, ma come possiamo affrontare questo discorso con un adolescente?
Le parole ovviamente cambiano, ma non il messaggio. Con gli adolescenti possiamo utilizzare un linguaggio più chiaro, ad esempio parlando della depressione come di un’esperienza umana che possiamo vivere tutti. L’adolescente è in un periodo della vita contraddistinto da alti e bassi ormonali ed emozionali, da paure e incertezze, dalla voglia di fare esperienze: sta all’adulto fargli capire che non deve rinunciare alla propria vita solo perché ha un genitore depresso.
Vi sono luoghi più idonei di altri per una discussione tra un adulto e un bambino o un adolescente?
La vita quotidiana ci presenta diverse occasioni adeguate a forme più intime di scambi tra genitori e figli: è importante coglierle e non lasciarle passare. Un momento molto idoneo, per esempio, è la sera, quando il bambino deve andare a letto. Per quanto riguarda gli adolescenti, credo che un buon luogo sia l’abitacolo della macchina: esso offre uno spazio privilegiato in cui l’adulto non può guardare il ragazzo e nessuno dei due può scappare. Anche una passeggiata potrebbe prestarsi per uno scambio.
A causa del suo disagio, il genitore depresso potrebbe sentirsi inadeguato nel suo ruolo. Cosa si sentirebbe di consigliare?
A tutti quelli che sono depressi direi che anzitutto è loro diritto deprimersi, poi aggiungerei che in qualche modo la depressione è anche un’opportunità della vita per crescere, per capire quali siano state le scelte che magari si sono rivelate inadeguate, permettendoci a volte di riaggiustare il corso della vita. Nel momento acuto però l’ideale sarebbe che il genitore si rendesse conto dei limiti legati al difficile periodo che sta attraversando, e richiedesse un aiuto professionale. A volte rivolgersi a un altro membro della famiglia o a una figura esterna, autorizzandoli a parlare con i propri figli, può essere di grande aiuto. È importante che il bambino e il ragazzo capiscano di non potere influire in alcun modo sul dramma del genitore e di non portare alcuna responsabilità; si tratta, insomma, di sviluppare delle strategie.
Cosa non dovremmo mai dire a una persona depressa?
Frasi come «Ma sì, dai, passerà». Quando lo facciamo sminuiamo il valore del dolore dell’altro. Sminuendo il dolore dell’altro però, rischiamo di entrare nel gioco che una parte della persona depressa ha voglia di giocare, in altre parole, la rafforziamo nella convinzione che non si tratti di nulla di grave e non la sosteniamo nella presa di coscienza della serietà del problema vissuto e nella ricerca di un aiuto.
È più difficile essere genitori oggi?
Credo che per essere genitori adeguati oggi siano necessarie una certa creatività e originalità, al di là di tutti gli schemi sociali, religiosi, politici e di convenienza. È difficile essere genitori in una società che cambia costantemente, che ci bombarda di valori commerciali in grado di creare movimenti dissociativi all’interno della famiglia. In fondo siamo genitori solo nella misura in cui possiamo esserlo, ossia da soli, in coppia, in coppia omosessuale, e così via, ma non esistono famiglie giuste e famiglie sbagliate. Per me è importante lavorare con i genitori, poiché credo che oggi il loro sia un ruolo difficile.
In Dov’è finita la felicità troviamo ad esempio un padre che sta male, e a quel punto interviene la madre, prendendo in mano la situazione; laddove invece i genitori sono impossibilitati a farlo, intervengono altre figure della famiglia. Il modello classico di famiglia in cui madre e padre sono una coppia e nonni e zii vivono a portata di mano però è sempre più raro: cosa suggerisce per quei bambini che non possono contare sulla «ricevibilità» di cui parlava prima?
È vero che i genitori spesso non si rendono conto della gravità di certe situazioni, o magari non hanno la disponibilità mentale per farlo, ma è pur vero che sin dalla nascita il bambino è preso in carico da una serie di figure mediche e pedagogiche, ad esempio dal pediatra. Quando poi inizia la scuola, è introdotto in una rete sociale, con insegnanti e curatori. Queste figure adulte hanno un ruolo importante e possono fare da antenne e captare il malessere del bambino, per poi rapportarlo a chi di dovere a dipendenza della situazione.