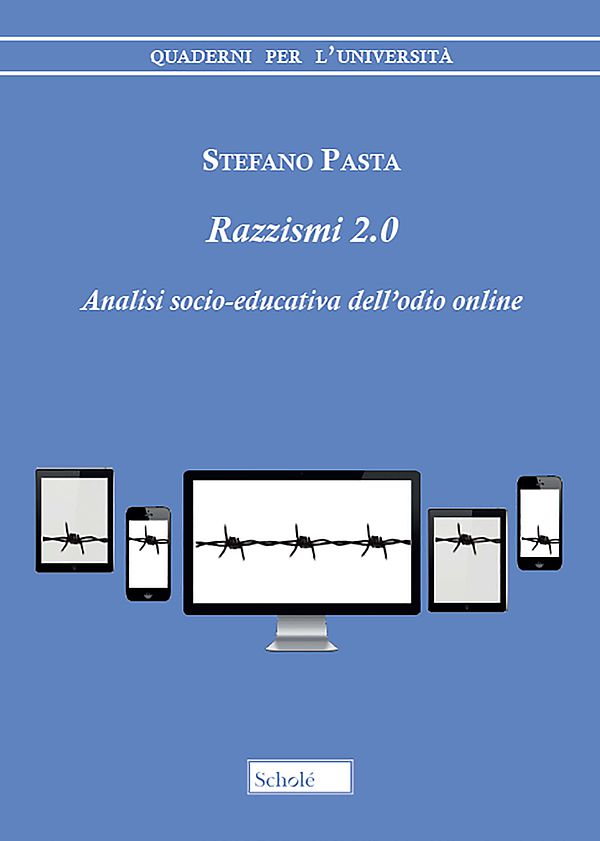Quando hanno chiesto alla senatrice italiana Liliana Segre, testimone dell’orrore dei campi di concentramento nazisti, quale parola avrebbe inciso all’ingresso del memoriale della Shoah, nella Stazione di Milano, ha scelto la parola «indifferenza»: l’indifferenza della sua maestra, dei suoi concittadini, dei suoi amici rispetto al dramma che la toccò ancora ragazzina; un’indifferenza che alimenta odio e razzismo. Ma quale razzismo? Oggi, dobbiamo fare i conti con tutti quei fenomeni di odio online e razzismo tipici del web sociale, i razzismi 2.0 come li definisce Stefano Pasta, pedagogista, esperto di hate speech, membro del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano. In molti paesi, l’odio online è diventato un tema prioritario, che, in un modo o nell’altro, coinvolge tutti, basta pensare a quanto tempo dedichiamo ai nostri profili social, a chattare su whatsapp, a creare stories su Instagram, a leggere e condividere contenuti; il cosiddetto web sociale è uno spazio di co-autorialità, dove chiunque, indipendentemente dall’età o da una presunta competenza, può agire nella sfera pubblica, basta un like, la condivisione di un video su TikTok o di un meme su WhatsApp. Cosa c’è di più innocuo? «Col web sociale – dice Stefano Pasta, autore del saggio Razzismi 2.0 – non basta più educare al pensiero critico o alla fruizione dei contenuti, è necessario educare alla produzione culturale, poiché in questo spazio non siamo semplici spettatori, ma spettautori».
Oltre a occuparci di bulli e delle loro vittime, è necessario rivolgersi anche al grande bacino degli «altri»
Schermi e tastiere hanno liberato gli istinti più torbidi, dice Pasta: «Per studiare questi fenomeni, ho chattato con ragazzi dai 14 ai 21 anni, che avevano partecipato a forme esplicite d’odio, applaudito alle molotov lanciate su un centro profughi, incitato allo stupro di una coetanea, o fatto battute antisemite, e alla mia domanda se si fossero resi conto di ciò che facevano, molti si sono giustificati dicendo che erano solo battute, da non prendere sul serio». Li prendiamo troppo sul serio? Strumenti come TikTok attraverso l’ironia e la banalizzazione facilitano la propagazione di forme d’odio, trasferiscono contenuti caratterizzati da un apparente disimpegno, meno riconoscibili come discorsi d’odio e per questo più accettabili da un punto di vista sociale, ma con un impatto – commenta Pasta – «pari alle forme più organizzate e strutturali di odio online».
Si tratta di forme diverse di odio, ma che insieme partecipano alla creazione di un clima culturale che porta alla «rottura del tabù» e all’accettazione sociale: «Tutti gli studi ci mostrano come l’accettazione sociale sia ciò che rende possibile l’aumento di intensità dei processi di elezione a bersaglio, lo vediamo con i discorsi d’odio e razzismo, ma anche con teorie incredibili come il terrapiattismo, tutti contenuti che se pur ai margini, sono rimessi nello spazio pubblico di discussione», dove trovano nuova linfa. Negli ultimi anni, complice la pandemia, e l’esplosione dell’Intelligenza artificiale, il fenomeno dell’odio online ha allargato i suoi confini, oggi si parla di hate speech, una categoria che raccoglie fenomeni diversi, dal sessismo all’antisemitismo, dall’islamofobia all’omofobia, all’odio verso il singolo, e la richiesta di una maggiore responsabilità da parte delle grandi piattaforme del web sociale è diventata sempre più pressante. Nel 2022, il Consiglio d’Europa ha definito il discorso d’odio, l’hate speech, a partire da tre livelli: quello penalmente perseguibile, il discorso d’odio rilevabile da un punto di vista amministrativo e un terzo livello, quello della cittadinanza, in cui le manifestazioni d’odio sono rilevanti per il vivere insieme.
Il processo di accettazione sociale si rafforza anche grazie al gioco perverso di accostamenti tra manifestazioni d’odio diverse: che legame può esserci fra una critica al green pass e la derisione della Shoah? Eppure durante la pandemia abbiamo assistito a simili accostamenti. «Abbiamo reso accettabili – dice Stefano Pasta – parole, accostamenti e teorie, sdoganato tabù che una volta rotti, online come offline, si stabilizzano e diventano parte dello sviluppo culturale di una comunità. Oggi, in Italia, siamo tornati addirittura a parlare di sostituzione etnica, una vecchia teoria di matrice antisemita che avevo studiato durante il mio dottorato». Tuttavia, ci sono segnali positivi e l’Europa, attraverso documenti come il Digital service act, emanato nell’ottobre del 2022 per regolamentare il mondo digitale, sta giocando un ruolo chiave, di guida. «Il dibattito – continua Pasta – è fra un sistema giuridico di matrice statunitense, in cui sono nate le principali piattaforme web, secondo cui non si può porre alcuna limitazione alla libertà d’espressione anche quando è lesiva della dignità altrui e il diritto europeo che parla di responsabilità delle piattaforme, di mediazione, in cui la libertà d’espressione finisce dove lede la dignità umana». Il confronto è culturale, non solo giuridico.
Chi ha, dunque, le responsabilità maggiori nella diffusione dei contenuti d’odio online? Ci sono responsabilità diverse, commenta Pasta: «dal ragazzino che dice di non accorgersi della gravità di ciò che scrive, all’odiatore seriale che sfrutta la pandemia per diffondere contenuto d’odio, ai giornalisti e ai politici, ma l’impatto maggiore è dato dal silenzio e dall’accettazione della maggioranza… e non è una lezione nuova, è la zona grigia di cui parlava Primo Levi, è il silenzio degli amici che preoccupava Martin Luther King più delle parole dei nemici». La stessa indifferenza, continua Pasta, che va combattuta fin dalla scuola: «Quando mi capita di fare formazione agli insegnanti su temi come il cyberbullismo, dico sempre di preoccuparsi non solo dei bulli e delle vittime, ma soprattutto degli altri; la prevenzione di tali fenomeni si fa educando il gruppo classe, non favorendo atteggiamenti di conformismo passivo, bensì promuovendo empatia verso le vittime, educando a una cittadinanza digitale, uno sforzo a cui tutti siamo chiamati». Il web sociale, come altre tecnologie del nostro tempo, è prima di tutto una grande opportunità a cui dobbiamo, però, essere educati, un’educazione rivolta alla fruizione, ma soprattutto alla produzione di quei contenuti culturali che creano una comunità.
Per segnalare fenomeni di odio online, dal novembre 2021, la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha attivato la piattaforma: www.reportonlineracism.ch