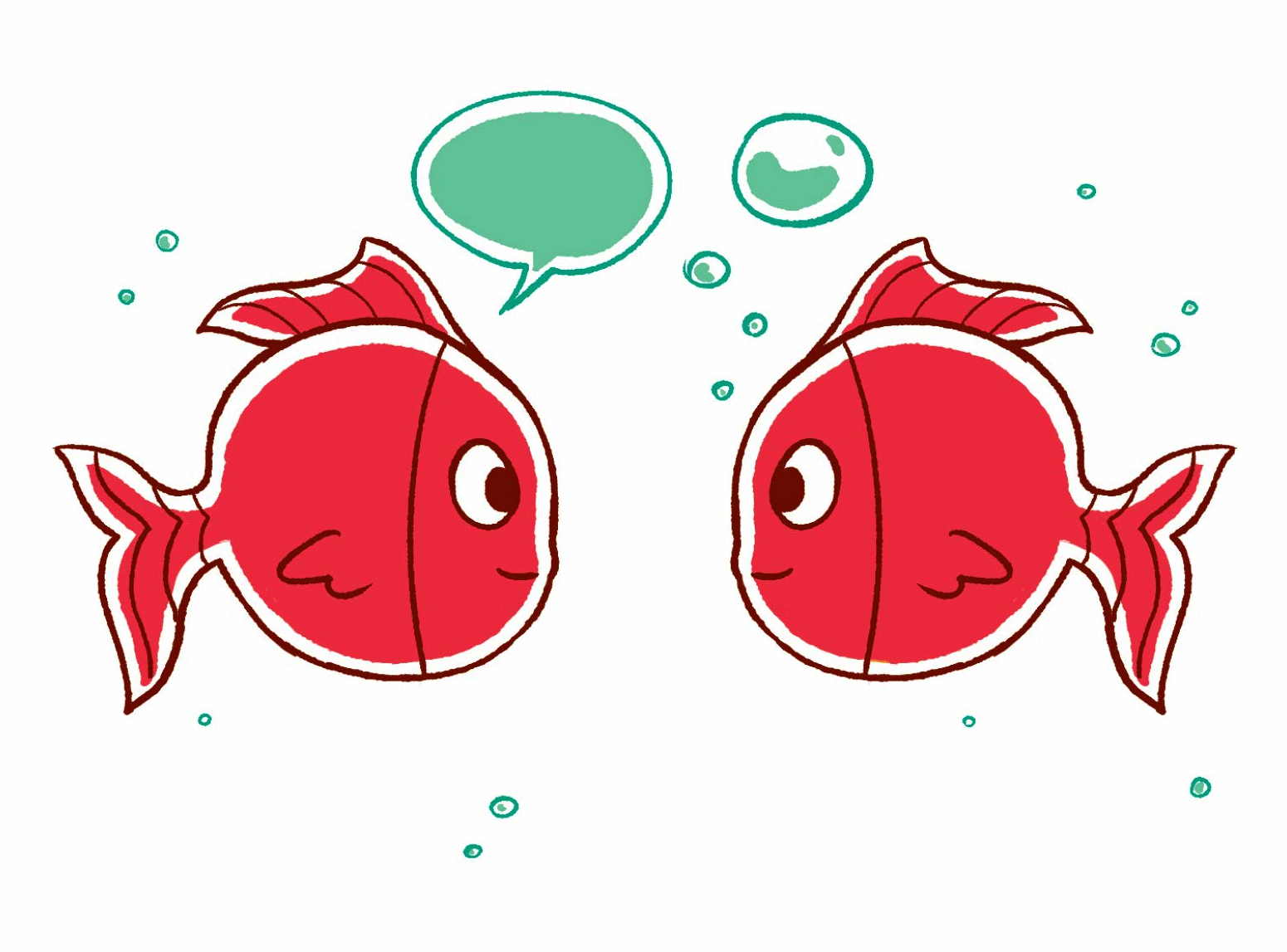Jean-Christophe Seznec, psichiatra francese, non ha dubbi: la semplicità e la rapidità con cui possiamo esprimerci attraverso la tecnologia e l’idea che esistiamo solamente se comunichiamo, ci hanno fatto dimenticare la virtù del silenzio. Messaggi scritti e vocali, e-mail e post si moltiplicano nelle nostre giornate, rimbalzando e circolando a una velocità tale da diventare irrecuperabili già dopo pochi minuti. I testi aggressivi e «tossici» vengono trasmessi con la stessa impulsiva facilità di quelli amichevoli. Sopraffatti da questo vortice compulsivo, facciamo fatica a recuperare il potere delle parole e i benefici delle pause. Per aiutarci a trovare una dimensione meno frenetica, Seznec, che è anche presidente dell’Aftcc (Associazione francese di terapie comportamentali e cognitive) ha scritto, in collaborazione con Laurent Carouana, La magica virtù di misurare le parole. Quando tacere, come parlare (Feltrinelli).
Jean-Christophe Seznec, come è nata l’idea di questo libro?
All’inizio la mia idea era di scrivere un libro sulla comunicazione, un manuale su come esprimersi al meglio. Poi c’è stato l’attentato alla sede del giornale satirico «Charlie Hebdo». Il loro umorismo, in Francia, non dava fastidio a molte persone. Chi non lo gradiva, semplicemente evitava di leggere il giornale. Con quell’attacco abbiamo scoperto che ciò che dicevamo qui, in Francia, poteva influenzare persone che vivevano dall’altra parte del mondo con una cultura e una prospettiva diversa dalle nostre. È diventato chiaro che il discorso decontestualizzato può assumere un altro significato ed essere fonte di incomprensione, anche drammatica, come nel caso di «Charlie Hebdo». Il discorso è contestuale: Pierre Desproges, un comico francese, dice a questo proposito che si può ridere di tutto, ma non con tutti. Oggi, con la globalizzazione e i social network, non sappiamo più a chi arrivano le nostre parole. Ed è sotto gli occhi di tutti quanto circolino facilmente notizie false, teorie cospirative e troll. Allora ho pensato, tra me e me, che in questo nuovo contesto, fosse più interessante riflettere sullo stare zitti invece di scrivere un libro sul parlare. Inoltre, il mio interesse per la meditazione ha accentuato la percezione delle devastazioni che derivano dal commentare costantemente la propria vita e il mondo. Le parole impoveriscono la realtà. Dico spesso che la vita è come una partita di calcio: per giocare, devi essere sul campo. Se commenti, stai sugli spalti. Saper tacere per contemplare e apprezzare l’esperienza sensoriale, usando lo stesso metodo di quando si medita, ci permette di assaporare la ricchezza della vita.
Perché le parole sono importanti e perché le sprechiamo?
Le parole che diciamo oppure che pensiamo sono stimoli che risuonano nella nostra interiorità. Dentro di noi scatenano pensieri, sensazioni fisiche ed emozioni. Ci agganciano per trascinarci verso un’esperienza emotiva. Se giudico una situazione grave, sveglio il mio cervello emotivo che può arrivare ad alterare la realtà, che di fatto magari è soltanto spiacevole o scomoda. È quindi importante scegliere le parole per descrivere correttamente una situazione e non indossare occhiali emotivi distorti, col rischio di scatenare sofferenze interne. A volte usiamo troppe parole, con noi stessi e con gli altri: è il nostro cervello emotivo, il nostro doberman, come lo chiamo nel libro, che prende il sopravvento e abbaia per cercare di rassicurarci. Ci vuole molto lavoro per imparare a convivere con la fragilità umana e per far fronte al disagio. Parlare, a volte, è come agitarsi nelle sabbie mobili: siamo tentati di farlo, ma così sprofondiamo ancora di più nella sofferenza.
Quindi dovremmo parlare meno?
Non ci sono regole uguali per tutti. Il discorso è contestuale: dipende dalla propria personalità, cultura o situazione. Tuttavia, incoraggio tutti a diffidare dei commenti interiori. E consiglio di aspettare che una situazione si definisca, in modo da evitare reazioni impulsive. Restando fermi, senza cedere all’azione immediata, permettiamo all’intelligenza emotiva di emergere.
Ha qualche consiglio per aiutarci a controllare le nostre parole?
Consiglio di respirare, dando tempo alla nostra mente di stabilizzarsi e diventare limpida. Come dicono le nonne francesi, è utile girare la lingua sette volte in bocca prima di parlare. Parlare è come la musica, i silenzi sono utili, impediscono che i discorsi si trasformino in rumore. Dopo ogni frase che pronunciamo, facciamo un bel respiro di pancia per prenderci il tempo di connettere e allineare corpo, testa ed emozioni. È un esercizio che aumenta la consapevolezza e ci insegna ad agire come la rana: nonostante si renda conto di tutta l’agitazione che la circonda, non si muove, ma gracida e salta solo se necessario.
E per quanto riguarda le parole sui social media? Vale lo stesso discorso?
Sui social media suggerisco di non reagire a caldo perché non sappiamo chi leggerà le nostre parole, quale sarà il suo contesto di riferimento. Pensiamo ad esempio al numero 6: può essere percepito da qualcuno come un 9 e questo fraintendimento può diventare l’inizio di un conflitto. Drammi come l’attentato a «Charlie Hebdo» sono nati dall’errata interpretazione delle caricature dovute a differenze culturali. Allo stesso modo i social media possono diventare fonte di distorsioni, conflitti e violenze. Il mio consiglio è di non partecipare al rumore generale. Nel contesto attuale, possiamo fare nostra la scommessa pascaliana: molto spesso abbiamo più da guadagnare nel tacere che nel reagire a certe pubblicazioni. Scegliamo di coltivare la pace dentro e fuori di noi. Lo scontro porta solo allo scontro.