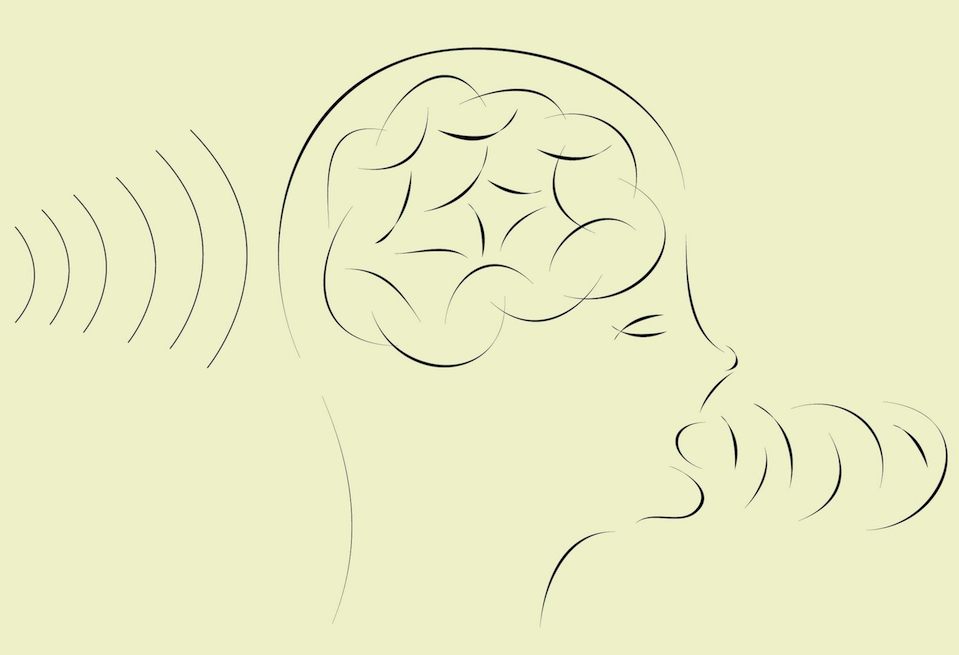Inglese trasferitasi negli Stati Uniti, Ann Lesley Brown è stata una psicologa dell’educazione che ha posto al centro dei suoi interessi la rilevanza della comunità di ricerca. Il suo programma denominato Fostering Community of Learners (FCL) concepiva l’attività didattica come un laboratorio sempre aperto, dove la massima rilevanza era data al lavoro di squadra nel corso dell’apprendimento.
Ampio spazio alla ricerca e alla pratica didattica di Ann Brown è dato dai due scienziati cognitivisti Steven Sloman e Philip Fernbach, sintetizzando il risultato delle loro più recenti indagini nel libro intitolato L’illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli. I due ricercatori giungono alla conclusione che ciascuno di noi vive nell’illusione di sapere tante cose perché, inconsapevolmente, facciamo affidamento alle conoscenze distribuite nelle cose che ci stanno attorno e nelle menti degli altri, cosicché è tempo di concepire non più l’intelligenza come una prestazione individuale bensì come l’abilità di contribuire al successo di un gruppo.
Sullo sfondo del modello sviluppato da Ann Brown stanno le intuizioni dello psicologo russo Lev Semënovič Vygotskij. Vygotskij pensava alla mente come ad un’entità sociale e al pensiero come ad un’attività dialogica. Riflettendo su di noi in quanto specie, Vygotskij osservava che non è tanto la nostra potenza cerebrale individuale a distinguerci, quanto piuttosto la nostra abilità ad imparare attraverso le altre persone e le altre culture. Descrivendo ciò che essi intendono con il concetto di «comunità di conoscenza», Sloman e Fernbach dichiarano apertamente tutto il loro debito nei confronti di Vygotskij e della sua idea che la nostra mente ha un carattere marcatamente sociale.
Alle questioni pedagogiche e psicologiche Sloman e Fernbach giungono però solo in un secondo momento, dopo aver dato una spiegazione alla nostra illusione di sapere: «il punto, per noi, non è che le persone siano ignoranti; è che le persone siano più ignoranti di quanto pensano di essere». Abbiamo un’idea vaga di come funziona un sifone, pur usando più volte ogni giorno; non sappiamo perché l’acqua esce dal rubinetto; pochi sanno disegnare una bicicletta in maniera che davvero possa funzionare – per restare alle cose di tutti i giorni. E quando, poi, dobbiamo spiegare a parole ciò che riteniamo di sapere, allora diventa evidente tutta la nostra ignoranza: «ignoriamo la complessità sopravvalutando quanto sappiamo sul funzionamento delle cose».
Secondo Sloman e Fernbach tutto ciò è normale e non serve sorprenderci per due motivi: prima di tutto perché il pensiero è una forma di azione e, quindi, ricordiamo e sappiamo quanto è funzionale alle nostre necessità, secondariamente perché, nel corso della nostra evoluzione, «abbiamo avuto molto successo nel suddividere il nostro lavoro cognitivo». Ciò significa che noi abbiamo l’illusione di sapere «perché sbagliamo nel tracciare una linea precisa tra ciò che è dentro e ciò che è fuori dalle nostre teste». Non ci rendiamo conto fino a quale grado è «sociale» il nostro «personale» sapere.
I risultati delle ricerche condotte da Sloman e Fernbach fanno emergere una serie di evidenze che contrastano con alcuni luoghi comuni. Per esempio, i due autori hanno attirato l’attenzione sul fatto che il nostro pensiero è specializzato nell’applicazione del principio di causalità, spingendoci a cercare rapporti di causa/effetto in tutto ciò che incontriamo. Purtroppo, questo principio è spesso inadeguato per descrivere fenomeni complessi perché tende a fornire soluzioni semplicistiche. In generale, non notiamo questa eccessiva semplificazione perché la condividiamo con il gruppo sociale al quale apparteniamo. Inoltre, tendiamo ad usare una rapida scorciatoia, quando ci rendiamo conto che facciamo fatica a comprendere dei fenomeni complessi: ricorriamo ai «valori». Questa tendenza è molto evidente nel dibattito politico: i «valori sacri» di una fazione o di un’altra, non solo sono il collante di una comunità, ma sono un ostacolo alla ricerca delle conseguenze delle scelte politiche: «i cittadini, i commentatori e i politici prendono spesso posizione prima di impegnarsi in un’analisi seria dei pro e contro di una proposta di legge». Ciò significa che, in un mondo globalizzato e complesso, nel dibattito politico ci comportiamo come quando vivevamo in minuscole comunità, nelle quali il ricorso ai «valori sacri», in certe situazioni di urgenza, permetteva di tener salda la coesione del gruppo.
C’è un altro, importante, aspetto che caratterizza in maniera molto specifica la nostra ignoranza. Steven Sloman e Philip Fernbach l’hanno messo in evidenza studiando in modo in cui le persone valutano il sapere scientifico. A domande del tipo: «è vero o falso che normalmente i pomodori non contengono geni, mentre i pomodori geneticamente modificati li contengono», la maggior parte dei loro intervistati ha risposto che è vero. Ciò succede perché la comprensione di come funzionano le mutazioni genetiche è molto vaga, cosicché si tende ad equipararla ad altri fenomeni: «le persone pensano alla modificazione genetica così come pensano ai germi». Ma l’aspetto socialmente più interessante osservato da Sloman e Fernbach è che la divulgazione della corretta informazione scientifica non muta questo genere di false convinzioni perché esse «sono strettamente intrecciate con altre credenze, con i valori culturali condivisi e con le nostre identità». Ciò comporta che a certe forme di ignoranza non possiamo rinunciare perché sono condivise dalla comunità di cui facciamo parte e dalla quale saremmo esclusi se cambiassimo idea. «Le nostre convinzioni non sono proprio nostre, sono condivise dalla nostra comunità. E questo le rende davvero difficili da cambiare».
La nostra conoscenza è dunque legata a doppio filo con la comunità in cui viviamo: da un canto, inconsapevolmente, ci appoggiamo sulla «comunità della conoscenza» sia per arricchire le nostre conoscenze sia per illuderci di averne più di quanto effettivamente ne abbiamo, d’altra parte, questa stessa comunità, c’impone credenze e valori che c’impediscono di assumere altri punti di vista e verificare le convinzioni condivise. «Non pensiamo mai da soli» proprio perché siamo tra questi due poli.