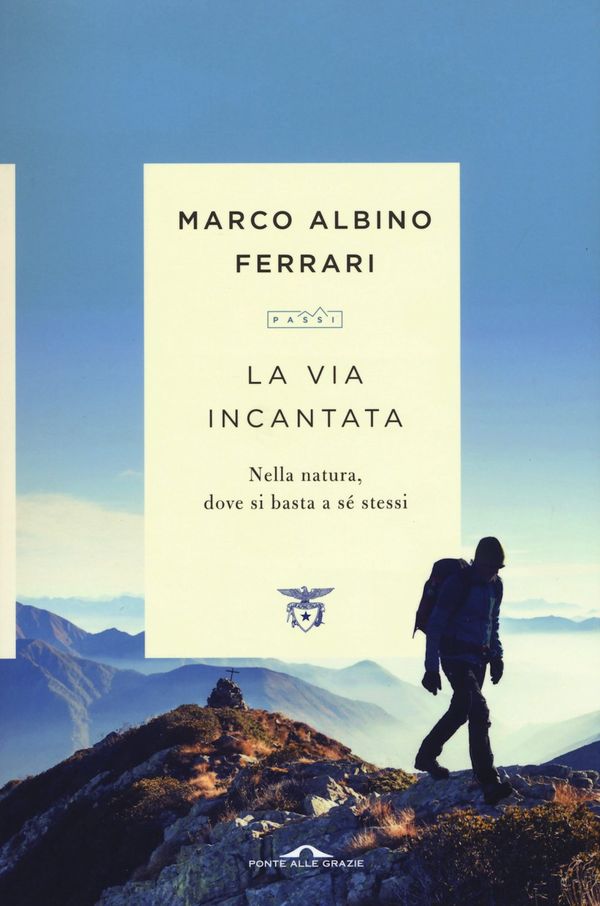Nel corso di questa rubrica ci è capitato più volte di confrontarci con scrittori sopraffini. È il caso di Gilles Clément, è il caso di Pia Pera ed è anche il caso del fondatore e direttore del periodico «Meridiani Montagne» Marco Albino Ferrari. L’ultimo suo libro fresco di stampa per la casa editrice Ponte alle grazie e intitolato La via incantata è una straordinaria lettura, per leggerezza e per grazia. Anche qui torna l’intreccio natura/letteratura, cercata lungo tutto il romanzo nel rapporto fra l’esploratore piemontese Giacomo Bove e Emilio Salgari – quando Bove si sparò, l’autore del Corsaro nero seguì la vicenda da cronachista e ne ricavò tre articoli.
Con una penna abile, capace di tenere attaccato il lettore e al contempo in grado di non sovraccaricare mai il testo, lasciando spazio all’aria, ai vuoti, seguendo la lezione di Calvino, Ferrari, aduso alla montagna sin da piccolo per via dell’iniziazione materna alle passeggiate e anche alle scalate, ci porta sulle tracce di Bove, diviso fra vita mondana e spedizioni, fra i ghiacci nordici e il Sud del mondo. Il punto più entusiasmante e iperbolico della narrazione è certamente da rinvenirsi nella spedizione artica che, lavorata dalle sapienti mani dello scrittore e giornalista, diventa una parabola lucente, immersa com’è fra le aurore boreali, le giornate con una sola ora di buio e quelle, al contrario, con pochissime ore di luce. Sono quelle giornate lunghe a sostanziare le trentacinque lunghissime e intense settimane di pausa e attesa per attendere il disgelo che permetterà a Bove e ai suoi di trovare il Passaggio di Nord-Est dopo tre secoli di tentativi infruttuosi.
Su questa avventura è caduta una damnatio memoriae ideologica, conseguenza evidente della decisione da parte di Bove di togliersi la vita dopo mesi di sofferenze inaudite causate da una malattia contratta in Africa – spedizione che oltretutto gli era stata imposta e che aveva accettato più con la testa che con il cuore. Ma – e Ferrari ce lo spiega – non tutto del grande esploratore è andato perso, se è vero che Emilio Salgari si immedesimò in lui rivivendone su pagina le avventure e il coraggio, pur sottacendo la fonte, ed emozionando con le stesse generazioni e generazioni di grandi e giovani lettori. Bove aveva il coraggio e il cuore, Salgari, una sorta di Bove rinato su carta, la penna. Marco Albino Ferrari entrambe le cose: chi si accinge a esplorare le montagne s’avventura nell’ignoto, non sa veramente dove andrà a finire, cosa scoprirà, quando giungerà alla meta.
Con un giovane fotografo, l’autore compie un’escursione ambiziosa, quella lungo il sentiero Bove, la più alta via delle Alpi dove una volta vivevano uomini con una percezione completamente diversa del tempo, uomini costretti a condizioni estreme e per questo capaci di andare all’osso, all’essenza delle cose. Ecco perché ha un senso immergersi di nuovo nella wilderness, lontani dalla società positivista, per ritemprarsi in una solitudine assoluta che ricorda quella abbacinante vissuta da Bove e dai suoi a bordo della «Vega», nel punto più alto del globo, in una dimensione spazio-temporale aperta a interpretazioni pronte ogni volta a contraddirsi e a riaprirsi di nuovo, nello sgretolarsi dei confini geografici e al contempo mentali.
Un’avventura del genere, Ferrari l’ha vissuta – e ce l’ha trasmessa – anche sull’isola di Montecristo, ne abbiamo parlato nel corso di questa rubrica. Anche lì, l’immaginario letterario creato dal romanzo di Dumas si sposava con una natura stupefacente, intatta, quasi del tutto inaccessibile all’uomo. Ha senso che vi siano zone protette, in Italia, fra i nostri monti, dove è interdetto l’accesso all’uomo? Se lo chiede Ferrari, e la risposta è ovvia. Sì, ha senso, ha senso nella misura in cui diamo ancora un senso all’immaginario. Alla letteratura, quindi, a quello che del paesaggio rimane depositato come cenere in zone remote e forse inaccessibili della nostra psiche. E rinasce, e poi rimuore, rinascendo ancora e sgretolando i confini tremuli di quella che per convenzione chiamiamo realtà.