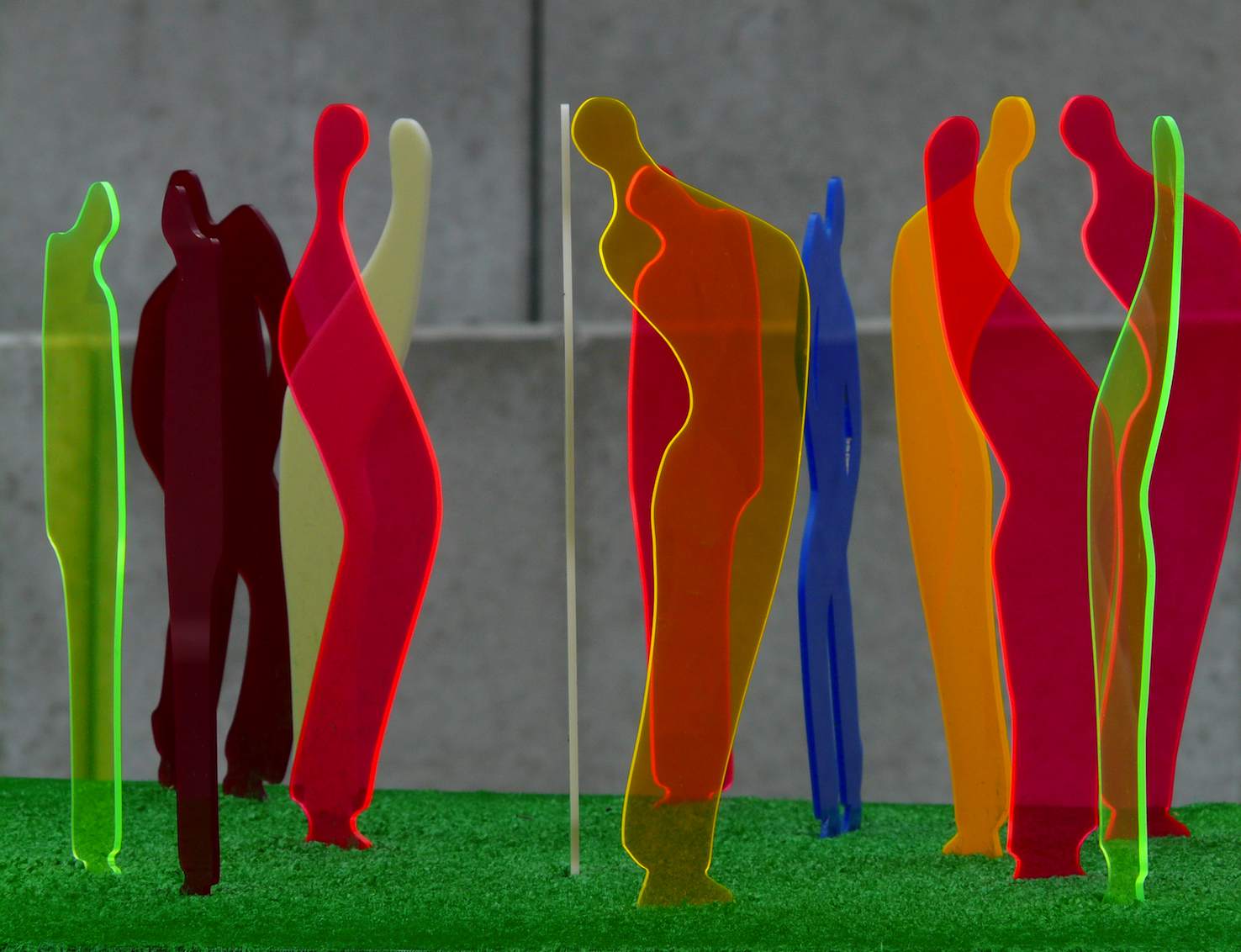Innanzitutto la plastica non è una, non è una monade. Poi, le plastiche sono sostanze organiche (come il legno e la lana, ad esempio) e derivano da risorse naturali: prevalentemente petrolio, carbone e gas, cioè prevalentemente da combustibili di origine fossile. Chi lo avrebbe mai detto o chi se lo ricordava?
Oggi esistono svariati tipi di plastiche, che si differenziano sia per l’origine sia per gli additivi aggiunti ed i processi di lavorazione, ma tutti hanno in comune alcuni elementi base: le materie plastiche sono sostanze costituite da macromolecole (polimeri) ad alto peso molecolare. Si conferiscono loro le caratteristiche tecnico-chimiche e fisiche (tramite l’aggiunta di composti) e le forme volute mediante numerosi processi tecnologici: riscaldamento, compressione, condensazione, calandratura, soffiaggio, stampaggio, ed altri.
In origine, molte materie plastiche derivavano da resine di origine vegetale, ad esempio dalla cellulosa (dal cotone), dagli oli (dai semi di alcune piante), dai derivati dell’amido e del carbone; ed alcune dagli scarti di lavorazione dell’industria casearia: dalla caseina (dal latte). Il nylon, ad esempio, era un composto prodotto da carbone, acqua e aria. Oggi la maggior parte delle plastiche deriva dai prodotti petrolchimici: la produzione mondiale di materie plastiche ne assorbe circa il 4 per cento annuo.
La prima plastica ad avere avuto un discreto successo commerciale, la celluloide, fu prodotta negli anni 1870 circa ed era di origine naturale: era infatti un derivato dalla lavorazione della cellulosa. Alcuni polimeri sintetici, come il rayon ed il cellophane, provengono dalla cellulosa che è un polimero naturale, come la cera ed il caucciù. La bachelite invece, creata nel 1907, fu la prima plastica interamente sintetica.
Negli anni successivi alla prima guerra mondiale furono scoperti numerosi materiali plastici (fra cui il PVC, il teflon ed il plexiglas) ma la vera svolta venne data negli anni del secondo dopoguerra, con le ricerche sui polimeri effettuate dai chimici tedesco Ziegler ed italiano Natta, i quali nel 1963 ottennero il premio Nobel per la chimica. L’impulso alla ricerca, alla produzione ed all’utilizzo delle plastiche fu determinato dalla difficoltà di reperire le materie prime naturali e dal loro costo, sia durante il periodo più duro della seconda guerra mondiale sia soprattutto successivamente, negli anni della crescita. Una delle motivazioni primarie fu quella di trovare alternative alla gomma naturale, che non era di facile importazione, ed ai tessuti naturali, per cui crebbe la produzione del nylon e delle gomme sintetiche.
Furono scoperti e realizzati materiali innovativi, molto più economici e polivalenti delle materie prime naturali, i quali vennero utilizzati al posto di quelli metallici come componenti di macchinari e dispositivi impiegati in condizioni di temperature estreme (sia elevatissime sia molto basse) per le qualità di bassi coefficienti di dilatazione termica con elevata resistenza dimensionale, di alta resistenza all’alterazione chimica e meccanica, agli urti, alle intemperie, la trasparenza, la rigidità, la resistenza, l’isolamento elettrico, termico ed acustico, e tanti altri.
Oggi i derivati delle materie plastiche sono ovunque. Non ce ne accorgiamo, ma la nostra vita quotidiana è possibile, nella sua forma attuale, solamente grazie ad essi, e ne restiamo sorpresi. Quasi tutto ciò che è manufatto, se non è di metallo, di vetro o di legno, è costituito anche o esclusivamente da plastiche. Su un piano squisitamente teorico, esisterebbero delle alternative in innumerevoli utilizzi, ma spesso impiegarle richiederebbe più energia e più emissioni, nella loro manifattura, delle materie plastiche che andrebbero a sostituire. Ad esempio, i metalli (ferro ed alluminio) ed i loro derivati (acciaio) necessitano di enormi quantità di energia per essere prodotti (sia dalla materia prima, sia dal riciclo), oltre a considerare l’esauribilità delle miniere e dei giacimenti e le condizioni sociali correlate all’industria estrattiva.
I materiali plastici sono più resilienti e leggeri dei metalli, caratteristiche che li rendono componenti di elezione nelle costruzioni di ogni tipo, ad esempio quella delle automobili, dove il loro utilizzo consente di ridurre una serie di costi: in primis il consumo di carburante. Essi vengono impiegati praticamente in tutti i settori per le loro caratteristiche di facile lavorabilità e basso costo: dall’industria dell’imballaggio a quella dell’edilizia, da quella della componentistica all’arredamento, dall’elettronica ai beni di consumo, solamente per fare alcuni esempi.
Il settore agricolo assorbe il 3,9 per cento delle materie plastiche prodotte in Italia. La possibilità di poter disporre tutto l’anno di prodotti agricoli stagionali si deve proprio alla plastica con cui si realizzano i teloni che ricoprono le piantagioni. Essi le proteggono, le stimolano, fino ad anticipare le colture e incrementare i raccolti, promuovendo così un settore spesso in difficoltà. Le serre con coperture di plastica sono di più facile realizzazione, rendono di più e hanno bisogno di meno energia per venire riscaldate rispetto a quelle in vetro. Anche nell’irrigazione dei campi, le strutture e i tubi in plastica hanno dimostrato versatilità ed efficienza. Grazie a tubazioni in PVC si è riusciti ad irrigare zone in cui la natura dei terreni o la particolarità delle acque compromettevano la durata di tubi in cemento o metallo.
Il settore dell’imballaggio è di gran lunga quello di maggior sbocco per le materie plastiche e la sua importanza continua ad aumentare grazie alla versatilità, alla leggerezza, alla robustezza, all’inerzia chimica, alla buona impermeabilità ai gas e all’economicità. Questo settore assorbe circa il 44 per cento della plastica prodotta. Le materie plastiche trovano importanti applicazioni nel settore farmaceutico. Basti pensare ai farmaci protetti dai blister termoformati, oppure ai numerosissimi oggetti ed attrezzature impiegate in medicina e chirurgia (tende ad ossigeno, guanti sterili, oppure presidi salvavita, come il cuore artificiale o le sacche per il trasporto di sangue e plasma, le sacche per la dialisi, i cateteri ed i tubicini per le trasfusioni), senza entrare nel merito delle apparecchiature a scopo diagnostico o terapeutico.
Considerando tutte queste proprietà positive, da dove nascono i problemi? Come spesso accade i problemi conseguono dall’ignoranza, oltre alla scarsa degradabilità dei materiali plastici, la quale determina la longevità dei prodotti. La buona notizia è che conosciamo quasi perfettamente il problema, che deriva in gran parte da errate abitudini, e che pertanto abbiamo il dovere di limitarlo.
Seguiteci nel prossimo reportage per scoprire le più recenti tecnologie per abbattere l’inquinamento derivato dall’abuso di materiali plastici e dal loro non corretto smaltimento.