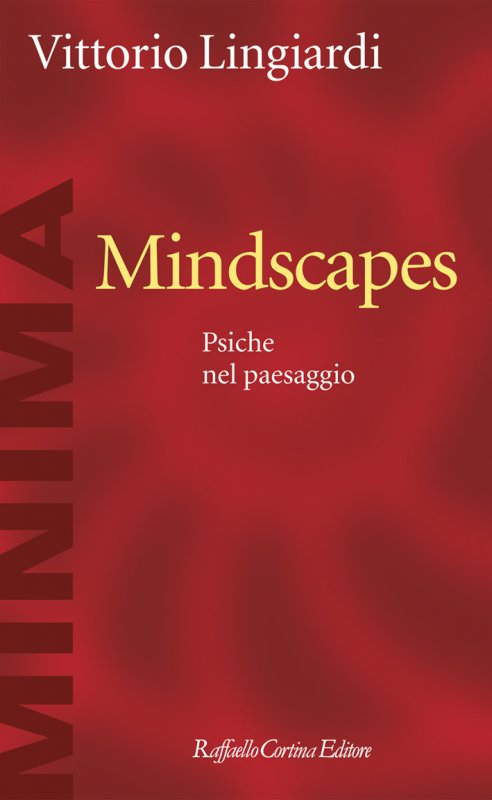Che cosa cerchiamo in un paesaggio? E che tipo di esperienza è quella che ci porta a immergerci in ciò che vediamo fuori di noi? Il saggio dello psicanalista Vittorio Lingiardi, professore ordinario di psicologia dinamica presso la facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, si intitola Mindscapes ed è stato pubblicato da Raffaele Cortina editore. Pagine dense e pregne che ci raccontano del legame fra poesia, psicoanalisi e paesaggio, svelandoci quanto di noi ci sia in quello che vediamo. Una geografia sentimentale che abbiamo voluto approfondire con l’autore stesso.
Professor Lingiardi, questo libro – così si legge dalla prefazione – nasce da uno di quei vizi sani: quello di raccogliere, prendendole nei musei, alle mostre, cartoline con quadri di paesaggi. Perché?
In effetti, questo libro porta i segni della mia inclinazione ossessiva per la raccolta, la collezione, la ricerca di corrispondenze intime tra le cose. Ma contiene anche la disinvoltura che mi rende insofferente alle gabbie disciplinari e mi permette di passare da un campo all’altro per costruire dialoghi. Mindscapes contiene tre «p»: poesia, psicoanalisi, paesaggio. Perché raccolgo cartoline di paesaggi? Perché i luoghi sono memoria. I paesaggi di cui parlo, questo mondo di mezzo in cui noi siamo là ma quel là è anche in noi, sono per me vere e proprie strutture psichiche. Il paesaggio non è semplice «bel-vedere» (quindi in tal senso non è una cartolina), è un’esperienza fisica, e quindi psichica. Il paesaggio richiede immersione. Una parola che mi ha aiutato a mettere a fuoco questa predilezione è quella coniata da uno dei più grandi poeti italiani, Andrea Zanzotto, il quale parlava di «paesaggire» per descrivere l’esperienza umana nel paesaggio, il nostro stare fisico nel paesaggio inteso come «deposito di tracce». Il paesaggio è la patria dei nostri pensieri, possiamo anche non vederlo. Il filosofo Merlau Ponty parlava del bastone del non vedente come dell’estensione del suo sguardo, estremità che si è trasformata in zona sensibile. Il panorama non è necessario, conoscere il paesaggio è stare al mondo.
C’è sempre una prima volta. Qual è il primo paesaggio che abbiamo visto, che abbiamo conosciuto?
Quello di chi si è preso cura di noi. Quando parla del neonato che guarda la madre, Winnicott usa un’immagine meravigliosa: dice che è come un meteorologo, scruta il volto materno per vedere se è illuminato dal sole o attraversato dalle nuvole. La presenza della meteorologia nella relazione primaria non può che evocare il tema del paesaggio. Leggendo saggi di psicoanalisi (Freud e la Klein, per esempio) si incontrano affascinanti descrizioni di bambini che si arrampicano sul corpo materno, scoprono i seni, la pancia, le gambe, il viso, e fanno dello stesso corpo materno, oppure di quello paterno, una geografia di esperienze sensoriali. In altre parole potremmo dire che la struttura del legame di attaccamento è geografica.
Il paesaggio è presentissimo anche nei sogni.
Sì. Una delle scoperte più belle che ho fatto andando a rileggere la letteratura psicoanalitica durante l’ideazione e la stesura di questo libro, riguarda proprio la presenza del paesaggio nei sogni. I sogni sono pieni di traversate, gole, mari, immersioni, deserti. L’analista deve viaggiare tra paesaggi reali e psichici, esterni e interni. Vi sono strutture fondanti la psicanalisi, per esempio il mito, che sono assolutamente inserite nel paesaggio. Il mito di Edipo, per esempio – e lo vediamo nei tanti dipinti che lo raccontano, da De Chirico a Bacon – è immerso nel paesaggio: l’incrocio delle strade, la rupe. Il materiale onirico, l’elemento inconscio, è anche l’esperienza primaria del sogno.
Quando si incontra una persona che inizia l’analisi, dove si finisce?
È come entrare in una città. Ogni mondo psichico ha i suoi parchi, i suoi vicoli, le sue piazze, le sue aree dismesse. Il mondo interno è come una città che può essere percorsa attraverso l’analisi. Camminare nella città perdendo tempo coincide con l’importanza di disorientarsi nel paesaggio per infine ritrovarsi.
Mare o montagna?
Mi sono posto questa domanda che sembra apparentemente banale, ma non lo è. Perché preferiamo andare in un posto piuttosto che in un altro? Perché in quel paesaggio è custodito un «oggetto perduto», forse il viso di chi per primo ci ha guardato, o ha distolto lo sguardo. È un luogo che non può che essere dentro di noi.