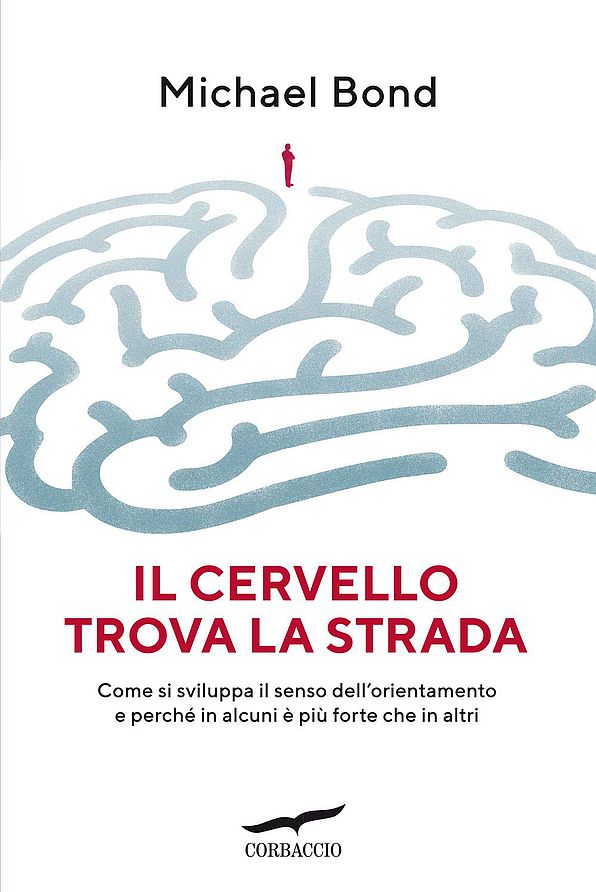I dispositivi Gps ci indicano dove andare, guidandoci senza che per noi sia necessario impiegare le facoltà cognitive sviluppate nel corso delle migliaia di anni dell’evoluzione umana. Affidandoci esclusivamente allo smartphone, quando ci muoviamo in auto o a piedi, rischiamo però di perdere l’allenamento al senso dell’orientamento. Senza anatemi contro le nuove tecnologie, il giornalista scientifico Michael Bond, nel saggio Il cervello trova la strada (Corbaccio), ci invita a riflettere su come il senso dello spazio influenzi la nostra psiche e i nostri comportamenti.
Michael Bond, i dispositivi Gps ci tolgono la capacità di vivere lo spazio?
Premetto che i Gps sono tecnologie eccellenti. Dobbiamo solo ricordarci che quando le utilizziamo blocchiamo l’ippocampo, la parte del cervello nella quale si trovano molte delle cellule «spaziali» che permettono di orientarci. Possiamo anche pensare che vada bene così, ma quando non si usa un organo, non lo si esercita, questo si deteriora. Inoltre, coi Gps seguiamo le istruzioni e diventiamo inconsapevoli di ciò che ci circonda, non guardiamo quello che abbiamo attorno e non lo ricordiamo. Io non dico di smettere di usare questi dispositivi esterni, ma di farlo in modo più creativo, ad esempio con la modalità Street View, cioè con riferimenti fotografici che incoraggino a osservare in maniera attiva, non soltanto eseguendo l’ordine dello smartphone. Oppure, possiamo vedere la direzione di massima e poi proseguire da soli.
Quali altri conseguenze dell’uso esclusivo dei Gps ci possono essere a livello cognitivo?
Non sappiamo ancora quali siano gli effetti a lungo termine. Alcuni neuroscienziati stanno cercando di capire come le demenze siano collegate all’incapacità di orientarsi nello spazio. Infatti, la prima abilità che le persone con una demenza perdono è proprio il senso dell’orientamento. Al momento, comunque, non possiamo dire nulla di esaustivo al riguardo, le ricerche sono all’inizio e ci sono molti fattori in questione.
Come si è sviluppato il senso dell’orientamento nel corso dell’evoluzione umana?
Tra i 150 e i 100mila anni fa, in Africa, gli esseri umani iniziarono a percorrere distanze molto ampie. Vivevano in piccoli gruppi e viaggiavano, camminavano per centinaia di chilometri per incontrare altri esseri umani, per commerciare o scambiare storie o informazioni. Viaggiare faceva parte della vita quotidiana ma per sopravvivere dovevano riuscire a ricordarsi dove stessero andando, come fosse il paesaggio, se avessero cambiato direzione per aggirare una collina oppure un fiume. Secondo diversi studi, sembra che la nostra capacità di orientamento venga proprio da lì.
Perché abbiamo paura di perderci?
La nostra paura sembra risalire a quel periodo. Proviamo a immaginare di trovarci in quello scenario africano e perderci. Non c’erano molti esseri umani in giro, ma animali pericolosi che ci avrebbero uccisi e mangiati. E non avremmo avuto accesso nemmeno al cibo, perché si cacciava in gruppo. Perdersi significava morire. Oggi possiamo provare un grande senso di paura e ansia legato a quell’istinto. Di fatto, ci sono ancora luoghi nel mondo dove perdersi potrebbe diventare catastrofico.
Come funziona il cervello quando deve orientarsi?
Il principale meccanismo spaziale del cervello risiede nell’ippocampo, un’area che possiedono tutti i mammiferi. Negli ultimi cinquant’anni, i neuroscienziati hanno scoperto che quest’area contiene alcune cellule che si sono sviluppate per aiutarci nell’orientamento. Ci sono le place cells (cellule di posizione) che lavorano per informarci dove ci troviamo e dove siamo stati. Ad esempio, la prima volta che entriamo in una stanza, queste cellule si attivano insieme in uno schema particolare che poi diventa fisso. Quindi se usciamo e torniamo un’ora dopo, le place cells si riattivano esattamente nello stesso modo. Nell’ippocampo ci sono anche le head-direction cell (cellule testa direzione) che funzionano da bussola interna, le grid cells (cellule a griglia) che ci dicono quando ci spostiamo e verso dove e le boundary cells (cellule confine) che si attivano quando siamo vicino a un muro o a una parete. Tutte queste cellule ci danno una memoria dello spazio, chiamata dai neuroscienziati «mappa cognitiva», che ci fornisce una rappresentazione del mondo esterno.
Quanto è importante il ricordo dei luoghi?
I nostri ricordi sono legati ai posti dove abbiamo fatto le esperienze nella vita. Se incontriamo alcuni amici facendo una camminata, il ricordo di quel posto sarà legato agli amici e a quello di cui si è parlato. Ci sono luoghi per i quali abbiamo sentimenti profondi: quando ci torniamo, riviviamo certe emozioni. Sembra che il cervello usi la memoria spaziale come via di accesso e come struttura per altre memorie.
Che cos’è la consapevolezza spaziale e perché si crede che le donne siano meno predisposte a orientarsi?
La consapevolezza spaziale è la capacità di capire il posto in cui si è e cosa si ha attorno. Si tende a ritenere che le donne siano meno predisposte degli uomini a orientarsi per ragioni biologiche, ma non è vero. Sappiamo che il fatto che gli uomini dimostrino performance leggermente migliori nell’orientamento è dovuto alla cultura. Una delle spiegazioni più plausibili è data dal modo in cui bambine e bambini vengono cresciuti. In genere, i genitori tendono a restringere i movimenti delle bimbe rispetto a quelli dei bimbi perché le considerano più vulnerabili e sono inclini a farle restare più vicine a casa. Un elemento non di poco conto considerando che il modo migliore per sviluppare il senso dello spazio è sperimentare fin da piccoli. Inoltre, il pregiudizio sulle donne fa sì che, anche quando crescono, non vengano incoraggiate a intraprendere attività che riguardano l’orientamento. È un circolo vizioso: se si pensa di non essere brave in qualcosa alla fine non lo si diventa, e non certo per ragioni biologiche.
* L’intervista è stata tradotta e in alcuni passaggi adattata dalla giornalista.