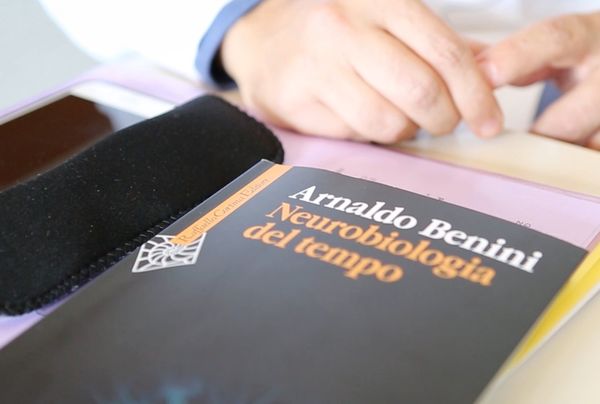Secondo Sant’Agostino «Se nessuno mi domanda cos’è il tempo, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più». Secondo l’astrofisico britannico Stephen Hawking «Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ne ha una propria personale misura che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo». Per Einstein solo l’ostinata illusione degli sprovveduti tiene in vita la differenza fra passato, presente e futuro e il tempo è relativo alla velocità: «Più alta la velocità, più lento il tempo». E oggi la neurobiologia considera il tempo come un prodotto del nostro cervello, come spiega in modo estremamente esaustivo e convincente Arnaldo Benini (professore emerito di Neurochirurgia e neurologia presso l’Università di Zurigo) nel suo libro Neurobiologia del tempo (Raffaello Cortina editore): «Il tempo non è un attributo dell’Universo che noi percepiamo, ma è in noi. Le neuroscienze cognitive l’hanno localizzato nel cervello e cercano dove siano e come funzionino i meccanismi che lo creano».
Abbiamo chiesto cosa sia il tempo al neurologo capoclinica del Neurocentro dell’Ospedale Regionale di Lugano dottor Leonardo Sacco che lo definisce con una riflessione: «Tutti sanno cos’è il tempo e nessuno riesce a spiegarlo». Egli ci ricorda che i fisici arrivano a negarne l’esistenza, mentre letteratura e neuropsicologia lo descrivono collegandolo parecchio al concetto di memoria. Sia il professor Benini sia il dottor Sacco concordano sulla sua origine: «Il tempo è una produzione del nostro cervello, non una sua percezione, perché non viene percepito con un organo a livello sensoriale (ad esempio come l’olfatto dal sistema olfattivo), ma è il cervello stesso che lo organizza e lo sistematizza in modo più o meno cosciente».
Il nostro interlocutore converge nell’affermazione di Benini secondo il quale il tempo è una dimensione fondamentale della vita degli esseri viventi con sistema nervoso: «Questo ci permette di contestualizzarci in una linea temporale definita, e di organizzare il nostro tempo sistematizzandolo in modo più o meno cosciente». È perciò ovvio chiedersi se un cervello lesionato potrebbe manifestare disturbi del senso del tempo. Secondo il professor Benini è proprio cosi: «Questi disturbi sono una conferma del tempo come meccanismo nervoso che richiede l’integrità delle aree che lo elaborano». Chiediamo lumi al dottor Sacco su questo argomento tanto affascinante quando complicato da snocciolare, che egli introduce con una doverosa puntualizzazione: «L’interpretazione della neurobiologia del tempo di Benini non è universalmente accettata e c’è chi pensa vi sia una zona specifica del cervello che ci dà il senso del tempo». In relazione a ciò, il neurologo afferma però che al momento «sebbene non sia ancora chiaro quale area cerebrale sia deputata al senso del tempo, cosa certa è che il cervello possiede diverse e differenti aree la cui lesione può determinarne una distorsione». Il cervello ha dunque un senso del tempo situato in più zone anatomiche («ad esempio il lobo temporale, il lobo frontale e quello parietale»).
I circuiti dell’emotività fanno sì che una zona del cervello, piuttosto di un’altra, darà la nostra connotazione al tempo stesso: «La prevalenza del lato emotivo comporterà un tempo più soggettivo (ndr: tempo personale), mentre il presente è dato dalle circostanze. Se si tratta del passato entra in gioco la memoria, in quanto tempo e memoria hanno un rapporto stretto e intimamente legato agli aspetti emotivi». Sacco porta ad esempio la rievocazione di un ricordo: «Lo collochiamo temporalmente ed esprimiamo cosa viene prima e dopo. E in relazione all’evento stesso facciamo una narrazione che però spesso può non collimare con ciò che realmente è avvenuto».
Si giunge così a una logica conclusione: «Il nostro cervello interpreta gli avvenimenti e la realtà in modo logico e consequenziale, ma del tutto individuale». Che cosa capita dunque quando un cervello è leso per rapporto al senso del tempo? Ce ne dà un’idea la storia di un paziente, H.M. il cui cervello era privo dei lobi temporali mediali bilaterali e che perciò presentava una totale assenza del senso del tempo: «A lungo oggetto di studi di neuropsicologia, H.M. era impossibilitato a fissare nuovi eventi e non era in grado di riprodurre ricordi del passato. Ci si è chiesto se una persona con queste caratteristiche abbia una propria storia e un’identità, non essendo inserita in un contesto sociale». Si sa che H.M. non ha vissuto la propria malattia in modo consapevole e il dottor Sacco ci conferma che molte delle malattie neurologiche che producono disturbi della percezione del tempo, per il paziente non comportano la coscienza di questo scompenso temporale.
Il motivo è presto detto: «Non essere consapevole della propria malattia è tipico delle patologie che colpiscono il cervello, semplicemente perché il cervello stesso è nel contempo l’organo della malattia e l’organo che produce la coscienza della stessa». È ampio il ventaglio di patologie che può produrre uno stesso danno cerebrale per rapporto all’alterazione del tempo, ma Sacco mette in guardia: «Non vanno confuse quelle che colpiscono il senso dell’orientamento nel tempo (come ad esempio l’Alzheimer) con quelle che producono una distorsione del senso del tempo al punto tale che la persona è convinta che gli avvenimenti si susseguano più velocemente di come succede in realtà. In questo caso la persona avverte una sensazione continua di velocità delle cose che non riesce a frenare e, per fortuna, si tratta di casi molto rari».
Per riassumere: «Oltre a malattie degenerative o eventi traumatici, altre patologie possono alterare il senso del tempo; ad esempio le malattie di tipo infettivo come l’encefalite, l’epilessia (che incide sulla cognitività e che si può curare con adeguate terapie a base di anti-epilettici), i tumori cerebrali la cui prognosi non sempre risulta essere molto favorevole, soprattutto per i glioblastomi».
Ci viene spiegato che l’approccio terapeutico è di tipo eziologico («che cura la causa») oppure psicologico o neuropsicologico («che cura il sintomo»), mentre la prognosi resta individuale, secondo la patologia in questione e il paziente stesso.
È ancora un mistero ciò che ne è del tempo quando il nostro cervello non ne ha più il senso? Non certo secondo Lewis Carrol: «Quanto tempo è per sempre, Bianconiglio?», chiese Alice. «A volte solo un secondo».