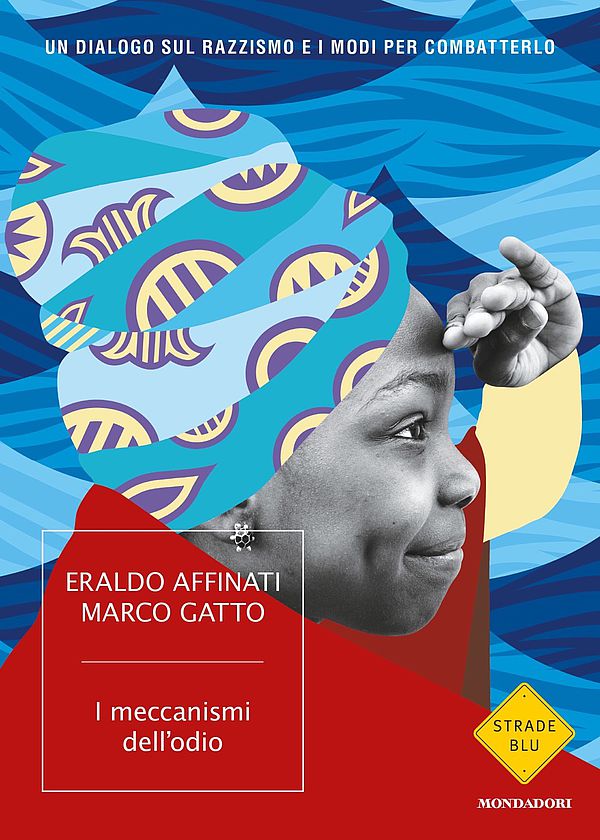Credevamo che la pandemia ci avesse resi più umani, ricordandoci che le nostre vite poggiano su un sostrato di fragilità che bisogna avere il coraggio di affrontare. E invece, oggi più che ieri, razzismo e xenofobia dilagano: il movimento di Black lives matter in America è la risposta a situazioni insostenibili, che non vorremmo vedere. Vale la pena, forse, al posto di (non senza ragioni) stigmatizzare il comportamento di chi non accetta il diverso, cercare di comprenderne le origini. Ottimo, come spunto di riflessione, il volume scritto a quattro mani dallo scrittore Eraldo Affinati e da Marco Gatto intitolato I meccanismi dell’odio (Mondadori). Una lunga intervista, o meglio: un dialogo. Ne abbiamo parlato con Affinati.
Eraldo Affinati, perché odiamo così tanto? Da dove nasce la sensazione di sentirsi continuamente minacciati? E da cosa, in fin dei conti?
Tutto si lega alla nostra insicurezza che può produrre una reazione violenta, talvolta incontrollata. Gli adulti si dimostrano spesso fragili perché le scelte su cosa vogliamo essere o non essere costano e non sempre premiano. I giovani riflettono l’indecisione dei genitori e restano vulnerabili di fronte a modelli di bellezza esteriore. Inoltre la dimensione digitale ci illude di poter lanciare il sasso e nascondere la mano. Così stando le cose, ogni incontro umano diventa rischioso, specie quelli che ci chiamano in causa come persone.
Quando, secondo lei, l’Occidente ha iniziato a mostrare i segni di questa malattia, che si traduce – mi pare – in un’incapacità di condividere la propria intimità con gli altri?
Dopo la sconfitta delle grandi rivoluzioni novecentesche il Vecchio Continente, reclinato su se stesso, ha dovuto fare i conti coi nuovi dannati della terra, rispetto ai quali mostra un atteggiamento giuridico del tutto inadeguato. I codici non bastano a regolare i flussi dell’immigrazione. C’è bisogno di un lavoro umano da svolgere.
Questo libro è un progetto che ha iniziato a prendere piede prima che la pandemia arrivasse alle nostre latitudini. Crede che il Covid abbia cambiato in meglio o in peggio il nostro modo di guardare all’altro?
Il Covid ha esacerbato le disuguaglianze sociali: io e Marco Gatto ci abbiamo ragionato nel primo capitolo. Allo stesso tempo la pandemia ha fatto capire a tutti noi di essere sulla medesima barca: non basta indossare la mascherina se l’altro non fa altrettanto. Gli educatori dovrebbero ripartire proprio da questo sentimento di coralità e anche dal senso di smarrimento provato dagli adolescenti di fronte al vuoto del lockdown.
Nel libro si affronta anche la questione della scuola. Come e in che modo può la scuola agire affinché questo odio, questa ferita narcisistica che ci fa temere l’intimità e il confronto con l’altro e le sue fragilità diventi meno pressante e lasci spazio ad un incontro rigenerante?
La scuola dovrebbe predisporci all’incontro sociale incrementando la qualità della relazione umana. Inoltre sarebbe fondamentale ripristinare le gerarchie di valore nel grande mare del Web. Nella rete di scuole Penny Wirton per l’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, cinquanta postazioni da Messina a Milano con sperimentazioni significative in Ticino, in particolare nel liceo cantonale di Lugano, abbiamo favorito il dialogo fra pari mettendo in relazione adolescenti italofoni con coetanei provenienti da ogni parte del mondo. Secondo noi è questa la strada da percorrere per combattere il razzismo.
Può parlarci anche della sua personale esperienza nel mondo della scuola?
Molti dei libri che ho scritto negli ultimi anni sono il frutto della mia esperienza come docente di lettere, prima negli istituti professionali, poi alla Città dei Ragazzi, comunità educativa alle porte di Roma, dove per la prima volta ho incontrato i minorenni non accompagnati afghani, magrebini, slavi e africani. Alcuni di loro mi hanno guidato nelle terre da cui provenivano. Ho raccontato questi viaggi in La città dei ragazzi (Marocco) e Vita di vita (Gambia). Anche i testi che ho dedicato a Dietrich Bonhoeffer (Un teologo contro Hitler) e Don Lorenzo Milani (L’uomo del futuro e Il sogno di un’altra scuola), oltre all’Elogio del ripetente, vanno in tale direzione.
Che ruolo giocano gli intellettuali in questo senso? E la letteratura, che viene spesso citata nel testo come ancora di salvezza, isola di umanità ma anche bussola per non perdersi?
Gli intellettuali in questo momento ci sembrano essere sotto scacco: se partecipano al battage mediatico rischiano di trasformarsi in caricature di se stessi; se si astengono tornano nella vituperata turris eburnea da cui provengono. A noi sembra decisivo praticare un’esperienza concreta per dare legittimità alle parole che pronunciamo e scriviamo. La vera letteratura non può prescindere dalla vita, mantenendo a tutti i costi il rigore stilistico.
Il dialogo fra lei e Marco Gatto affronta anche il tema degli umili, di coloro che passano silenziosi ma che forse determinano gli accadimenti storici più di chi si erge su un piedistallo. Cosa possono insegnare a questo Occidente malato di narcisismo?
Mi fa piacere che lei abbia colto questo aspetto del nostro dialogo a cui teniamo molto. In effetti le persone semplici che fanno bene il loro lavoro e magari restano al di fuori dal cono di luce dei riflettori rappresentano la parte migliore di un tessuto sociale che a volte sembra lacerato. Per diventare donne e uomini nuovi dobbiamo assumere la responsabilità dei contesti in cui operiamo. Anche imparando a spendere i nostri saperi, senza tenerli chiusi in cassaforte.