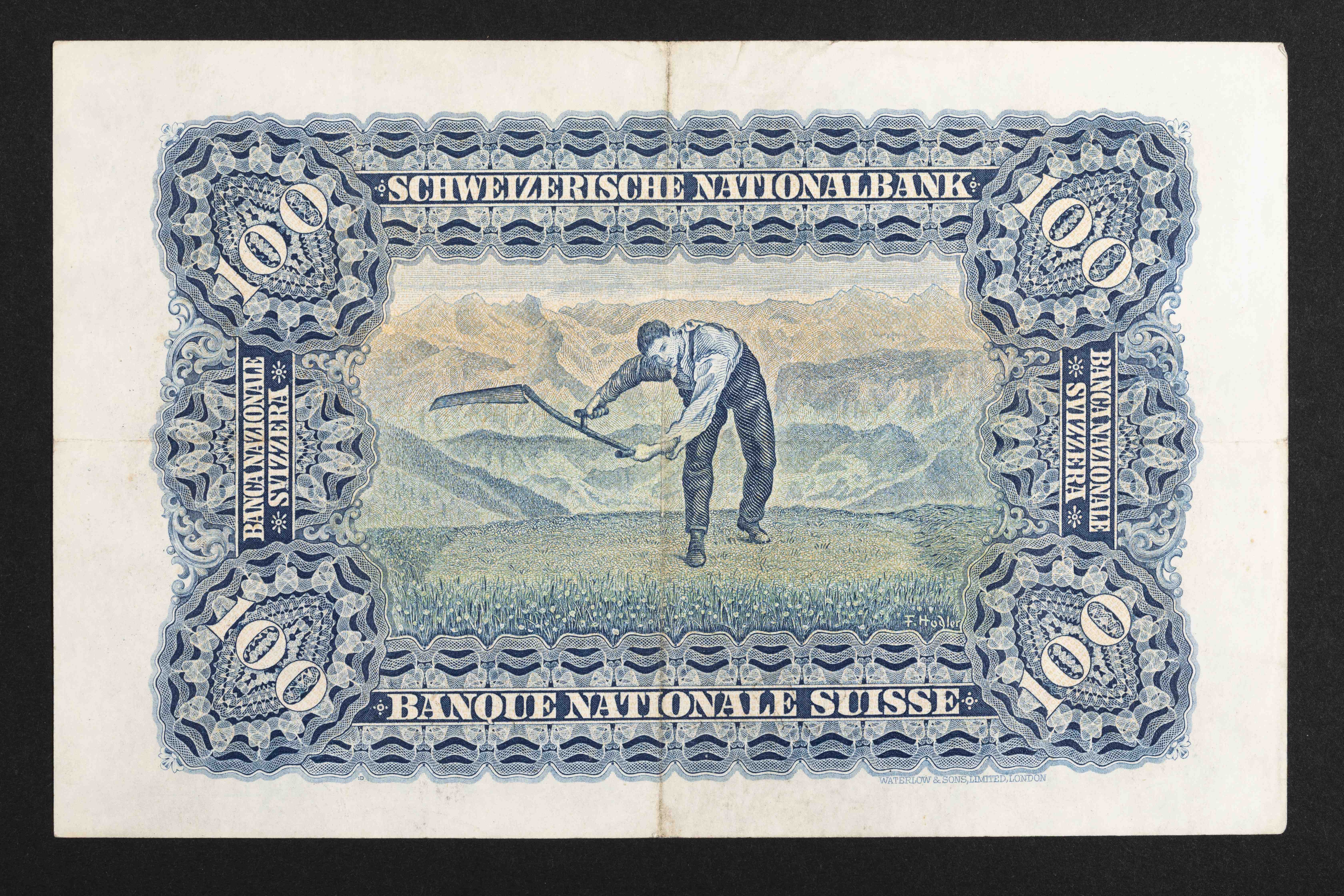Fra gli argomenti economici maggiormente oggetto di accesa discussione vi è la tassazione della sostanza individuale. Spesso, infatti, il dibattito tende a suddividersi fra sostenitori di un’imposizione (ancora più elevata) di essa ‒ questi si propongono attenti a tematiche come eguaglianza ed equità sociale ‒ e detrattori (questi ultimi sono considerati benestanti e, stando al pensiero generalizzato, chiamati in causa). In realtà, indipendentemente da condizione economica individuale o schieramenti politici di preferenza, si dovrebbe essere unanimemente poco favorevoli ad ogni forma di tassazione, che disincentivi la trasmissione intergenerazionale di benessere e (ancor più direttamente) l’accumulazione di capitale. Analizziamo quegli elementi di manifesta criticità da attribuirsi all’imposizione della sostanza patrimoniale:
1. Doppia imposizione: se tale concetto è associato alla tassazione dei redditi (che sono «flussi» - flow), quasi mai lo è all’ambito patrimoniale (che è, invece, uno stock). Se si suppone che il bene (im)mobile sia stato acquistato con redditi già imposti, doverne denunciare il possesso ed assoggettarli quali sostanza patrimoniale rappresenta un vero e proprio «doppio onere». In sintesi, il legislatore sottopone due volte a tassazione lo stesso bene, cioè dapprima sotto forma di redditi cumulati necessari al suo acquisto e successivamente in qualità di cespite patrimoniale. Oltre a costituire un approccio sbagliato, così facendo si discrimina persino fra quanto sia da considerarsi «sostanza». In altri termini, per quale motivo il decisore pubblico ritiene di dovere imporre a tassazione immobili, conti depositi, valori numismatici ecc. e non ‒ per assurdo ‒ bellezza fisica, talento, titoli nobiliari o altre caratteristiche individuali, che possano essere potenzialmente fonti di migliori opportunità lavorative, remunerazioni o altro ancora? E, naturalmente, considerare come sostanza il possesso immobiliare e guardare ad esso come semplice asset (e non come costo o garante di un territorio curato e portatore di domanda di manodopera locale) è miope;
2. Disincentivo al risparmio: tassare la sostanza scoraggia l’accumulazione di beni «di padre in figlio» ed è un modo sbagliato di dovere ripartire ogni volta «da zero»: nel contempo, il patrimonio (piccolo o grande che sia) rappresenta un’efficace diversificazione del proprio modo di detenere i risparmi (mettendo non soltanto l’individuo, ma anche la Nazione nel suo complesso a migliore riparo dinanzi a potenziali crisi economiche). In altri termini, se l’Italia ed i suoi abitanti non avessero accumulato ricchezza immobiliare negli Anni Sessanta e Settanta (in parte, magari, rivenduta a scopo di monetizzazione o diverso investimento) godrebbero senz’altro di peggiore salute: se a ciò si aggiunge che le «fiammate» in termini di rialzo dei prezzi negli anni Ottanta hanno fatto sì che i prezzi/valori immobiliari venissero sottoposti ad un effetto moltiplicativo senza precedenti, ecco accumulata una ricchezza come nessun economista potrebbe essersi immaginato e/o avere suggerito. Agire, invece, in modo tale che la popolazione resti vincolata al reddito − quest’ultimo legato a lavori sempre più precari − è poco lungimirante, in quanto crea situazioni di dipendenza dalla regolarità dei flussi reddituali in entrata;
3. L’indissolubile binomio con le società ricche: i legislatori che per motivi prettamente fiscali o di consolidamento dei bilanci pubblici decidano di tassare anche la sostanza patrimoniale individuale, agiscono in aperto conflitto con la principale caratteristica delle loro economie, cioè la ricchezza. In altri termini, ci si deve «mettere il cuore in pace» che società prospere implichino aumento di reddito e patrimonio individuale: ogni forma di disincentivo all’accumulazione di uno di essi è, pertanto, incoerente con la condizione economica di tali Paesi;
4. La questione dell’equità: a «schermo» dell’imposizione del patrimonio individuale si avanza sovente la necessità di garantire equità distributiva tra fasce di contribuenti. Poiché è difficile immaginare che quelle più deboli vogliano rimanere a lungo tali, la tassazione delle une (cioè quelle più ricche) a vantaggio delle altre (cioè quelle più povere) mai ha davvero arricchito queste ultime. Lo stesso concetto di «equità» dovrebbe − se interpretato in mera chiave redistributiva − essere messo in forte dubbio: esso, infatti, sarebbe nella logica delle cose piuttosto da interpretare come «possibilità», cioè «capacità (dietro impegno da parte del soggetto interessato) ad avere accesso a tutte le posizioni lavorative possibili» così da guadagnare di più ed accumulare quel benessere fino ad allora «negato». Un simile meccanismo corrisponde, nient’altro, che a quello di «creazione di reddito/ricchezza», mentre quanto spesso operato dalla mano pubblica è un mero «trasferimento di reddito/ricchezza» dove quest’ultimo si limita a (tar)tassare gli uni per aiutare gli altri: queste fasce di popolazione vengono rese, troppo a lungo, dipendenti da tali sussidi. È, invece, la sola «creazione di reddito» resa accessibile a tutta la popolazione ad essere una vera e propria casistica win-win, cioè benefica per tutti oltre che per lo stesso decisore pubblico in quanto il gettito fiscale (da un PIL in crescita) aumenterebbe in modo trasversale a tutta la società. La monotonia gestionale pubblica induce, invece, troppo spesso a prevedere la propria azione «a senso unico», cioè «trasferendo» come un travaso di un liquido da un bicchiere ad un altro il reddito (con inevitabili perdite, alias sprechi, che rendono un meccanismo già in partenza a somma nulla persino negativa).
Tassare la sostanza è per tutti i motivi sopra citati sconsigliabile e ciò non certo in un’ottica neoliberale quanto (solo apparentemente, incredibile a dirsi) «sociale», cioè di «società nel suo insieme». Che alcune multinazionali − guardando alle persone giuridiche − esplorino tutta una serie di vie secondarie per versare meno imposte può essere riprovevole, ma da un’angolatura economica si dovrebbe leggere tale fenomeno in chiave opposta: per quale motivo noi consumatori operiamo lunghe ricerche per risparmiare nell’acquisto di un prodotto (e ciò è considerato consigliabile per una migliore gestione del proprio bilancio), mentre le aziende non possono sfruttare condizioni impositive favorevoli presso certi Paesi?
L’odierna rigidità d’approccio nei confronti delle imposte rispetto all’incentivo alla concorrenza commerciale non si giustifica. Ma questa è un’altra storia ancora. Rimane, comunque, che non si debba mai penalizzare chi abbia di più, quanto mettere chi abbia di meno nelle condizioni per avere durevolmente di più.