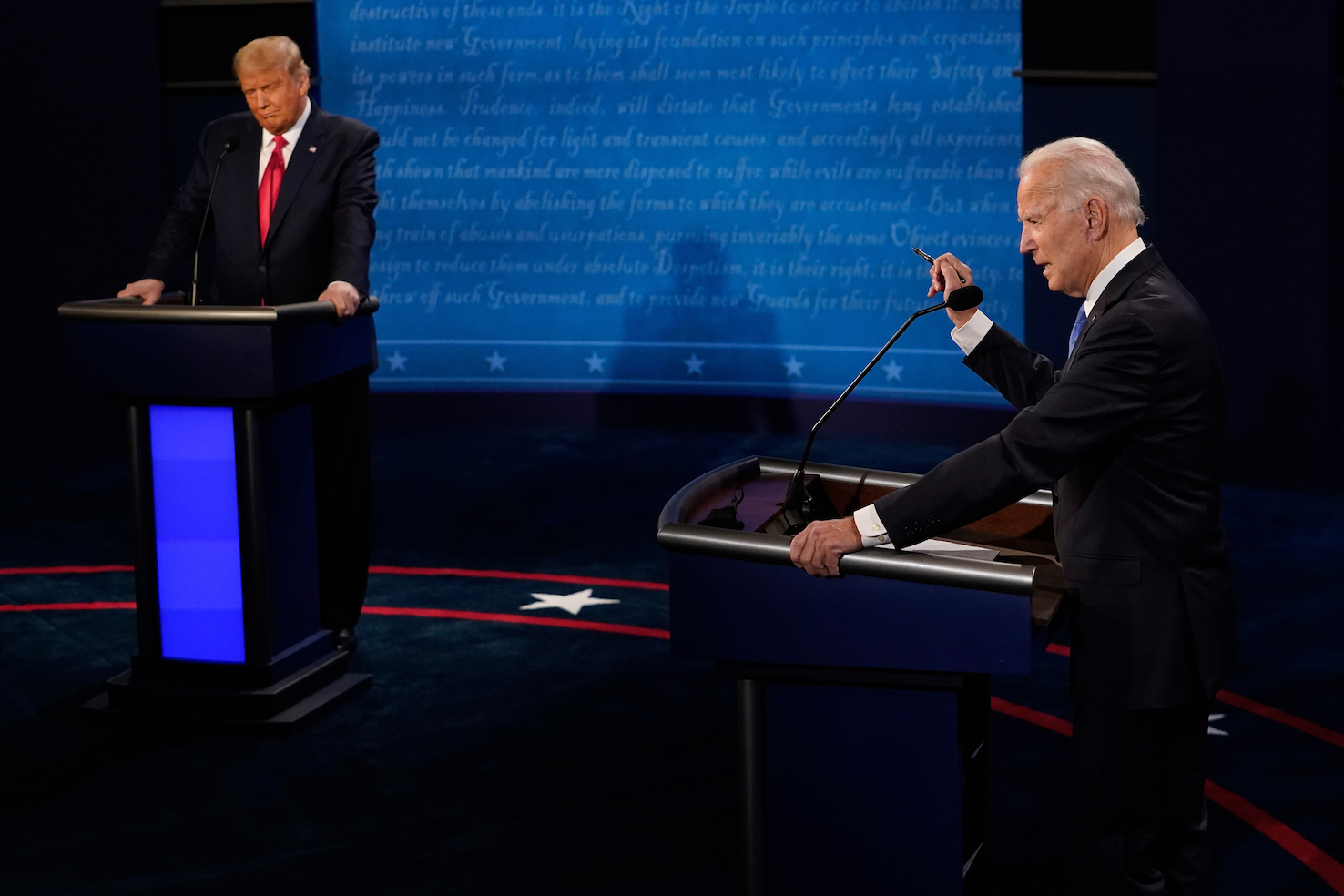È stata una campagna elettorale unica nella storia, dopo un quadrienno già eccezionale. Donald Trump è stato percepito come il presidente di uno «strappo di civiltà». Una nazione già polarizzata all’estremo molto prima di lui, ha vissuto la corsa alla Casa Bianca del 2020 come una battaglia esistenziale, per l’anima dell’America. A sinistra molti hanno descritto una rielezione di Trump come l’anticamera di una svolta autoritaria. A destra molti hanno sostenuto – o tollerato – questo presidente come l’ultimo baluardo per difendere l’identità storica di un Paese a maggioranza (relativa) bianco, anglosassone, cristiano. Ma Trump ha saputo anche spostare alcuni terreni di battaglia, ridefinendo dove sta «il centro» del Paese: per esempio dopo di lui difficilmente l’America tornerà ad abbracciare il liberismo nei trattati commerciali, o una visione bonaria dell’ascesa della Cina.
Il 2020 ha chiuso l’inaudito quadriennio di Trump con una campagna disseminata di sorprese, una più clamorosa o devastante dell’altra. L’anno si era aperto all’insegna dell’impeachment – solo il terzo nella storia americana – eppure quell’evento sembra già relegato in un passato remoto, al punto che nessuno gli attribuisce un impatto significativo sul voto. Poi c’è stato il Coronavirus o «China virus», come lo chiama il presidente. A seguire, per effetto dei lockdown, abbiamo avuto la più grave crisi economica a memoria dei viventi, forse seconda solo alla Grande Depressione degli anni Trenta. A maggio, l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente bianco a Minneapolis ha scatenato un’ondata di proteste contro il razzismo e contro le forze dell’ordine, che per almeno due mesi hanno conteso al Coronavirus l’attenzione nazionale; ivi compresi degli episodi di violenza, razzie, saccheggi, che hanno innescato una controreazione conservatrice in difesa dell’ordine pubblico.
Poi ancora: a settembre, la morte della giudice femminista e progressista Ruth Bader Ginsburg ha reso vacante un seggio alla Corte suprema, consentendo a Trump la sua terza nomina per blindare una maggioranza conservatrice nel massimo tribunale degli Stati Uniti, con possibili conseguenze sull’agenda legislativa di chi gli succederà. Infine il Coronavirus ha contagiato il presidente stesso, in quella che poteva essere una sorta di nemesi, ed invece si è trasformata in una guarigione-convalescenza così veloce da rilanciare la sua narrazione: dal Covid ci si salva, dalla depressione economica no, guai a infierire con dei lockdown che creano miseria e sofferenza.
Infine la pandemia ha stravolto lo stesso processo elettorale: una stragrande maggioranza di cittadini avevano già votato prima della data canonica del 3 novembre. Su questo Trump ha innestato un elemento destabilizzante: le sue accuse su presunti brogli nel voto per corrispondenza, hanno alimentato il timore che la corsa alla Casa Bianca non finisca affatto il 3 novembre, bensì che sia destinata a trascinarsi ben oltre in un’interminabile e pericolosa spirale di contestazioni, ricorsi. Magari con la Corte suprema come arbitro finale.
L’attenzione degli ultimi giorni si è concentrata sui soliti sospetti: quegli elettori fluttuanti negli Stati contesi, che furono all’origine dello shock del 2016. Geograficamente sono soprattutto nel Midwest; socialmente sono per lo più operai; fanno parte di «un’America dei penultimi», che si è sentita tradita e abbandonata dalla sinistra politically correct interessata solo a raddrizzare i torti subiti dalle minoranze di colore o dalle minoranze sessuali, a difendere l’orso bianco ma non il siderurgico bianco. «Rust Belt», cintura della ruggine: dove c’era il cuore del capitalismo industriale americano e oggi c’è un paesaggio in declino, fabbriche chiuse, impoverimento, tossicodipendenze che colpiscono ex operai bianchi di mezza età. La sfida per la Casa Bianca si gioca almeno in parte lì, come nel 2016.
Altri Stati-chiave, o terreni di battaglia contesi fra i due candidati, sono la Florida, l’Arizona, la North Carolina, con caratteri demografici e culturali diversi.
Ma non c’è un percorso realistico verso la rielezione di Donald Trump, che non passi per quattro Stati della «Rust Belt»: la Pennsylvania che vale 20 voti nel collegio elettorale, l’Ohio con 18 voti, il Michigan (16) e il Wisconsin (10). Quattro anni fa Hillary Clinton veniva data favorita nei sondaggi, con margini di sicurezza: 12 punti in più nel Michigan, 7 in Pennsylvania e Wisconsin. Tutti e quattro gli Stati della «Rust Belt» finirono nella casella di Trump. Che cosa andò storto per i democratici? Hanno imparato la lezione? La Clinton fu accusata di aver dato per scontato che il Midwest avrebbe votato democratico; fece pochissime apparizioni in campagna elettorale da quelle parti (neanche una nel Wisconsin). Tra gli elettori senza titolo di studio universitario – dove si concentra la classe operaia – il consenso era stato in favore di Barack Obama nel 2012 con 12 punti di margine, si spostò su Trump con 7 punti.
Spostamenti enormi, poco frequenti nella storia elettorale. Spiegano perché quest’anno Biden ha preso delle posizioni moderate – scontentando l’ala radicale e giovanile della sinistra – sul fracking, tecnologia di estrazione di gas e petrolio: non vuole regalare di nuovo a Trump i voti di chi lavora nelle industrie energetiche o collegate, un business ancora importante nell’area di Pittsburgh.
Lo stesso problema si pone in Ohio, nei monti Appalachi: lì vive una classe operaia bianca impoverita, quella che le élite chiamano col termine spregiativo di white trash (spazzatura bianca) o rednecks (colli rossi), e per la quale Hillary coniò un suo appellativo, «i deplorevoli». La Clinton quattro anni fa perse l’Ohio in una débacle memorabile, appena il 43% dei voti, il peggior risultato del partito democratico dai tempi del presidente repubblicano Ronald Reagan (il quale aveva una forte capacità di attrazione verso la classe operaia).
Il Michigan, cuore dell’industria automobilistica americana, diede una vittoria risicata a Trump: appena diecimila voti su quasi cinque milioni. Nel mondo dell’industria automobilistica fece breccia l’attacco contro i trattati di libero scambio, la promessa di dazi contro le importazioni cinesi. Il presidente è tornato alla carica: si presenta come il vero difensore dei posti di lavoro minacciati dalla concorrenza sleale della Cina; accusa Biden di essere sempre stato favorevole alle liberalizzazioni commerciali. Il suo rivale però è meno vulnerabile di Hillary. Biden è riuscito a costruirsi un’immagine da uomo della middle class, di origini popolari.
Lontano dalla «Rust Belt», il più importante fra gli Stati contesi è la Florida. Vale 29 voti elettorali, quest’anno ha raggiunto al terzo posto per importanza lo Stato di New York (dietro California e Texas)… anche grazie ai newyorchesi «profughi fiscali» come Trump che a Mar-a-Lago ha stabilito la sua seconda Casa Bianca. Il peso di ogni Stato in voti del collegio elettorale viene aggiustato in base alla popolazione e quella della Florida continua a crescere. Aveva 15 milioni di abitanti nel 2000 quando decise un’altra elezione (Bush-Gore), oggi ne ha 22 milioni. Ad aumentare il numero di residenti hanno contribuito flussi di pensionati del Midwest in cerca di un clima mite, ricchi della East Coast in cerca di un paradiso fiscale (la Florida non ha addizionale Irpef), ispanici.
Il continuo rimescolamento demografico rende la Florida volatile, imprevedibile. Il voto ispanico, per esempio, non è un blocco. I cubani e venezuelani sono i più a destra in odio alle dittature socialiste dei loro paesi d’origine; i portoricani votano a maggioranza democratico. Altre categorie come gli ex immigrati dal Messico o dal Centramerica possono seguire le stesse linee di demarcazione del voto bianco: più a sinistra i giovani; a destra quei redditi medio-alti che temono un aumento della pressione fiscale con Biden alla Casa Bianca.
Nella dinamica delle ultime giornate di campagna ha fatto irruzione un dato positivo sull’economia: la ripresa del Pil è così fantastica (+33% su base annua), che non esistono precedenti dalla Seconda guerra mondiale.
Per Trump è stato il canto del cigno, l’ultima nota positiva prima che gli elettori lo mandino a casa? Oppure riuscirà a capitalizzare la buona notizia, con una spettacolare rimonta dell’ultima ora? La risposta dipende da quanti americani «sentono» questa ripresa come un fenomeno reale: sul loro posto di lavoro, il loro reddito, le loro aspettative per il 2021. +7,4% il Pil del terzo trimestre (rispetto al secondo), che equivale a +33% se proiettato su base annua, è un rimbalzo vigoroso. In tempo utile per finire nei comizi finali del presidente: la conferma di quanto lui va dicendo da tempo e cioè che il peggio è passato.
Trump aggiunge che è grazie alla sua capacità di governo, se l’impatto del Coronavirus è stato relativamente breve; accusa il suo rivale Joe Biden di voler prolungare la sofferenza con un accanimento sui lockdown a oltranza. Questo dato va inquadrato nella giusta prospettiva. L’enorme +33% annuo è in parte un’illusione ottica legata alla caduta del trimestre precedente. Va letto in sequenza con quello del secondo trimestre, in cui il Pil era sceso del 9% rispetto al primo e del 31,4% su base annua. Alla fine, il rimbalzo registrato dal primo luglio al 30 settembre lascia l’economia americana del 3,5% più povera rispetto alla fine del 2019. Questa rimane una pesante recessione.
Un altro indicatore, relativo al mercato del lavoro, dice che sui 22 milioni di posti di lavoro eliminati dall’inizio di questa crisi, ne sono già stati recuperati la metà. È il classico bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno: la ripresa c’è, ma per 11 milioni di disoccupati è un evento ancora del tutto virtuale. Il messaggio del presidente è chiaro: la mia politica economica aveva generato una crescita eccezionale, raggiungendo il pieno impiego; poi è arrivato dalla Cina un virus che ha sfasciato tutto; ma l’economia americana è così sana che stiamo risollevandoci a gran velocità; guai se eleggete un democratico che ucciderà la ripresa a colpi di nuove tasse. Tuttora questo è l’unico terreno sul quale lui gode di un leggero vantaggio nei sondaggi. Inoltre una maggioranza relativa considera di «stare meglio oggi rispetto a quattro anni fa.