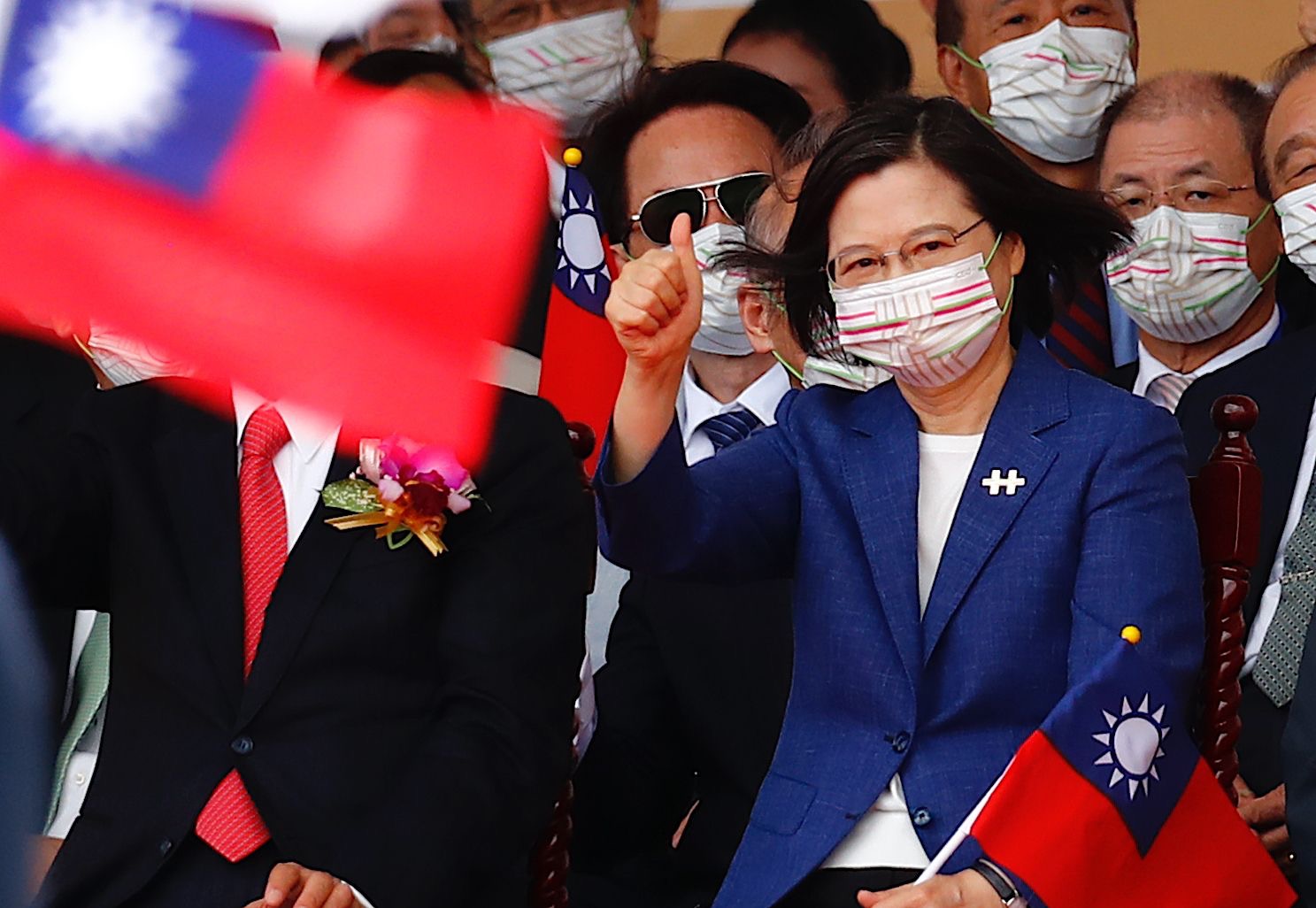La sua superficie è 266 volte più ridotta e la sua popolazione un sessantesimo appena, eppure la piccola Repubblica di Cina, forte di appoggi internazionali preziosi quanto informali, tiene testa da oltre settant’anni alla gigantesca Repubblica popolare cinese. Non solo. Mentre da una parte Pechino considera terra irredenta e parte integrante del suo territorio l’isola di Taiwan, dall’altra lo Stato cinese concorrente che prende il nome da quest’isola non è da meno: nella sua costituzione rivendica infatti la sovranità sull’intera Cina e perfino sulla Mongolia. Non a caso considera Taipei una capitale provvisoria, quella vera è Nanchino, la bellissima città che fu a lungo il centro del potere nell’impero millenario, ma che presenta lo scomodo inconveniente di trovarsi in piena Cina continentale, comunista e nemica.
La storia dell’isola, che nel tratto più stretto di quel braccio di mare dista 150 chilometri dalla terraferma, ha radici lontane. È sempre stata oggetto di disputa fra cinesi e giapponesi. Quando nel Cinquecento la raggiunsero i navigatori portoghesi la trovarono così ricca di affascinanti vedute da chiamarla ilha formosa, isola bella, e proprio con quel nome, Formosa, è entrata nel vocabolario geografico dell’Occidente. La Repubblica di Cina comprende non soltanto Formosa ma anche alcuni arcipelaghi nel Mar cinese meridionale, piccole isole di chiara importanza strategica. Oggi su quelle coste sfrecciano a bassa quota i cacciabombardieri inviati da Pechino in missione pesantemente intimidatoria: Golia sfida il minuscolo Davide. Certo, se non fosse per la tutela americana, ribadita una volta ancora settimana scorsa dal presidente Joe Biden, da tempo ne avrebbe fatto un sol boccone.
E pensare che furono proprio gli Stati uniti, subito dopo avere sconfitto a suon di atomiche l’impero giapponese che occupava quelle terre fin dall’ultimo scorcio dell’Ottocento, a restituirle alla Cina. Correva l’anno 1945, la diplomazia di Washington ancora non poteva sapere che di lì a poco la lunga guerra civile fra nazionalisti e comunisti sarebbe entrata in una nuova fase destinata quattro anni più tardi a culminare nella vittoria di Mao Ze-dong e nella nascita della Repubblica popolare. Né poteva sapere che il Kuomintang nazionalista di Chiang Kai-shek avrebbe fatto base a Formosa meditando orgogliosi propositi di riconquista e dando vita a una creatura politica revanscista, oggi popolata da 26 milioni di abitanti. Né infine poteva sapere che di lì a poco la guerra di Corea, con il massiccio intervento della Cina comunista, avrebbe sconvolto gli equilibri strategici nell’area.
Cominciava in quel 1949 la contrapposizione fra le due Cine separate dalla geografia e dall’ideologia. Vista in una prospettiva storica, la riunificazione sembra l’inevitabile sbocco di una situazione innaturale, ma certo non appare sull’orizzonte dell’attualità. Anche perché i due Paesi hanno percorso strade molto diverse. La Repubblica maoista attraversata da aspri sussulti ha finito con l’affiancare al ruolo egemonico del partito comunista la scelta di una «economia socialista di mercato», fino a diventare la superpotenza non soltanto militare ma anche commerciale che allarma il mondo intero. Taiwan è stata protagonista di uno spettacolare sviluppo all’occidentale, inizialmente favorito dal fatto che molti nazionalisti sfuggiti al vittorioso potere comunista avevano portato con sé importanti risorse con cui hanno finanziato un’impetuosa crescita economica. Oggi nell’immensa Cina di Xi Jinping il prodotto interno lordo pro-capite a parità di potere d’acquisto misura poco più di 19mila dollari l’anno, quello di Taiwan supera i 59mila: più di tre volte tanto.
È su questa realtà economica e sociale che Pechino, spalleggiata dalla Russia e dalla Corea del nord, vorrebbe realizzare la sua politica irredentista. A volte le due Cine sono state sull’orlo della guerra, e anche oltre. Il Governo comunista non ha mai abbandonato il proposito di completare con le armi, vista la resistenza di Taipei alla negoziazione, il percorso avviato fin dai primi anni del dopoguerra, quando aveva contro il mondo intero. Infatti a rappresentare la Cina nella comunità internazionale, a cominciare dall’Organizzazione delle nazioni unite, non era il colosso continentale ma il piccolo e informale Stato isolano che si voleva erede della Repubblica post-imperiale di Sun Yat-sen. Fu proprio negli anni in cui Taiwan impersonava la Cina di fronte al mondo che Quemoy, un’isoletta costiera che fungeva da avamposto taiwanese a un paio di chilometri dalla terraferma, si trovò per due volte, nel 1954 e nel 1958, al centro di un confronto militare, in pratica un ritorno di fiamma della guerra civile. Le due crisi si conclusero abbastanza rapidamente anche perché Washington non aveva escluso, dopo la partecipazione della Cina comunista alla guerra di Corea, il ricorso alle armi atomiche.
Rimaneva il paradosso della rappresentanza: il seggio all’Onu, per non parlare di quello permanente con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza, non poteva che toccare a Pechino. E così fu a partire dal 1971, quando l’assemblea generale approvò la risoluzione 2758 che smentendo un atto precedente dichiarò il Governo della Repubblica popolare unico legittimo rappresentante della Cina. E poiché i due contendenti accettavano di allacciare rapporti diplomatici soltanto con i Paesi che non riconoscevano l’«altra» Cina, la comunità internazionale quasi al completo, sospinta dalle ragioni della Realpolitik, aprì le sue ambasciate a Pechino lasciando a Taipei semplici uffici di rappresentanza. Oggi sono soltanto una quindicina gli Stati che intrattengono relazioni formali con Taiwan: piccoli Paesi del Centro America e dell’Oceania, ma anche una potenza diplomatica come il Vaticano, che Xi Jinping vedrebbe volentieri in un ruolo di mediazione fra le due Cine.
Tutto questo non significa, del resto, che la Repubblica taiwanese abbia perduto la protezione di cui godeva quando rappresentava l’intero gigante cinese. Gli Stati uniti, che pure riconoscono la Cina popolare, non hanno cessato di esercitare, mostrando i muscoli con le loro navi da guerra irte di missili, una funzione di garanzia dello status quo. Per venire ai nostri giorni, «giù le mani da Taiwan» è il messaggio implicito nel varo dell’Aukus (Australia, United Kingdom, United States), un patto di sicurezza con cui le tre potenze fanno fronte comune contro ogni rischio di destabilizzazione nell’area indo-pacifica. Un’iniziativa che di fronte al rinnovato protagonismo di Pechino sulla scena mondiale ha assunto una evidente connotazione anti-cinese. Qui siamo di fronte a un nuovo paradosso non privo di illuminanti precedenti storici: proprio l’attivismo e i toni minacciosi della Repubblica popolare, provocando la nascita di un agguerrito fronte di resistenza, sono diventati per Taiwan una sorta di assicurazione sulla vita. Per ora, con le flotte dell’Aukus che pattugliano quei mari turbolenti, nell’ilha formosa si possono dormire sonni un pochino più tranquilli.